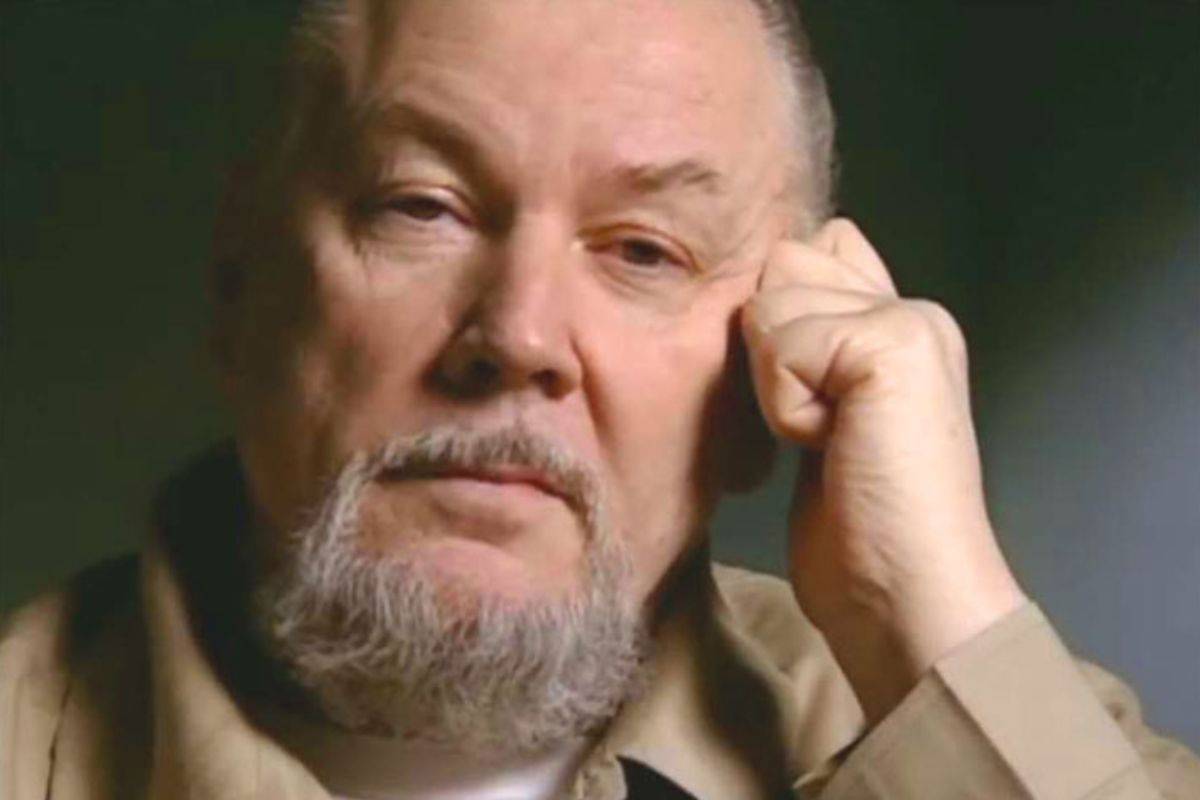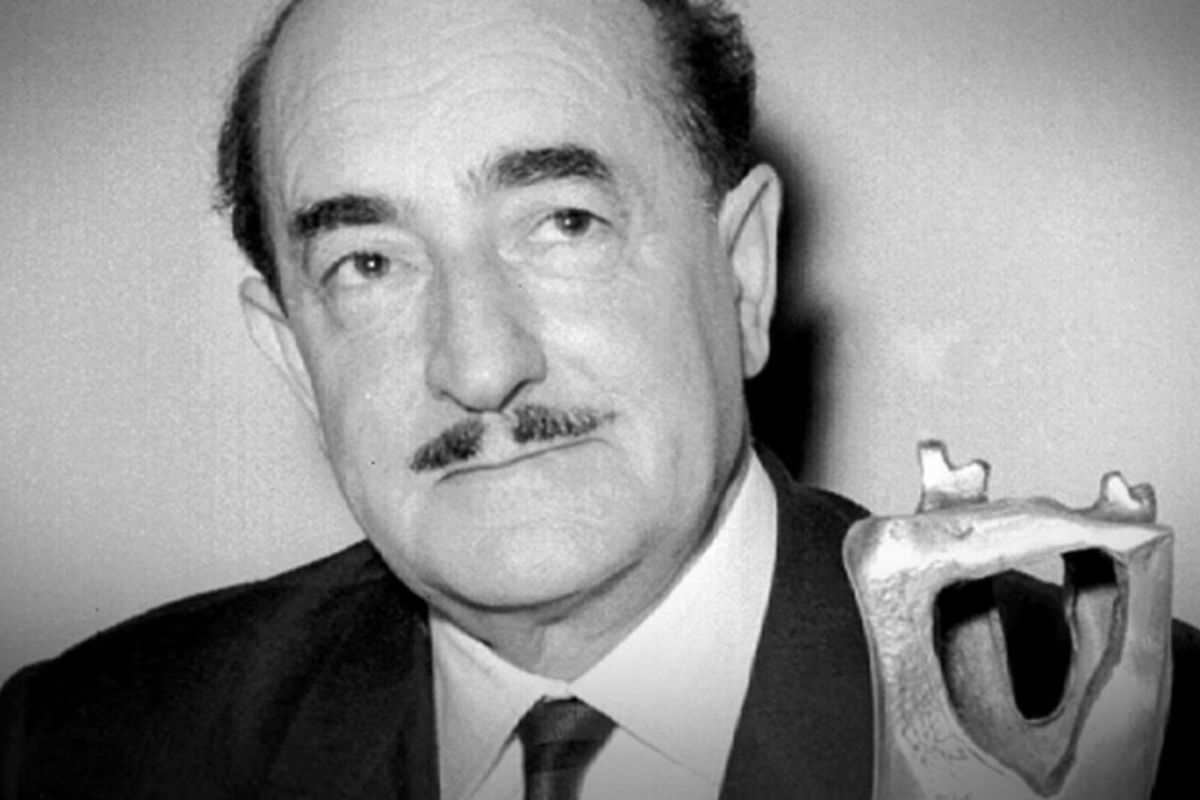L’antica città etrusca di Spina riaffiora dalle Valli di Comacchio: scopri tutto quello che c’è da conoscere.
La storia di Spina è una storia di ritorni. Per secoli il suo nome ha attraversato miti e fonti antiche, sospeso tra realtà e leggenda, fino a quando un ritrovamento inatteso nelle Valli di Comacchio, agli inizi del Novecento, ha riportato alla luce una delle città più enigmatiche dell’Etruria padana. Da allora, Spina è divenuta un laboratorio permanente di ricerca, un luogo in cui terra e acqua conservano testimonianze capaci di riscrivere il ruolo degli Etruschi nell’Adriatico.
Spina, la riscoperta di una città dimenticata
Le prime certezze sulla presenza di Spina emersero negli anni Venti, quando gli scavi nella necropoli di Valle Trebba misero fine all’alone leggendario che avvolgeva questa città. Quelle campagne archeologiche, condotte in un territorio dominato da paludi e acque mutevoli, rivelarono migliaia di sepolture e un patrimonio materiale di sorprendente ricchezza. Fu l’inizio di una nuova stagione di studi che riconsegnò Spina alla storia, dimostrando come il suo ruolo nei rapporti tra mondo etrusco e mondo greco fosse stato più rilevante di quanto immaginato.
L’abbondanza di ceramica attica rinvenuta nelle tombe, prodotta nelle botteghe ateniesi del V secolo a.C., mostrava con chiarezza l’intensità dei legami commerciali e culturali che univano questa città all’Egeo. Si trattava di un flusso costante di manufatti pregiati che, passando dal delta del Po, raggiungevano l’entroterra padano. Dando forma a una rete di scambi in cui Spina agiva come cerniera tra Mediterraneo e Europa continentale. In quel paesaggio sospeso, le testimonianze archeologiche dialogavano con le fonti antiche, che descrivevano la città come una sorta di avamposto sull’estremo limite dell’Occidente conosciuto.

Spina, la riscoperta di una città dimenticata – misteriditalia.it – credit Instagram
Spina appariva così non solo come un porto strategico, ma come un crocevia simbolico, un luogo in cui i Greci immaginavano approdassero miti e rotte. Le narrazioni legate a Fetonte, alle Eliadi, a Dedalo e a Eracle trovavano in questo delta un territorio adatto a collocare l’incontro tra natura, leggenda e confini geografici. La sua posizione, immersa in un sistema di acque e canali, evocava infatti un paesaggio liminare, prossimi agli estremi del mondo allora esplorato.
Gli studi successivi hanno contribuito a restituire un quadro sempre più articolato della città. Grazie alle ricerche condotte da archeologi, topografi e studiosi di ceramica, oggi Spina è riconosciuta come uno dei centri più dinamici dell’Etruria padana. Capace di gestire scambi a lunga distanza e di ospitare una comunità attiva, abituata a dialogare con culture diverse. Le necropoli, con le loro sepolture ricche di oggetti importati, rappresentano un archivio fondamentale per comprendere identità. Pratiche sociali e trasformazioni economiche del tempo.
Per molti versi, lo studio di Spina continua a essere una sfida. Le condizioni ambientali che per secoli l’hanno preservata rendono complesso il lavoro sul campo. Mentre l’estensione del sito impone un approccio multidisciplinare che coinvolge archeologia, geomorfologia e analisi dei materiali. Questo intreccio di competenze permette di ricostruire, passo dopo passo, l’aspetto di una città che viveva sospesa tra terra e acqua. Non molto diversa da quella che oggi definiremmo una laguna.
 Spina, la Venezia etrusca: la città fantasma che riappare dopo duemila anni - misteriditalia.it - credit Intsgram
Spina, la Venezia etrusca: la città fantasma che riappare dopo duemila anni - misteriditalia.it - credit Intsgram