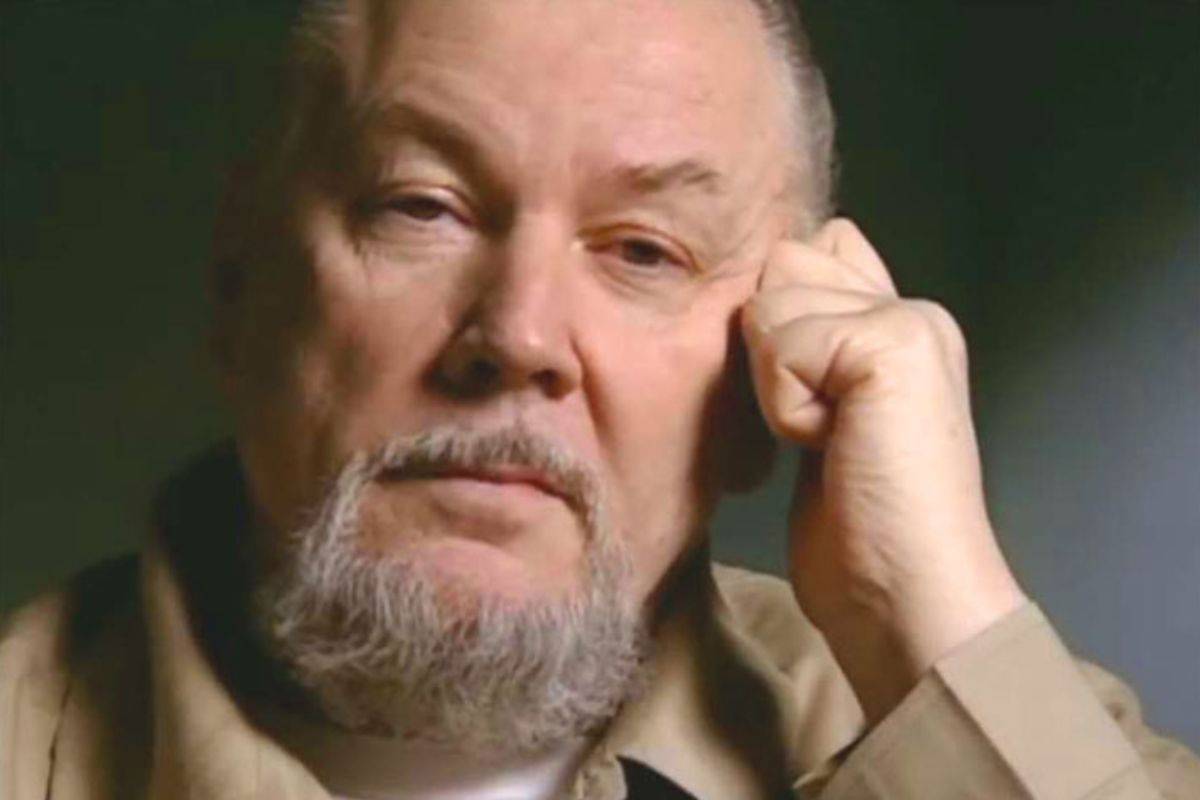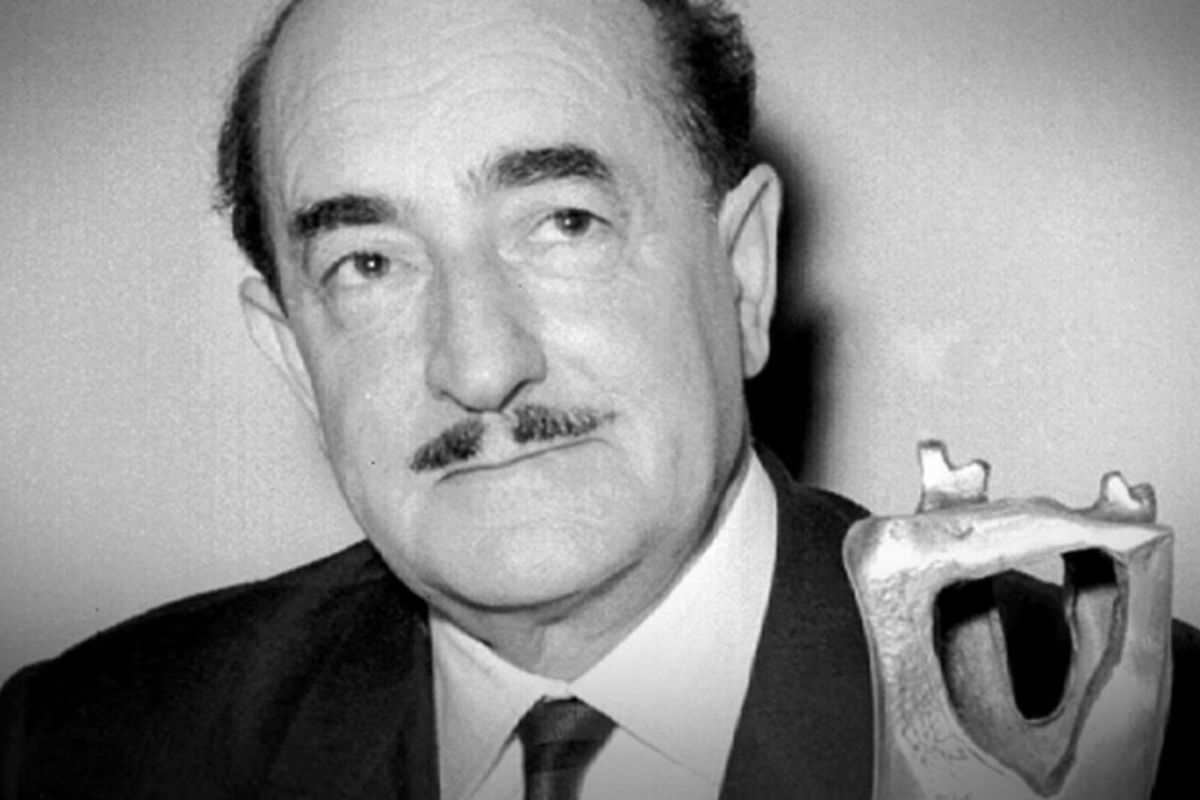La storia della Sala d’Ambra, capolavoro artistico trafugato dai nazisti e scomparso nel 1944, tra ricostruzioni, ricerche e ipotesi irrisolte.
Ci sono opere che sembrano destinate a sfuggire al tempo, altre che invece si perdono in un punto esatto della storia, lasciando dietro di sé un solco di domande. La Sala d’Ambra appartiene a entrambe le categorie: capolavoro del Settecento, simbolo del prestigio imperiale russo e, allo stesso tempo, uno dei misteri irrisolti più affascinanti del Novecento. Trafugata dai nazisti durante la Seconda guerra mondiale e scomparsa nel caos dei bombardamenti, la sala continua a suscitare ipotesi, ricerche e leggende.
Sala d’Ambra, un capolavoro nato tra diplomazia e meraviglia
Le origini della Sala d’Ambra risalgono al 1701, quando Federico I di Prussia commissionò la costruzione di una stanza interamente rivestita di questo materiale prezioso. L’ambra, allora più costosa dell’oro, fu modellata in centomila pezzi che decoravano pareti, cornici e mobili, trasformando quei trentasei metri quadrati in una sorta di scrigno luminoso. La sala non aveva soltanto un valore estetico: rappresentava un gesto politico e un simbolo del potere prussiano.
Il suo destino cambiò quando Pietro il Grande visitò Berlino. Colpito dalla magnificenza della stanza, ne parlò a lungo con il sovrano prussiano, e nel 1717 la Sala d’Ambra divenne il dono che suggellò l’alleanza tra i due Paesi. Trasportata con una complessa operazione logistica fino alla Russia, fu collocata nel palazzo di Caterina a Carskoe Selo, la residenza estiva degli zar. Nel corso degli anni, fu ampliata fino a raggiungere novantasei metri quadrati, decorati con pannelli d’ambra, gemme, specchi e oro. La stanza divenne così uno dei massimi esempi dell’arte barocca europea.

Sala d’Ambra, un capolavoro nato tra diplomazia e meraviglia – misteriditalia.it
La Sala d’Ambra attraversò i secoli rimanendo intatta nonostante restauri, guerre e rivoluzioni. Ma il 1941 segnò l’inizio della sua scomparsa. L’invasione nazista e l’assedio di Leningrado resero impossibile la sua evacuazione: troppo fragile e ingombrante per essere smontata rapidamente, fu nascosta dai sovietici sotto strati di carta, tessuti e legno nel tentativo di confonderne l’aspetto.
Gli sforzi non bastarono. Le truppe tedesche identificarono la stanza e, in un’operazione meticolosa supervisionata dall’esperto Alfred Rohde, la smontarono in trentasei ore. Su ordine diretto di Hitler, fu trasportata a Königsberg, dove venne rimontata ed esposta fino al 1944, quando la città fu devastata dai bombardamenti alleati. Da quel momento, il capolavoro scomparve nel nulla.
La Sala d’Ambra fu vista per l’ultima volta nell’estate del 1944, mentre veniva imballata e trasferita in un luogo ritenuto più sicuro. Quando l’Armata Rossa entrò a Königsberg nel 1945, non trovò traccia della stanza, né documenti che arrivarono rivelarne il destino. Da allora si sono susseguite decine di ipotesi: sepolta sotto le rovine del castello, evacuata via mare e affondata durante un attacco, nascosta in bunker sotterranei, miniere, gallerie ferroviarie o castelli dell’Europa centrale. Alcune teorie la collocano persino nelle collezioni private, sfuggita alla storia ufficiale.
La fragilità dell’ambra e le condizioni in cui potrebbe essere stata conservata alimentano il timore che non sia sopravvissuta. Eppure, la ricerca non si è mai fermata, sostenuta dal valore eccezionale dell’opera e dal fascino che continua a esercitare.
Nel 1979 l’Unione Sovietica avviò un progetto monumentale per ricostruire la Sala d’Ambra, fedele all’originale in ogni dettaglio. Il lavoro durò più di vent’anni e coinvolse artigiani specializzati e storici dell’arte. La nuova sala, inaugurata nel 2003 nel palazzo di Caterina, è oggi una testimonianza della grandezza perduta, ma anche un monitor sulla fragilità del patrimonio culturale.
 La Sala d’Ambra, il gioiello trafugato dai nazisti: storia, mito e scomparsa di un capolavoro - misteriditalia.it
La Sala d’Ambra, il gioiello trafugato dai nazisti: storia, mito e scomparsa di un capolavoro - misteriditalia.it