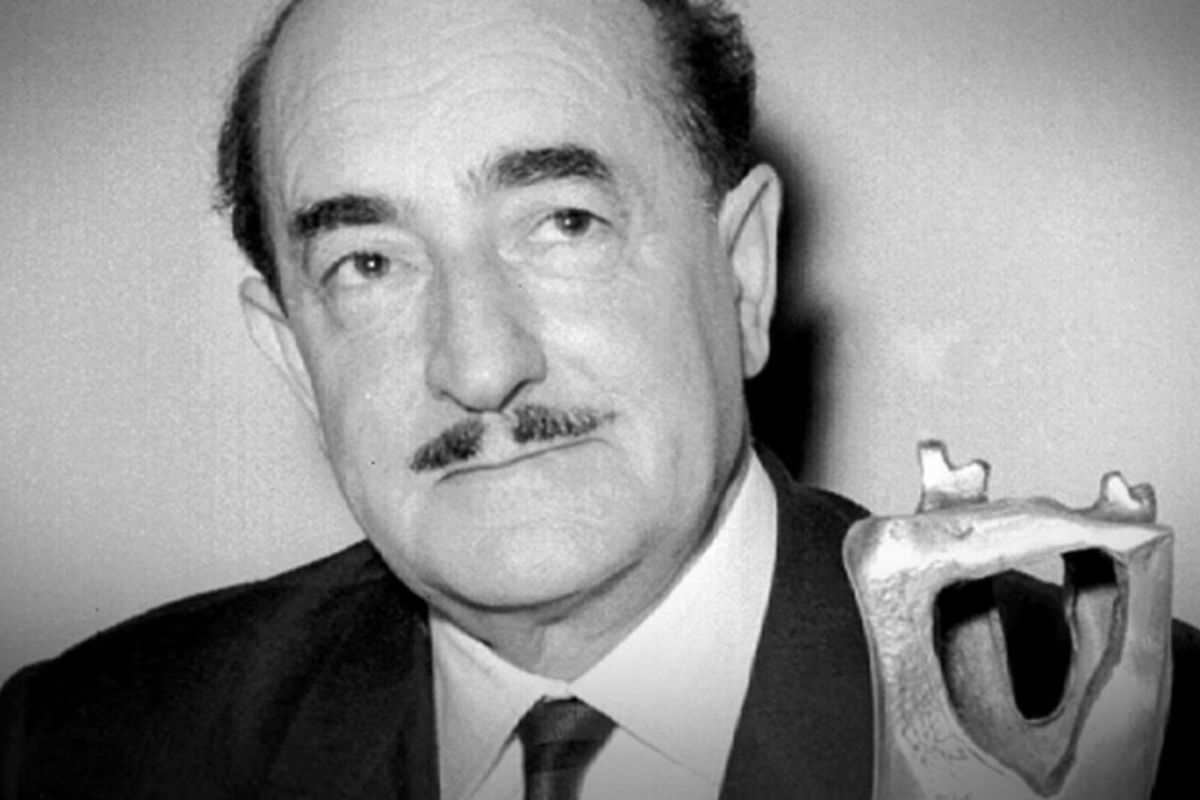La malattia da reflusso gastroesofageo colpisce milioni di italiani, con sintomi spesso sottovalutati. Scopri cause, diagnosi e strategie per prevenirla efficacemente.
La malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE) rimane una delle condizioni più comuni e fastidiose che interessano milioni di persone in Europa, con un’incidenza stimata tra il 10% e il 20%. Sebbene il fenomeno fisiologico del reflusso acido avvenga frequentemente dopo i pasti, la trasformazione in malattia si verifica quando la frequenza e la durata di tale risalita superano soglie patologiche, causando sintomi sia tipici sia atipici, e potenzialmente danni all’esofago.
Reflusso gastroesofageo: definizione, cause e sintomi
La malattia da reflusso gastroesofageo si manifesta quando il contenuto acido dello stomaco risale nell’esofago, irritando la mucosa e provocando pirosi retrosternale (bruciore dietro lo sterno) e rigurgito acido. Questo disturbo interessa circa il 30-35% dei pazienti con sintomi frequenti, mentre nel 3-5% dei casi si complicano con esofagite, ulcere o stenosi.
La causa principale è una riduzione del tono dello sfintere esofageo inferiore, la valvola muscolare che impedisce la risalita del contenuto gastrico. Le variazioni di pressione in questa zona sono influenzate da diversi fattori, quali l’alimentazione, modifiche ormonali, farmaci, sovrappeso e gravidanza. Anche fattori funzionali e anatomici giocano un ruolo rilevante nella patogenesi.
I sintomi si dividono in tipici – come bruciore retrosternale e rigurgito acido – e atipici, che includono tosse cronica, laringite, sensazione di nodo alla gola, difficoltà digestive, dolore toracico e insonnia. Tali manifestazioni atipiche possono complicare la diagnosi e richiedono un’attenzione particolare.

Reflusso gastrico: sintomi e cure – Misteriditalia.it
La diagnosi di MRGE si basa primariamente sull’anamnesi e sui sintomi tipici. Nel caso di persistenza dei disturbi o presenza di segnali d’allarme (dimagrimento, anemia, debolezza), si procede con esami strumentali. Tra questi:
- Gastroscopia (EGDS), che consente di valutare direttamente la mucosa esofagea, raccogliere biopsie e identificare lesioni come esofagite o metaplasia.
- pH-impedenziometria delle 24 ore, esame fondamentale per monitorare la quantità e la natura del reflusso (acido e non acido) in esofago.
- Manometria esofagea, utile per valutare la motilità e la pressione dello sfintere esofageo inferiore.
- Radiografia con mezzo di contrasto per studiare la funzionalità e la morfologia del tratto gastroesofageo.
La gestione iniziale del reflusso gastroesofageo prevede modifiche dello stile di vita e della dieta, con l’obiettivo di ridurre il peso corporeo, evitare cibi “reflussogeni” (cioccolato, menta, caffè, alcolici, pomodori, agrumi) e non coricarsi subito dopo i pasti, soprattutto se abbondanti.
Farmacologicamente, gli inibitori della pompa protonica (IPP) rappresentano il trattamento di prima scelta per la loro efficacia nel ridurre la produzione acida e nel favorire la guarigione delle lesioni esofagee. In alternativa o in aggiunta, si utilizzano antiacidi, antagonisti H2 e farmaci procinetici, quest’ultimi però con potenziali effetti collaterali neurologici e cardiaci da monitorare.
Negli ultimi anni, è cresciuto l’impiego di trattamenti mininvasivi endoscopici per i pazienti con reflusso resistente alla terapia farmacologica o con controindicazioni mediche. Questi interventi, eseguiti tramite strumenti introdotti per via orale, mirano a rafforzare la barriera esofago-gastrica senza ricorrere alla chirurgia tradizionale.
La fundoplicatio laparoscopica resta invece il riferimento nei casi più gravi o con concomitanti ernie iatali di grandi dimensioni, quando i farmaci non risultano efficaci.
 Mai più reflusso - Misteriditalia.it
Mai più reflusso - Misteriditalia.it