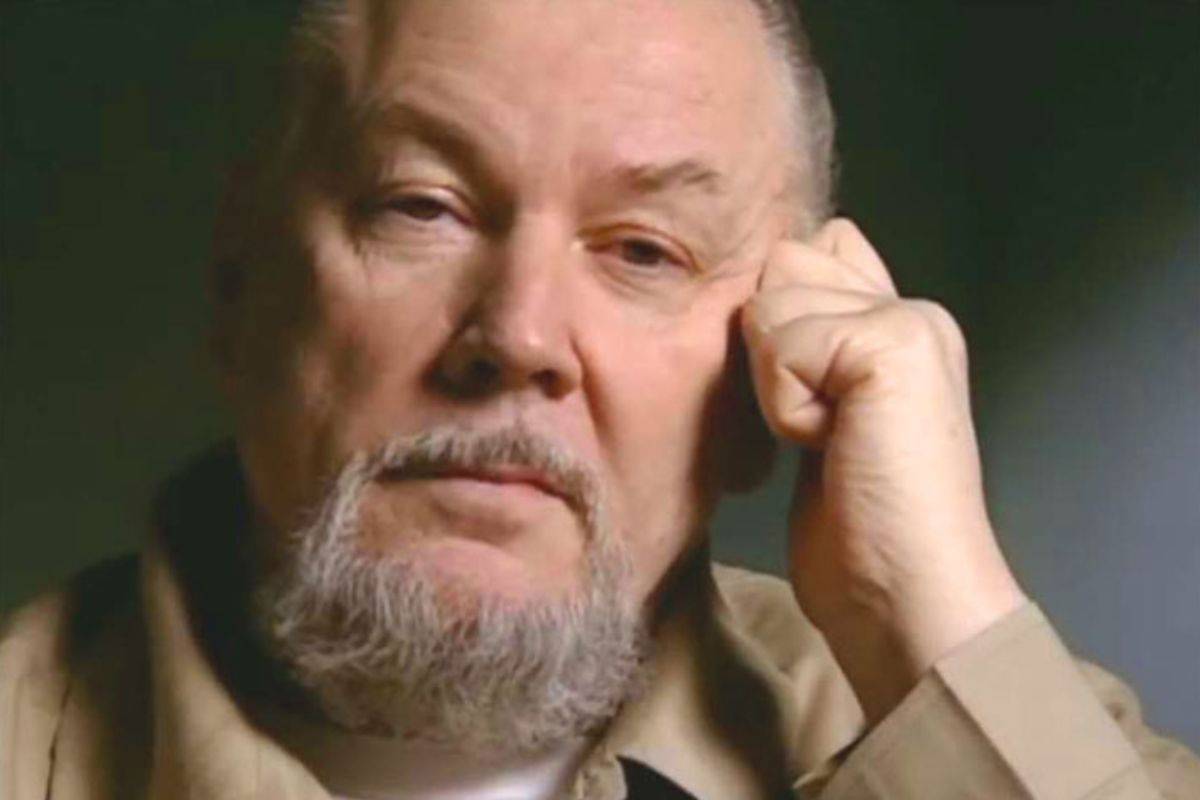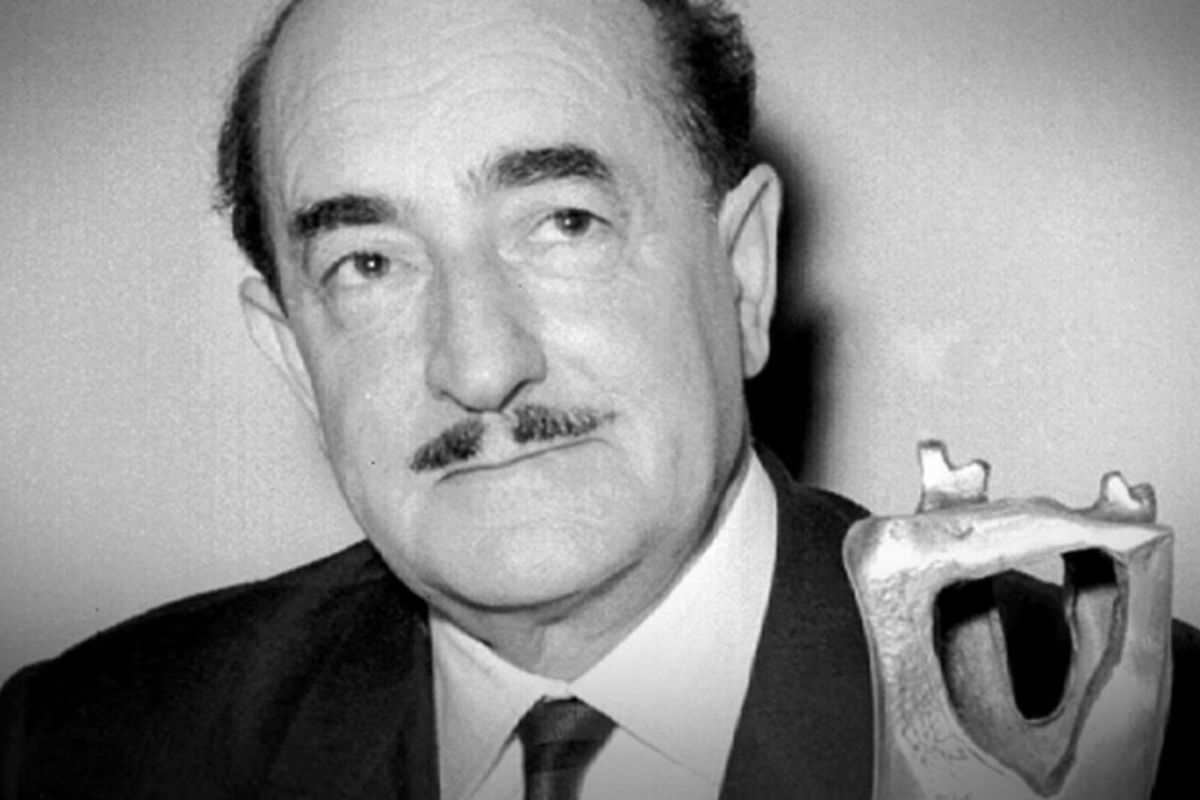La città europea che ballò sino alla morte: uno dei misteri più incredibili della storia del vecchio continente.
Il fenomeno noto come coreomania, o piaga del ballo, rappresenta uno degli eventi più enigmatici e inquietanti della storia europea, soprattutto per il celebre episodio che coinvolse la città di Strasburgo nel 1518.
Sebbene la peste nera rimanga la calamità più nota del Medioevo, la coreomania si distingue per la sua natura misteriosa e per l’effetto sorprendente che ebbe sulle comunità dell’epoca: intere folle di persone si abbandonavano a danze frenetiche e incontrollabili, spesso fino alla morte. Gli studiosi continuano a interrogarsi sulle cause di questo fenomeno che ha attraversato secoli, dal VII al XIX, con un picco tra il XIV e il XVII secolo.
La coreomania di Strasburgo: un caso emblematico
Il 14 luglio 1518, nella città di Strasburgo – allora parte del Sacro Romano Impero, oggi in Francia – Frau Troffea iniziò a ballare in modo spasmodico e senza sosta lungo una strada acciottolata vicino a casa sua. Nonostante le suppliche del marito, continuò per giorni, fino a che altre trenta persone si unirono a lei. Nel giro di un mese, il numero dei danzatori salì a circa 400, molti dei quali morirono per infarto, sfinimento o fame. Il consiglio comunale tentò di intervenire trasferendo i ballerini al santuario di San Vito, dove sembrarono guarire. Questo episodio è tra i meglio documentati, grazie a numerose cronache e rappresentazioni artistiche, come l’incisione ispirata e il dipinto di Pieter Brueghel II “I ballerini di San Giovanni a Molenbeeck” (1592).
L’episodio di Strasburgo affascina ancora oggi per i dettagli ricchi di tensione: la presenza di nomi specifici, la reazione del marito di Troffea, la partecipazione di persone con piedi sanguinanti e gonfi, e il fatto che il fenomeno si manifestò in un momento di enorme crisi sociale e climatica. Nel XVI secolo, la coreomania era interpretata come un evento soprannaturale: una maledizione divina, una punizione per i peccati o un castigo da santi offesi. La chiesa aveva il ruolo esclusivo di “curare” la danza, considerata una forma di possessione o influenza demoniaca.
Oggi, gli studiosi propongono diverse spiegazioni, nessuna delle quali definitiva. Alcune ipotesi mediche suggeriscono encefalite, epilessia o tifo, ma nessuna spiega la durata e la natura collettiva del fenomeno. Negli anni ’50, il farmacologo Eugene Louis Backman ipotizzò un avvelenamento da ergot, un fungo psicotropo che si sviluppa nei cereali in condizioni di umidità e provoca allucinazioni e agitazione. Tuttavia, questa teoria non spiega tutti i casi, considerando che la segale non era sempre il cibo principale e mancavano sintomi tipici come la cancrena.
Cosa accadde: l’ipotesi isteria collettiva
La spiegazione più accreditata è quella di un caso di isteria collettiva o isteria di massa, legata a condizioni di grande stress sociale, economico e climatico. Strasburgo all’inizio del XVI secolo era segnata da carestie, inondazioni, peste bubbonica e disordini civili, oltre a un contesto di profonde tensioni religiose e culturali. La coreomania potrebbe quindi essere interpretata come un modo di elaborare il trauma collettivo, un rito funebre sociale che coinvolgeva soprattutto le classi più povere, in particolare le donne contadine, frequentemente vittime anche delle persecuzioni per stregoneria.

Il dipinto “I ballerini di San Giovanni a Molenbeeck” – Misteriditalia.it
Gli storici Lynneth Miller Renberg e Kathryn Dickason evidenziano l’importanza di considerare il fenomeno nel suo contesto storico e culturale, evitando una lettura esclusivamente scientifica o diagnostica. La coreomania si colloca infatti tra due sistemi di credenze molto diversi: quello medievale, permeato da religiosità e superstizione, e quello moderno, scientifico e razionale. Renberg sottolinea come sia più rilevante interrogarsi su cosa significasse questo fenomeno per gli abitanti dell’epoca, piuttosto che fissarsi esclusivamente sulle cause.
Comprendere le percezioni e il contesto sociale del tempo permette di leggere la coreomania non solo come una bizzarria medica, ma come un evento umano carico di significato emotivo e simbolico. Dickason aggiunge che il corpo umano riflette le tensioni sociali e i traumi della collettività, e che la coreomania può essere vista come un’espressione di dolore e disordine che si manifesta materialmente attraverso la danza. Solo tenendo conto di questi aspetti culturali, religiosi e sociali si può davvero tentare di comprendere un fenomeno così complesso e affascinante.
 La misteriosa danza che portò alla morte tantissime persone - Misteriditalia.it
La misteriosa danza che portò alla morte tantissime persone - Misteriditalia.it