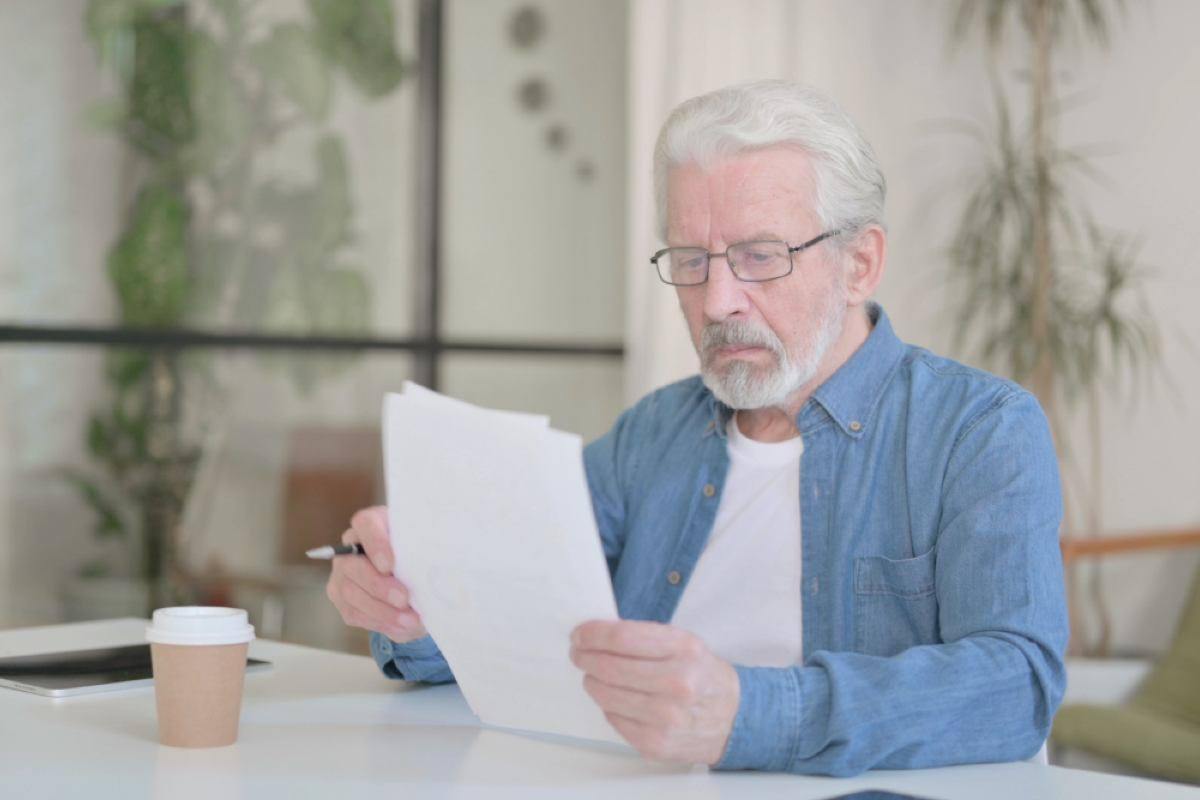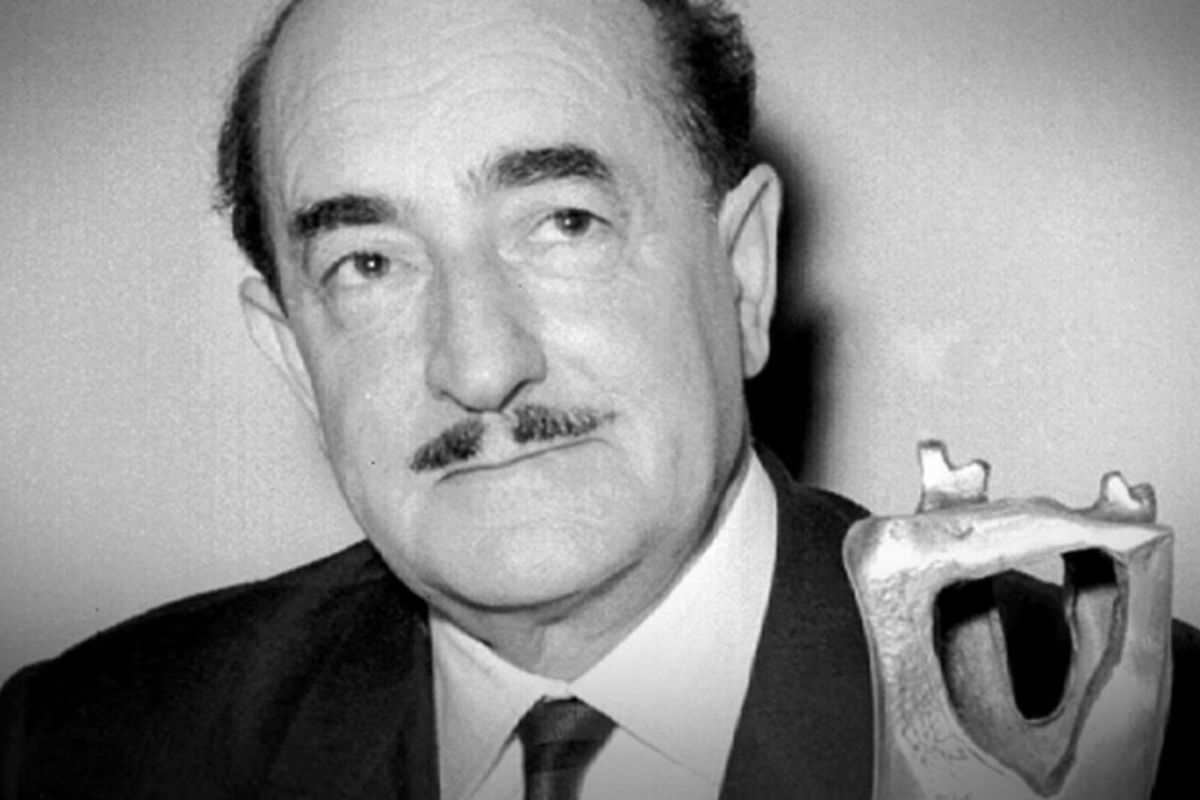INTRODUZIONE
Gli anni Sessanta
Gli anni Sessanta sono stati uno dei periodi più ricchi e fecondi di
cambiamenti della storia italiana. Immediatamente successivi al boom
economico, infatti, sono stati anni di profonde trasformazioni e di
esperimenti politici che hanno mutato il panorama politico e sociale del
nostro Paese.
Negli anni Sessanta si è assistito al primo tentativo di realizzare il
centrosinistra in Italia e, sul finire del decennio alle contestazioni operaie
e studentesche.
Sono stati anni di transizione tra l’immobilismo politico degli anni
Cinquanta e il super attivismo, purtroppo degenerato nel crimine, degli
anni Settanta.
Sono stati anni contraddittori. E continuano ad esserlo ancora oggi nel
giudizio di numerosi storici, che non sono concordi se ritenere questo
decennio la grande vittoria della democrazia, con l’ingresso del PSI nelle
compagini governative e le manifestazioni di piazza e la partecipazione
diretta del popolo alla vita e alle esigenze della “cosa pubblica” o se
considerare quelle stesse manifestazioni come l’espressione più alta del
fallimento della capacità dei partiti di rispondere alle esigenze e alle
domande della popolazione e quindi come un insuccesso della
democrazia rappresentativa.
Ancora oggi gli anni Sessanta fanno discutere anche se è facile
comprendere perché essi abbiano rappresentato per chi li ha vissuti un
periodo emozionante e coinvolgente. Perché gli anni Sessanta furono
anni di grandi mutamenti durante i quali sembrava che tutto potesse
3
essere raggiunto, soprattutto per merito delle migliori condizioni
economiche di cui godeva gran parte della popolazione. Anche in politica
molte cose stavano cambiando, in risposta alle profonde trasformazioni
che erano avvenute e che continuavano a smuovere la società.
Il Paese era diverso da quello che era uscito sconfitto dalla Seconda
Guerra Mondiale ed erano necessari comportamenti differenti della
classe politica che lo guidava. Proprio la necessità di governare lo
sviluppo fu il motivo che spinse i principali attori politici a cercare delle
alternative in una situazione politica bloccata e che spinse il più
importante partito del periodo, la Democrazia Cristiana, ad aprire un
dialogo, proficuo quasi esclusivamente sul piano teorico ed ideale, con il
Partito Socialista Italiano ed a sviluppare un progetto di centrosinistra
che, riformista nei contenuti, si rivelerà, in pratica, effimero.
Anche a livello internazionale gli anni Sessanta furono anni di transizione
con il processo di distensione avviato dal presidente degli Stati Uniti J.F.
Kennedy, eletto nel 1960, e dal leader sovietico Chruscĕv dopo la crisi
dei missili a Cuba, che fece temere davvero lo scoppio di una nuova
guerra di portata mondiale. Purtroppo il tentativo di porre fine alla guerra
fredda risultò vano e le condizioni per un passo del genere tornarono ad
essere favorevoli solo vent’anni dopo.
Gli anni Sessanta furono un periodo durante il quale iniziò a formarsi una
società civile, consapevole del proprio ruolo e delle proprie
responsabilità e illusoriamente convinta di poter “cambiare il mondo”. Ne
sono un esempio le manifestazioni studentesche e operaie che hanno
caratterizzato la vita italiana a partire dal 1967 e culminate l’asso
successivo ma anche le analoghe manifestazioni in molti paesi europei e
negli Stati Uniti, dove un’intera generazione protestò contro l’appoggio
americano al Vietnam del Sud e contro l’impegno dei soldati U.S.A. in
quella che era considerata una guerra inutile e lontana e che si concluse
negativamente per la potenza statunitense sia in termini geopolitici, sia
per quanto riguarda il numero delle vittime.
In questi stessi anni, però, in cui molte cose sembravano destinate a
cambiare per sempre sotto la superficie si muovevano uomini e
organismi con il proposito di fermare le trasformazioni in atto e di porre
un freno agli “esperimenti” che stavano modificando gli assetti politici del
nostro Paese. In questa prospettiva è possibile comprendere il tentativo
di colpo di Stato messo a punto nel 1964 dal Comandante dei carabinieri
Giovanni de Lorenzo che, con l’appoggio dei servizi segreti statunitensi,
si proponeva di bloccare ogni apertura a sinistra e di creare un nuovo
governo basato sui voti e sulla volontà dei partiti di destra.
4
Il colpo di Stato non fu mai attuato ma ciononostante raggiunse in parte i
suoi obiettivi e rese più prudente la DC sul programma di riforma.
Il “caso SIFAR”, come venne ribattezzato dai giornali quando, tre anni
dopo, il settimanale “L’Espresso” ne rese pubblica l’esistenza, fu un
tentativo estremo di porre fine alle trasformazioni che stavano
interessando la vita politica del nostro Paese e di restaurare un governo
che arginasse le spinte al cambiamento che provenivano dalla società
civile
PRIMO CAPITOLO
Politica e società
Per comprendere le cause che portarono alla calda estate del 1964 e al
tentativo di colpo di Stato è necessario partire da lontano, ricercando tali
motivi nella situazione politica internazionale e nelle profonde
trasformazioni che, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio del decennio
successivo, stavano modificando la società e la politica italiana.
Il polo internazionale1
All’inizio degli anni Sessanta il mondo era ancora diviso.
Subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale le due superpotenze
vincitrici, Stati Uniti ed Unione Sovietica, avevano diviso il globo in due
parti, ciascuna delle quali era direttamente controllata o si trovava sotto
l’influenza di uno dei due giganti. La Guerra Fredda, ovvero la
contrapposizione tra i due blocchi che si erano così formati, ha dominato
la scena politica internazionale per tutta la seconda metà del XX secolo.
Fu guerra perché il pianeta intero viveva con terrore l’esplosione, sempre
possibile, di un conflitto nucleare e, come osservava il filosofo Thomas
Hobbes, “la guerra non consiste soltanto nella battaglia o nel
combattimento, ma in un lasso di tempo in cui la volontà di scendere in
battaglia è sufficientemente manifesta”
2
; ma, in realtà, tale pericolo non
fu mai seriamente raggiunto perché i governi di entrambe le
1 Le informazioni relative allo scenario internazionale sono tratte da Eric J. Hobsbawn, Il secolo breve.
1914/1991, BUR, Milano, 1997 pagg. 281-289 2 L’affermazione del filosofo Thomas Hobbes è tratta da Eric J. Hobsbawn, Il secolo breve. 1914/1991, BUR,
Milano, 1997 pag. 268
5
superpotenze accettarono la divisione stabilita al termine del conflitto
mondiale. L’URSS controllava le zone occupate dall’Armata Rossa o da
altre forze militari comuniste alla fine della guerra e gli USA
controllavano il resto del mondo capitalista.
Il confronto militare, quindi, pur rimanendo latente e nonostante si sia
manifestato più volte nella arco di cinquanta anni, non fu la conseguenza
più importante della guerra fredda. Le due potenze nucleari furono,
infatti, impegnate in tre guerre, ma mai l’una contro l’altra. Nei conflitti in
Corea, in Vietnam ed in Afghanistan la sofisticata tecnologia bellica
messa a punto dai due giganti non si rivelò decisiva. Di ben altra entità
furono, invece, le conseguenze politiche che portarono ad una
spartizione e ad una polarizzazione in due campi nettamente distinti del
mondo e che fecero sentire i propri effetti in tutte le nazioni, dato che a
Occidente i comunisti scomparvero dal governo diventando emarginati
politici permanenti
3
, mentre l’URSS eliminò i non comunisti dalle
“democrazie popolari” in nome della marxista dittatura del proletariato
che si trasformò, ben presto, in una dittatura del partito.
All’inizio degli anni Sessanta, tuttavia, la guerra fredda sembrava
muovere qualche passo verso una soluzione durante il periodo della
distensione. Questa parola si era affacciata sullo scenario internazionale
verso la fine degli anni cinquanta, quando Chruscěv4
, l’unico statista di
origine contadina che abbia mai governato una superpotenza, aveva
stabilito la sua supremazia nell’unione Sovietica post-stalinista.
L’elezione di J.F. Kennedy nel 1960 coincise con un periodo in cui al
mondo capitalista sembrava di perdere terreno contro le economie
comuniste, cresciute molto rapidamente durante gli anni Cinquanta.
L’URSS, da parte sua, era preoccupata dalla grave rottura con la Cina,
che accusava Mosca di scivolare lentamente ma inesorabilmente verso il
capitalismo. Tale posizione di Pechino costrinse Chruscěv ad adottare
una politica più intransigente verso l’Occidente capitalista e le due
superpotenze si fronteggiarono a Berlino, nel Congo e a Cuba.
Paradossalmente il risultato finale di questa fase di minacce reciproche e
di reciproci sospetti fu un tacito accordo tra le due superpotenze a non
terrorizzare se stesse e il mondo che portò ad un sistema internazionale
relativamente stabile. Nel 1961 venne eretto il Muro di Berlino, che
chiuse in Europa l’ultima frontiera che era rimasta incerta tra l’Oriente
3 In Italia il Partito Comunista entrerà nell’orbita di governo del Paese solo sul finire degli anni ’70 grazie al
tentativo di “Compromesso storico” tra il segretario della DC, l’On. Aldo Moro, e il segretario del PCI, l’On.
Enrico Berlinguer. 4 Chruscěv guidò il PCUS a partire dal 1956 e diede avvio al processo di destalinizzazione dell’Unione Sovietica
denunciando i crimini di Stalin.
6
comunista e l’Occidente capitalista. Gli Stati Uniti accettarono un paese
comunista come Cuba a poche miglia di distanza dalla Florida, dopo
che, in un primo momento, si era rischiata l’esplosione della guerra
quando Cuba aveva accettato di “ospitare” dei missili sovietici e i focolai
accesi in America Latina dalla rivoluzione cubana ed in Africa dal
processo di decolonizzazione sembrarono estinguersi. Ancor più
indicativi del processo di distensione in atto furono alcuni provvedimenti
che avevano come obiettivo la limitazione delle armi nucleari e il fiorire
del commercio tra Stati Uniti ed Unione Sovietica. Le prospettive per il
futuro sembravano positive ma due eventi destabilizzarono l’equilibrio
finalmente raggiunto: dapprima la guerra del Vietnam (1965 – 1975), che
portò ad un progressivo isolamento degli Stati Uniti e che vide
l’emergere, in tutto il mondo, di numerosi movimenti pacifisti contro
l’intervento militare e, successivamente, nel 1973, la guerra dello Yom
Kippur, combattuta tra Israele, che gli USA avevano scelto come alleato,
e l’Egitto e la Siria, militarmente rifornite dai Sovietici.
Verso la metà degli anni Settanta, quindi, tutti i passi avanti fatti negli
anni precedenti per cercare un equilibrio mondiale erano stati
rapidamente cancellati e ci vorrà ancora più di un decennio per assistere
alla fine della Guerra Fredda con la caduta, nel 1989, del Muro di Berlino
ed il crollo dell’Unione Sovietica.
In Italia5
Intanto la situazione italiana si andava rapidamente modificando sia dal
punto di vista politico sia all’interno della società. Le enormi
trasformazioni che avevano caratterizzato il nostro Paese a partire dagli
anni Cinquanta sembravano render necessario un cambio nella linea di
governo e, quindi, già dalla fine del decennio si parlava di una possibile
svolta a sinistra con la costituzione di un governo di centrosinistra che si
materializzò effettivamente soltanto nel 1963.
Ma andiamo con ordine e cerchiamo di comprendere quali furono gli
eventi che avevano, in poco meno di un decennio, cambiato il volto del
nostro Paese.
Il nuovo benessere e le ottimistiche aspettative per il futuro diedero il via,
nella seconda metà degli anni Cinquanta, ad una dilatazione dei
consumi. Al primo posto c’erano motociclette e automobili: la “Lambretta”
5 Le notizie relative al quadro italiano sono tratte da Simona Colarizi, Storia del Novecento Italiano. Cent’anni di
entusiasmo, di paure, di speranza, BUR Saggi, Milano, 2000 pagg. 370-390.
7
dell’Innocenti e la celebre “Vespa” della Piaggio (nel 1956 uscì dagli
stabilimenti Piaggio il milionesimo esemplare) ma anche, tra le auto, la
“600” (1955) e la “500” (1957), entrambe della FIAT, furono alla base di
quella “motorizzazione di massa” che modificò profondamente lo
scenario delle città e dell’intera società italiana6
. Alla enorme espansione
dei consumi e al maggiore benessere si affiancò anche una maggiore
consapevolezza dei propri diritti degli italiani che si sentivano finalmente
liberi dai bisogni primari. Il motore principale di questo accresciuto senso
di cittadinanza fu senza dubbio la crescita della scolarizzazione: basti
pensare che tra il 1955 e il 1965 raddoppiarono gli iscritti agli istituti
superiori
7
.
Benessere, urbanizzazione, crescita della scolarizzazione: tutti fenomeni
che intaccarono profondamente la società italiana, che, finalmente, si
lasciava alle spalle secoli di civiltà contadina e che resero necessaria
una nuova guida politica che fosse capace di governare lo sviluppo. Era
proprio questo che si proponevano i socialisti quando, nella seconda
metà degli anni ’50, si cominciò a parlare insistentemente di
centrosinistra.
Trasformazioni avvenivano anche negli ambienti intellettuali e politici.
Nel 1955, infatti, venne fondato il settimanale “L’Espresso”, un giornale
laico nato con il sostegno finanziario di Adriano Olivetti e di cui Carlo
Caracciolo diventò il maggiore azionista mentre nel 1956 nacque un
nuovo quotidiano, “Il Giorno”, fondato dal presidente dell’ENI, Enrico
Mattei, che segnò una rivoluzione nel linguaggio, nei contenuti e nella
impostazione grafica rispetto al panorama grigio del giornalismo italiano.
Erano i primi segnali di risveglio della stampa italiana8
.
Diversa fu, invece, la sorte della televisione9 che, così come accaduto
anni prima per la radio, ricevette la diffidenza dell’establishment
democristiano, in quanto giudicata troppo moderna e trasgressiva per
adattarsi al costume italiano. In televisione i dirigenti designati dalla DC
esercitarono un controllo politico ma soprattutto morale estremamente
rigoroso ma, ciononostante, l’America e l’American way of life riuscirono
ad invadere l’Italia. Persino un programma per famiglie come “Lascia o
6 Dal 1954 al 1964 le automobili in circolazione in Italia passarono da circa 700 mila a quasi 5 milioni, grazie
anche all’introduzione del sistema rateale che ebbe un successo strepitoso. 7 Dai 500 mila iscritti alle scuole media e di avviamento professionale del 1947 si passa ai 900 mila del 1955 e al
milione e 600 mila del 1962; mentre tra il 1955 e il 1965 raddoppiarono gli iscritti agli istituti superiori, da 600
mila a 1 milione e 200 mila. 8 Sulla stessa strada de “L’espresso” e de “Il Giorno” si avviò anche il gruppo de “Il Mulino”, punto di incontro
tra intellettuali cattolici, socialisti e laici, un vero punto di incontro per il futuro centrosinistra. 9 Le trasmissioni ufficiali della RAI-TV iniziarono il 3 gennaio 1954 con il programma “ARRIVI E
PARTENZE”, condotto da Mike Bongiorno.
8
raddoppia?”
10 era ispirato ad un telequiz americano ed il successo fu
travolgente.
Se anche i media, quindi, si resero partecipi e artefici allo stesso tempo
di questa trasformazione della società italiana, numerosi cambiamenti
investirono, in questo stesso periodo, anche il mondo politico. Se, infatti,
il partito comunista continuava ad essere emarginato dal sistema politico
italiano, nonostante i suoi numerosi elettori che lo rendevano il secondo
partito italiano, il PSI che nel 1956 aveva allontanato le proprie posizioni
da quelle comuniste e filosovietiche si dichiarava pronto ad entrare al
governo del Paese con un ruolo di primo piano.
Nel frattempo due cambiamenti di livello internazionale rendevano
plausibile l’idea stessa del centrosinistra: in Vaticano, l’elezione al soglio
pontificio di Giovanni XXIII
11 che, nel 1962, convocherà il Concilio
Ecumenico Vaticano II e negli Stati Uniti l’elezione a presidente del
democratico John Fitzgerald Kennedy. In entrambi i casi fu mostrato un
cauto gradimento verso il centrosinistra: Giovanni XXIII si dichiarò dalla
parte dei deboli e dei poveri per cui i giusti (credenti e non) erano i
socialisti e i cattolici che si proponevano di favorire l’ascesa delle masse
lavoratrici e di battersi per i diritti e le riforme mentre la nuova frontiera di
Kennedy era una promessa di democrazia, di giustizia e di libertà che
non venne smentita quando dal Dipartimento di Stato americano filtrò
una prudente approvazione verso i nuovi equilibri politici italiani.
Se la situazione internazionale sembrava dunque favorevole, un vero e
proprio pronunciamento di piazza a favore dell’unione tra democristiani e
socialisti nel governo del Paese si ebbe nel 1960 quando migliaia di
giovani, i ragazzi con le magliette a strisce12 come furono ribattezzati
dalla stampa, si ribellarono al governo Tambroni, sostenuto in
Parlamento dai voti dei monarchici e dei missini. La scintilla che fece
esplodere la protesta fu l’autorizzazione data ai neofascisti del MSI di
celebrare il proprio congresso a Genova, città medaglia d’oro della
Resistenza. Genova antifascista però si ribellò e l’incendiò della protesta
dilagò in tutta Italia: ci furono scontri a Roma, Reggio Emilia, dove
restarono uccisi cinque manifestanti, Catania, Palermo, Parma, Modena
e Napoli. Queste manifestazioni, organizzate non solo da comunisti e
socialisti, ma anche dai partiti socialdemocratico e repubblicano nonché
10 “Lascia o raddoppia?”, condotto da Mike Bongiorno, debuttò in TV nel 1955. Il format su cui era modellato
era un programma americano dal titolo “The 64,000 $ Question”. 11 Giovanni XXIII, al secolo Angelo Giuseppe Roncalli, patriarca di Venezia, salì al soglio pontificio nel 1958. 12 Proprio con le proteste dei ragazzi con le magliette a strisce si impose all’attenzione dell’opinione pubblica un
nuovo soggetto politico, quello dei giovani, provenienti spesso direttamente dai banchi di scuola e di università e
pronti a battersi contro i neofascisti.
9
dai radicali e dalle associazioni partigiane, il richiamo ai governi di unità
nazionale antifascista del 1944, che dava una maggiore credibilità ad
una possibile alleanza governativa DC-PSI, nonché un manifesto,
sottoscritto il 18 luglio 1961 anche da molti intellettuali cattolici, in cui si
rifiutava ogni collaborazione con i neofascisti, “costrinsero” Tambroni a
dimettersi da capo del governo e portarono ad un esecutivo, guidato da
Fanfani, che si reggeva sulla significativa astensione dei socialisti. Era il
primo passo verso il centrosinistra: nel 1962 lo stesso Fanfani successe
a se stesso con un nuovo esecutivo appoggiato dall’esterno dal PSI che
entrò organicamente in una compagine ministeriale solo l’anno
successivo, nel 1963.
Finora sono state ripercorse le tappe che hanno portato alla costituzione
del primo governo di centrosinistra nella storia d’Italia, dopo quello di
unità nazionale antifascista immediatamente successivo al termine della
seconda guerra mondiale. L’alleanza governativa era necessaria per
guidare il paese in una fase ricca di trasformazioni e di mutamenti quali
erano gli anni Sessanta ma fu proprio la volontà di fermare il programma
riformista sulla cui base quel governo era nato a produrre, nel luglio del
1964, il tentativo di Colpo di Stato da parte dei Servizi Segreti e del Gen.
Giovanni De Lorenzo, comandante generale dell’Arma dei carabinieri.
Prima, però, di addentrarci nei meandri di quello che venne ribattezzato
dalla stampa come “caso SIFAR” è utile chiarire quali erano le riforme
che il nuovo governo si proponeva di realizzare e come, nel frattempo,
andava trasformandosi il rapporto tra società e politica.
Il nuovo esecutivo di centrosinistra si era costituito con il preciso obiettivo
di dare una risposta alle trasformazioni che stavano rapidamente
cambiando la società italiana. Il centrosinistra del 1962 era nato in base
all’accordo su un programma riformista imponente: riforma della scuola,
con l’obbligo scolastico innalzato a quattordici anni, riforma urbanistica,
riforma della pubblica amministrazione, attuazione delle regioni, secondo
quanto stabilito dalla Carta Costituzionale, nazionalizzazione delle
imprese elettriche e programmazione economica. Si trattava di un
insieme significativo di riforme che non venne mai realizzato nella sua
completezza; soltanto la riforma della scuola e la nazionalizzazione delle
imprese elettriche videro effettiva applicazione13
. Le cause che frenarono
un ben più incisivo intervento riformatore da parte del governo erano
varie e devono essere ricercate innanzitutto nella situazione dei due
partiti maggiori che avevano dato vita al progetto: il PSI e la DC.
13 Il nuovo esecutivo di centrosinistra esordì con due interventi molto popolari: l’aumento del 30% delle pensioni
di invalidità e vecchiaia e la gratuità dei testi per le scuole elementari.
10
Il primo, nel 1963, vide calare di 0,5 punti percentuali il proprio peso
elettorale, dal 14,2% del 1958 al 13,8%, a vantaggio del partito
comunista che guadagnò, invece, circa tre punti passando dal 22,7% al
25,3%14
. Tale arretramento, unito alla consapevolezza che le masse non
si riconoscevano nel partito socialista ma in quello comunista, così come
pure quei ceti medi fiduciosi nelle riforme e nel progresso, e ai processi
autodistruttivi di scomposizione e ricomposizione interna al partito che si
verificavano in quel periodo, posero fine all’idea di Nenni di realizzare in
Italia una grande socialdemocrazia. Questo stesso progetto fu avversato
e ostacolato, inoltre, dalla stessa Democrazia Cristiana che, dopo una
brillante partenza, rallentò la marcia, stemperando ogni intento
riformatore. A frenare la DC sulla strada del cambiamento furono le
pressioni della destra, interna ed esterna al partito, che aveva mostrato
la propria forza già nel 1962 quando Antonio Segni, democristiano, era
stato eletto al Quirinale con i voti determinanti del MSI
15
.
Contro i piani riformatori del nuovo esecutivo si era alzato anche il
malcontento di buona parte degli industriali che si sentivano traditi dai
democristiani che avevano spalancato le porte del governo ai socialisti
con un’incoscienza incomprensibile. Il PSI veniva considerato un alleato
infido o, come scrisse il Corriere della Sera, un vero e proprio cavallo di
Troia che avrebbe consentito ai comunisti di penetrare nella “stanza dei
bottoni”. La nazionalizzazione delle imprese elettriche, votata anche dal
PCI, scatenò il panico in Confindustria secondo la quale avrebbe
trasformato l’Italia in un paese dell’Est. In realtà il potenziamento del
ruolo dello Stato in economia si rivelò un buon affare per l’industria
privata, che poté giovarsi delle opere pubbliche e dei nuovi servizi a
basso costo. Tuttavia se alcuni imprenditori, come Valletta, il presidente
della FIAT, si dichiararono addirittura fautori del centrosinistra, forse
rassicurati anche dalla prudenza democristiana, molto più difficile da
disinnescare era l’allarme che cresceva nelle fasce più retrive del mondo
economico e nei settori meno dinamici della media-piccola borghesia. In
queste fasce della popolazione la svolta a sinistra era vista con profonda
insofferenza che si traduceva nel desiderio di tornare indietro e di frenare
quella corsa alla modernità. Proprio in questi strati della società si
svilupperà uno stato d’animo ideale per le trame golpiste che, dal 1964
14 La situazione elettorale del partito socialista non migliorò neppure nelle successive consultazioni; a partire dal
1963 iniziò per il PSI un trend negativo che in tredici anni lo vide calare al 9,7% del 1976. Tredici anni di
Welfare State finirono invece per giovare al PCI, balzato nel 1976 al 34,4% dei voti. 15 I cattolici erano soddisfatti delle difficoltà del partito socialista perché questo sarebbe stato così subalterno al
partito cattolico nel governo. Una forte socialdemocrazia avrebbe, invece, occupato il centro del sistema politico,
sospingendo i democristiani sulla destra dove, da sempre, la DC evitava di lasciarsi incasellare.
11
fino agli anni Ottanta, inquinarono e minacciarono la stabilità stessa delle
istituzioni democratiche.
Il primo tentativo di modificare dall’esterno le sorti della democrazia
italiana si verificò nel 1964 con il tentativo di colpo di Stato messo in atto
dal Gen. Giovanni De Lorenzo che, con l’appoggio degli ambienti di
estrema destra e dell’Arma dei carabinieri, si proponeva di “persuadere”
il Presidente del Consiglio, l’On. Aldo Moro e il presidente della
Repubblica Segni a liquidare i socialisti con un piano, il famoso “Piano
Solo”, che avrebbe garantito l’ordine e messo a tacere le opposizioni. Il
piano non ebbe seguito, grazie al rifiuto dei vertici democristiani di
appoggiare l’idea di De Lorenzo, vertici democristiani che, però, si
affrettarono a coprire la trama golpista con una cappa di silenzio. Pur
non raggiungendo i suoi obiettivi, tuttavia, il “caso SIFAR”, come venne
ribattezzato il complotto ai danni dello Stato nel 1967, quando ne furono
svelati i retroscena dai giornalisti de “L’Espresso” Eugenio Scalfari e Lino
Iannuzzi divenne un ulteriore motivo di cautela per la DC, che continuò la
marcia del centrosinistra con i piedi di piombo, a danno della capacità
riformatrice dei governi che si susseguirono. Proprio questa mancanza di
volontà di rispondere alle reali esigenze del Paese, produsse un diffuso
malcontento che sfociò pochi anni dopo, a partire dal 1967, nelle
proteste di piazza di studenti e operai ma, questa, è un’altra storia…
UNO SCANDALO ITALIANO: L’ESPRESSO E IL CASO SIFAR
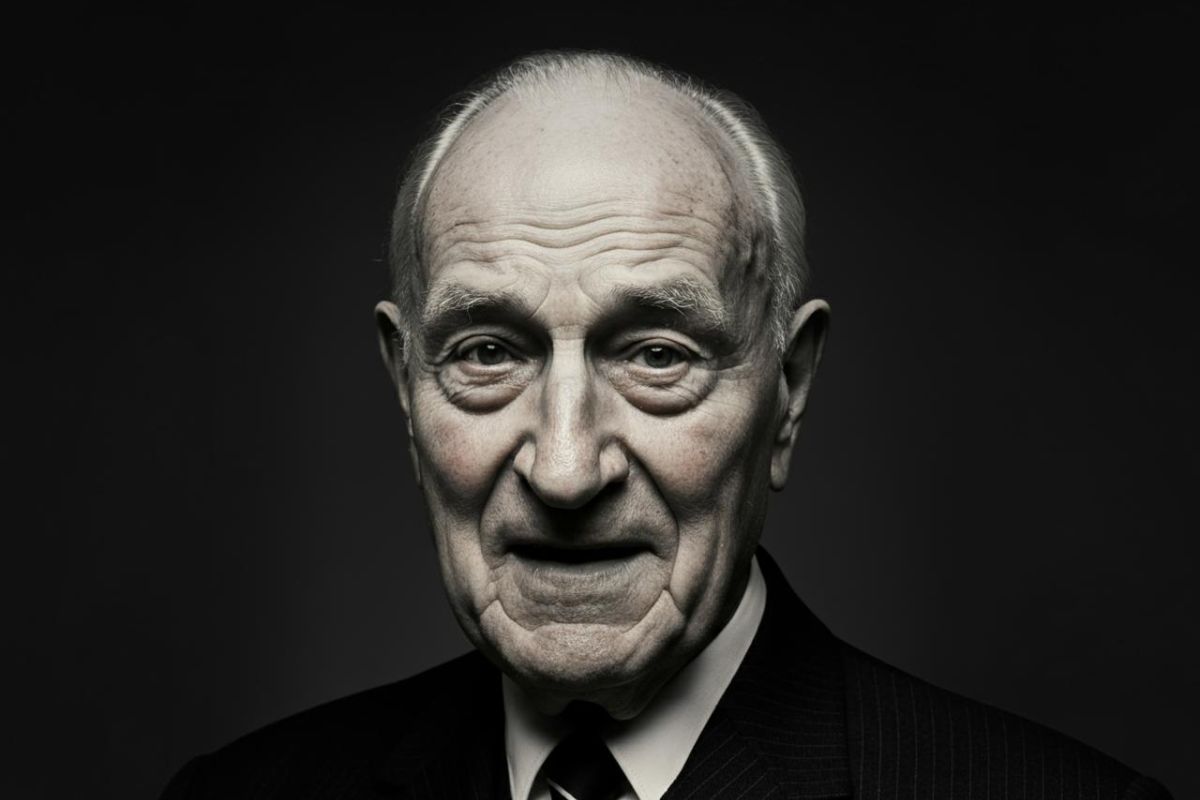 8989_1_politica-italiana-anni-60-misteriditalia.it
8989_1_politica-italiana-anni-60-misteriditalia.it