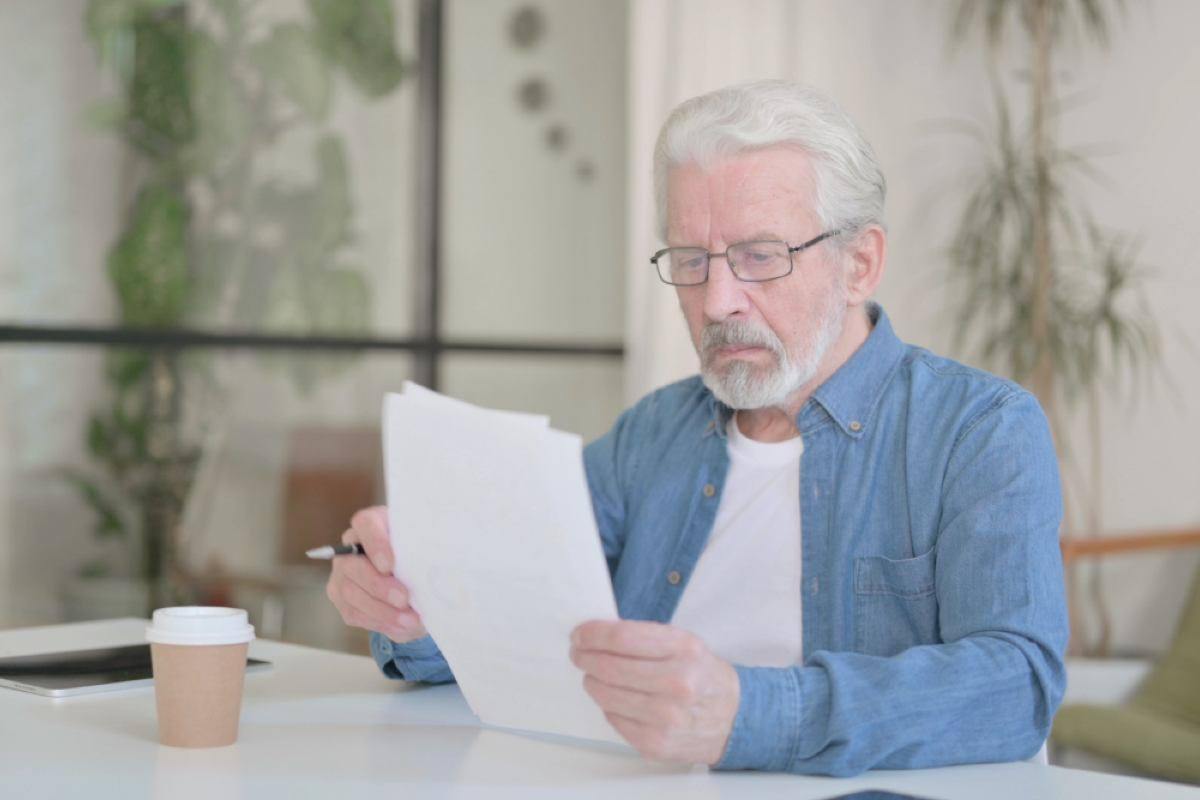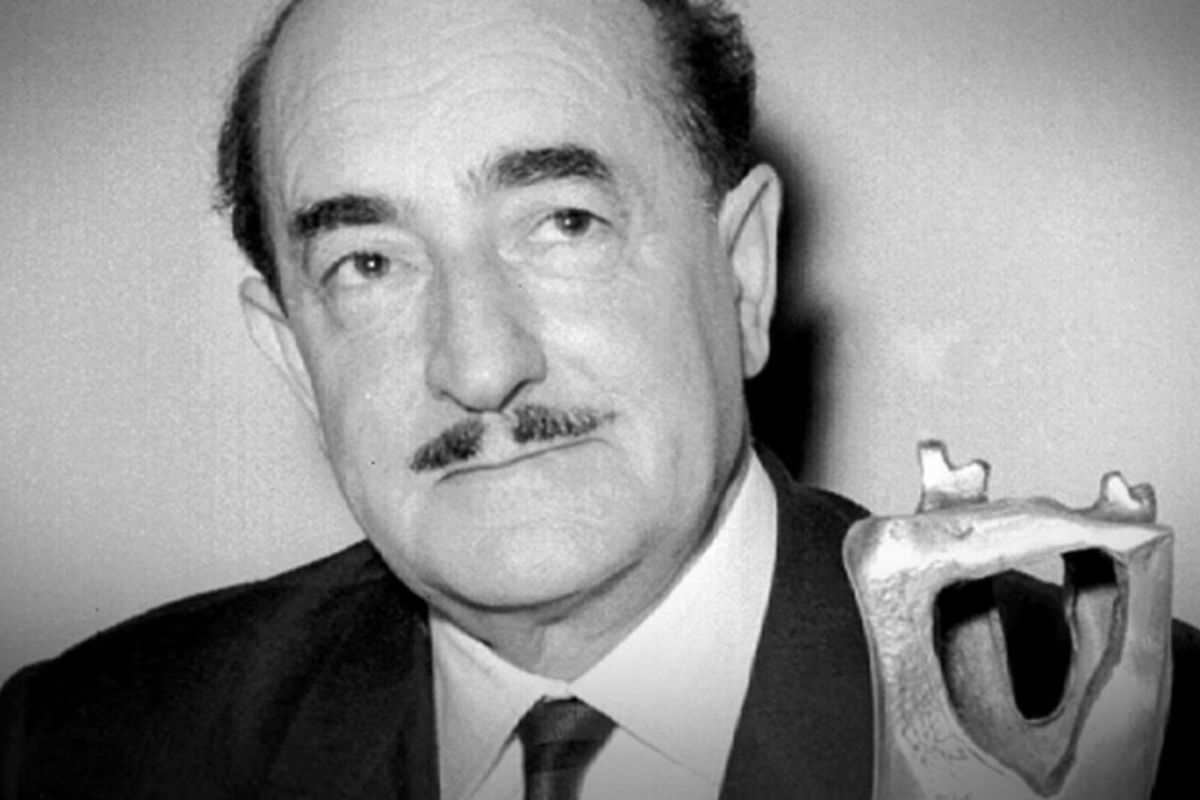In termine di uguale ragionevolezza deve ritenersi riferibile al medesimo
contesto unitario anche la terza strage insoluta, e cioè quella del 4 agosto del
1974 sul treno Italicus che causò dodici morti e quarantaquattro feriti.
La riferibilità della strage al contesto è stata già affermata in sede parlamentare.
Nella relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d’inchiesta
sulla logga P2 è già stato, infatti, affermato:
“1. La strage dell’Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di
ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana;
2. La loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento
nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana;
3. La loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell’Italicus e
può considerarsene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari,
ma storico-politici quale essenziale retroterra economico, organizzativo e
morale”.
E’ conclusione che può essere ribadita alla stregua di nuove e notevoli
acquisizioni e benché la complessa vicenda giudiziaria abbia sinora condotto ad
esiti assolutori.
La prima istruttoria sull’Italicus si concluse con il rinvio a giudizio di Mario Tuti,
Luciano Franci e Piero Malentacchi, estremisti di destra appartenenti
all’ambiente toscano del Fronte Nazionale Rivoluzionario.
Con i tre furono imputati anche Margherita Luddi, legata sentimentalmente al
Franci, per detenzione di armi, e Francesco Sgrò per calunnia.
Quest’ultimo era stato autore di un tentativo depistante tendente ad attribuire
l’organizzazione di un attentato ad un treno ad un movimento studentesco
romano di sinistra. Successivamente lo Sgrò riconobbe il carattere calunnioso
delle sue dichiarazioni, affermando di aver tentato con le stesse di ottenere
denaro dal MSI. Sgrò era stato infatti la fonte che aveva indotto il segretario del
MSI, onorevole Almirante, ad annunciare, per così dire, la strage recandosi,
accompagnato dall’onorevole Alfredo Covelli, dal dottor Emilio Santillo, direttore
dell’Ispettorato generale antiterrorismo, per denunciargli il proprio timore di un
imminente attentato ad un treno1
ad iniziativa di ambienti universitari romani di
sinistra.
Un secondo preannuncio della strage sarebbe stato operato da Claudia Aiello,
una italo-greca, dipendente del Sid con funzioni di interprete, che pochi giorni
prima dell’attentato sarebbe stata ascoltata in una ricevitoria del lotto di Roma
affermare per telefono frasi quali
“Le bombe sono pronte…”
e fare riferimento a passaporti e treni e alle città di Bologna e Mestre.
L’episodio, oggetto di ripetuto e attento esame giudiziario, non ha portato a
sviluppi indagativi che abbiano assunto concreto rilievo.
I due ricordati episodi appaiono peraltro di un qualche rilievo almeno per
confermare, da un lato, nell’attentato dell’Italicus il carattere di strage
annunciata più volte sottolineato nella pubblicistica, dall’altro, il clima di estrema
tensione che caratterizza il periodo.
La direzione indagativa che si sviluppò nei confronti di Mario Tuti, Luciano
Franci e Pietro Malentacchi prese le mosse, e sostanzialmente continuò a
fondarsi, sulle dichiarazioni accusatorie di Aurelio Fianchini, al quale il Franci,
suo compagno di detenzione, avrebbe confidato di avere eseguito la strage
indicando nel Tuti il gestore dell’esplosivo e nel Malentacchi colui che
materialmente avrebbe sistemato l’ordigno.
Corroboravano l’accusa del Fianchini la comune militanza nell’FNR, la
disponibilità di armi ed esplosivi, la responsabilità in altri attentati senza vittime,
la personalità sicuramente terroristica ed eversiva di Tuti, autore di numerosi
omicidi, alcuni dei quali consumati con notevole ferocia; infine il fatto che il
Franci, carrellista presso la stazione di Santa Maria Novella di Firenze, la notte
dell’attentato si trovava in servizio fuori turno ed in esito ad una sua richiesta,
mai giustificata, proprio in prossimità del binario dove aveva sostato l’Italicus.
Si trattava, come si vede, di un quadro probatorio consistente ma incompleto
per la mancanza di sufficienti riscontri all’accusa del Fianchini.
Ciò giustifica l’altalenanza dei risultati giudiziari. Tuti, Franci e Malentacchi
furono assolti in primo grado dall’accusa di strage per insufficienza di prove. In
appello Tuti e Franci furono condannati all’ergastolo. La sentenza fu annullata
dalla prima sezione della Corte di Cassazione e la Corte di Assise di Appello di
Bologna, in sede di rinvio, assolse Tuti e Franci con formula piena; l’assoluzione
divenne definitiva a seguito di sentenza del 24 marzo 1992 della Corte di
Cassazione.
Mentre era in corso il giudizio di primo grado, la procura di Bologna ravvisava la
necessità di proseguire le indagini sul duplice presupposto che gli imputati
rinviati a giudizio non avevano potuto agire isolatamente e che la prima
istruttoria poteva essere stata oggetto di inquinamenti e depistaggi di cui si
imponeva l’accertamento.
Nel nuovo procedimento la matrice eversiva di destra trovava ulteriori conferme,
articolandosi tuttavia in un ventaglio di ipotesi diverse per le specifiche
1
Il treno indicato da Sgrò all’onorevole Almirante avrebbe dovuto partire dalla stazione Tiburtina di Roma alle 5,30 e fu
preventivamente individuato nel Palatino. In realtà la strage si verifica sull’Italicus in partenza, come il Palatino, dalla
stazione Termini e non dalla Tiburtina, e alle 17,30 (e cioè alle 5,30 pomeridiane). La coincidenza lascia
ragionevolmente supporre che Sgrò, che pure in sede giudiziaria è stato ritenuto un comune bugiardo, fosse in qualche
modo a conoscenza dei preparativi dell’attentato.
responsabilità individuali2
. Mentre tale istruttoria era in corso giungeva a
dibattimento anche il procedimento per la strage della stazione di Bologna, di
sei anni successiva. In quella sede furono peraltro stralciate le posizioni di
Stefano Delle Chiaie, Adriano Tlgher, Marco Ballan ed altre.
Il giudice istruttore di Bologna – presso il quale erano concentrati i procedimenti
per strage (Italicus bis e Bologna bis) che proseguivano con il vecchio rito –
considerati gli sviluppi relativi alle possibili strategie emergenti dalle rispettive
indagini, la ricorrenza di medesimi soggetti e gruppi dell’eversione, i legami di
costoro con gli stesi esponenti degli apparati di sicurezza, la medesima natura
delle interferenze e degli ostacoli frapposti alle attività di accertamento con
notevoli analogie tra gli episodi di inquinamento e di depistaggio che si
andavano verificando nelle due vicende processuali, veniva indotto a disporre
nell’ottobre del 1993 la riunione dei due procedimenti.
L’istruttoria si è quindi conclusa con la sentenza-ordinanza 3 agosto 1994,
trasmessa per ulteriori sviluppi e quindi per competenza a diverse procure e
acquisita da questa Commissione.
Come sostanzialmente espresso nel provvedimento, le conclusioni del G.I.
dottor Grassi definiscono il procedimento ma non esauriscono le prospettive
aperte dal lavoro degli inquirenti per l’accertamento della responsabilità e i
motivi di riflessione storico-politica sui risultati processuali, dandosi carico
l’ordinanza di evidenziare acquisizioni e collegamenti probatori anche non
decisivi per l’immediata e definitiva soluzione positiva o negativa di singoli
episodi e sottostanti alle complessive strategie3
.
2
In particolare:
– si approfondiva ulteriormente la pista dei gruppi toscani, caratterizzata dagli emergenti collegamenti con
la loggia massonica P2 e con gli ambienti di apparati di sicurezza operanti in Firenze in un ruolo di
controllo, di copertura e di chiaro sostegno alle attività del Gelli,
– si prospettavano responsabilità a carico del gruppo dirigente di Avanguardia Nazionale, con particolare
riferimento alle figure di Stefano Delle Chiaie e di Adriano Tilgher;
– si sviluppavano nuove ipotesi, delineate dalle dichiarazioni di Valerio Viccei, nella prospettiva dell’esistenza di un
complesso disegno terroristico riconducibile al gruppo milanese diretto da Giancarlo Rognoni ed attuato da derivazioni
locali operanti nell’Italia centrale e in particolare nell’ascolano.
3
L’ordinanza-sentenza del dottor Grassi – che costituisce una delle acquisizioni più importanti per questa
Commissione ai fini di una ricostruzione attendibile dei contesti eversivi in cui maturarono e furono
compiuti gli attentati stragisti nell’ambito temporale limitato alla prima metà degli anni Settanta – giunge
alla seguenti principali conclusioni, così definendo:
– le imputazioni di concorso in strage per attentare alla sicurezza dello Stato, omicidio plurimo, lesioni,
detenzione di esplosivi, disastro ferroviario, in relazione all’attentato al treno Italicus, nei confronti di
Stefano Delle Chiaie e Adriano Tilgher, con proscioglimento per non aver commesso il fatto;
– l’imputazione di concorso in associazione sovversiva, in riferimento alla costituzione e organizzazione
del “Fronte Nazionale Rivoluzionario” in Toscana, fino al 3 agosto 1974, nei confronti degli stessi Delle
Chiaie e Tilgher, con proscioglimento per non aver commesso il fatto;
– le imputazioni di associazione sovversiva e banda armata operanti in Milano, Ascoli e altre zone
dell’Italia centrale sino all’agosto del 1974, nei confronti di Piergiorgio Marini e Giuseppe Ortensi,
dichiarandone l’improcedibilità per l’esistenza di precedente giudicato sui medesimi fatti;
– l’imputazione di favoreggiamento aggravato, a vantaggio di Luciano Franchi e Pietro Malentacchi e
nell’ambito delle indagini sulla strage dell’Italicus e commesso quindi nell’agosto-settembre 1974, nei
confronti del comandante del Gruppo dei carabinieri di Arezzo, col. Domenico Tuminello, dichiarando
l’estensione del reato per intervenuta prescrizione;
– l’imputazione di calunnia continuata, aggravata dalla finalità di eversione, in relazione alle false accuse
in danno di Valerio Viccei e Angelo Izzo, per aver reso dichiarazioni calunnatorie, per aver predisposto
un’evasione dal carcere di Paliano unitamente a Raffaella Furiozzi e a Sergio Calore e per aver detenuto
stupefacenti unitamente alla sola Furiozzi, nei confronti di Bongiovanni Ivano, dichiarando l’estinzione
del reato per intervenuta prescrizione;
– l’imputazione di calunnia aggravata dalla finalità di eversione, in relazione alle false accuse di omicidi
tra i quali quelli di Silvani Fedi e Manrico Bucceschi, nonché di più stragi, in danno di Licio Gelli, nei
Restano aperte ancora importanti istruttorie, relative alla specifica vicenda
dell’Italicus e al contesto eversivo in cui la stessa appare oggettivamente
inserita, che potranno ricevere importanti contributi dallo sviluppo delle indagini
milanesi condotte dal dottor Salvini.
Tuttavia l’ordinanza-sentenza appare esemplare per comprendere quanto
negativamente incidano in indagini di tal tipo sia gli effetti formali del decorso
del tempo, con l’intervento di cause di estinzione di reati, anche gravi, per
prescrizione, sia gli esiti processuali assolutori intervenuti medio tempore in
altre sedi.
Questi ultimi assumono una duplice valenza negativa, tanto per l’impossibilità di
un secondo giudizio (e quindi per l’effetto preclusivo naturalmente connesso al
giudicato), quanto per l’effetto, anch’esso formale, che il consolidamento di una
pronuncia su di un determinato episodio produce sulla possibilità di inserire
l’episodio stesso in uno sviluppo argomentativo più ampio, ogni volta che una
diversa valutazione di quello si appalesi di quest’ultimo passaggio ineludibile.
Sono ostacoli che ovviamente non sussistono ai fini di una valutazione diversa
da quella giudiziaria quale quella storico-politica che compete a questa
Commissione.
Ma soprattutto l’ordinanza-sentenza del dott. Grassi illustra come gli ostacoli e
depistaggi (che indagini tanto complesse hanno spesso subìto) possono, ove
opportunamente decifrati, contribuire utilmente alla ricostruzione per grandi
linee di un contesto unitario, ancorché non del tutto disvelato.
Quanto agli ostacoli ed ai depistaggi, sembra sufficente richiamare soltanto i
principali episodi.
Come si è già rammentato, l’ordinanza-sentenza del 3 agosto 1994 dichiara la
prescrizione dell’imputazione di favoreggiamento aggravato elevata nei
confronti del col. Domenico Tuminello, comandante del Gruppo Carabinieri di
Arezzo.
Quest’ultimo nell’agosto-settembre del 1974 (e cioè nell’immediatezza
temporale della strage) riceveva dal gen. Bittoni, comandante dell’8^ Brigata
Carabinieri di Firenze, una segnalazione relativa ai nomi (Franci e,
probabilmente, Malentacchi e Batani) di tre soggetti che, secondo informazioni
provenienti dalla federazione MSI di Arezzo, sarebbero stati implicati nella
strage; è lo stesso Bittoni a rivelare tale circostanza al P.M. di Bologna nel
confronti di Federigo Mannucci Benincasa e Umberto Nobili, ordinandone il rinvio a giudizio innanzi alla
Corte di Assise di Bologna;
– le impostazioni di favoreggiamento e abuso continuati e aggravati dalle finalità di eversione, minacce a
pubblico ufficiale, tentata sottrazione di documenti sottoposti a sequestro, in relazione alle attività illecite
dispiegate nella qualità di direttore del centro SISMI di Firenze per ostacolare le indagini sulle attività
eversive di Augusto Cauchi, nonché per ostacolare gli sviluppi istruttori sulla propria posizione, nei
confronti di Federigo Mannucci Benincasa, ordinandone il rinvio a giudizio innanzi alla Corte di Assise
di Bologna.
Pertanto la sentenza-ordinanza, sempre con riferimento agli ambiti temporali considerati, trasmette agli
atti:
– alla procura di Bologna per l’ulteriore corso delle indagini contro gli ignoti autori della strage
dell’Italicus;
– alla procura di Roma in ordine alle ipotesi di cospirazione politica e attentato contro la Costituzione dello Stato
delineabili nell’intero arco temporale compreso tra il 1969 e il 1982 a carico di Gian Adelio Maletti, Antonio Labruna,
Giancarlo D’Ovidio, Federigo Mannucci Benincasa, Umberto Nobili, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte, Licio
Gelli.
dicembre 1981, chiarendo di aver ricevuto a sua volta la notizia dall’amm.
Birindelli, politicamente inserito nelle fila di quel partito.
E’ di tutta evidenza che si trattava di un’acquisizione del massimo interesse
investigativo ove essa fosse stata resa nota e sviluppata nell’immediatezza.
L’inutilizzazione della fonte appare di notevole gravità, anche perché,
contrariamente a quanto sostenuto dall’imputato, venne dallo stesso omessa
ogni indagine sul fondamento della segnalazione e sulle fonti da cui proveniva.
Ciò assume rilievo più marcato sulla base dell’accertata affiliazione alla loggia
P2 del Tuminello, del Bittoni e del Birindelli nell’ambito dei nessi – tra l’eversione
di destra e ambienti P2 – oggi desumibili da plurimi e convergenti sviluppi in
diverse sedi giudiziarie.
Un ulteriore ostacolo all’accertamento della verità fu il risultato
dell’inquinamento probatorio derivante dal ruolo giocato da Ivano Bongiovanni,
proveniente da ambienti della criminalità comune, che negativamente si
ripercosse in ben quattro istruttorie (quella sui fatti di Teramo, di cui si dirà,
quella sulla strage di piazza della Loggia e quella concernente l’Italicus e la
stazione di Bologna).
Per ciò che riguarda l’inchiesta sull’Italicus, l’effetto inquinante riguarda in
particolare la collaborazione di Valerio Viccei, un estremista di destra di origine
ascolana inserito in un gruppo eversivo locale.
Viccei era approdato all’intento di collaborare con la giustizia ed era stato
sentito specificamente nell’istruttoria per l’Italicus nel marzo del 1985 in merito
ai collegamenti, particolarmente intensi, esistenti negli anni ’71-’74 tra il gruppo
di Ascoli e il composito sodalizio milanese che raccoglieva al suo interno
persone di alto livello provenienti da organizzazioni quali Ordine Nuovo,
Avanguardia Nazionale, Ordine Nero, MAR.
A costoro sarebbe risalita l’elaborazione e l’esecuzione di un disegno
terroristico che doveva comportare l’esecuzione di quattro attentati di tipo
stragista, tra i quali quello dell’Italicus. La cellula ascolana avrebbe avuto un
diretto ruolo operativo nell’attuazione di tale disegno preparando ed eseguendo
l’attentato ferroviario a Silvi Marina, in provincia di Teramo.
Le dichiarazioni di Viccei convergevano peraltro con precedenti dichiarazioni
(Andrea Brogi) e trovavano conforto in numerosissimi dati di riscontro raccolti
nell’ambito di diverse istruttorie4
. Orbene il Buongiovanni, che aveva
4
Per una migliore comprensione del progetto si considerino i seguenti elementi:
– esistenza già nel ’71-’72 di una cellula paramilitare ascolana contigua al Fronte della gioventù di quella
città;
– appartenenza a tale cellula di Ortenzi Giuseppe e Marini Pergiorgio; passaggio del controllo sulla cellula
ascolana dal Nardi Gianni all’Esposti Giancarlo;
– colloquio con l’Esposti del marzo-aprile ’74 nel corso del quale il Viccei apprende per la prima volta
(dopo che già era avvenuto l’attentato di Silvi Marina): a) che i milanesi intendevano portare avanti un
progetto terroristico comprensivo dell’esecuzione di quattro stragi e avevano individuato le ferrovie come
obiettivo preferenziale; b) che vi era stato un dissidio di fondo tra il Nardi e il gruppo milanese in quanto
il primo non si sentiva di eseguire la strategia stragista che era stata decisa; c) che l’attentato di Silvi
Marina era stato preparato dal Marini e da due milanesi dei quali l’Esposti non fece il nome, i quali inoltre
assistettero l’Ortenzi mentre questi installava l’ordigno sui binari; d) che l’attentato in questione avrebbe
dovuto essere la prima delle stragi volute dal gruppo milanese da eseguirsi nel 1974 nel contesto di un
piano di destabilizzazione e di sovvertimento delle istituzioni; e) che l’attentato era fallito a seguito di un
errore tecnico dell’Ortenzi, ma che negli inten0ti degli esecutori e degli ideatori avrebbe dovuto provocare
una vera e propria strage;
– colloquio con l’Ortenzi, nel corso del quale quest’ultimo, dopo qualche resistenza, conferma nella
sostanza il racconto dell’Esposti in ordine all’attentato di Silvi Marina, ma ne addebita l’insuccesso al
comportamento tenuto dai milanesi durante la collaborazione dell’ordigno sui binari;
inizialmente reso all’A.G. di Bologna dichiarazioni di un qualche interesse sui
suoi rapporti con Giancarlo Rognoni, Cesare Ferri e Mario Tuti, tentò dapprima
di minare l’attendibilità delle collaborazioni che andavano rendendo importanti
estremisti di destra (Angelo Izzo, Raffaella Furlozzi e Sergio Calore),
accusandoli di aver progettato un presunto tentativo di evasione dal carcere di
Paliano dove erano ristretti insieme allo stesso Bongiovanni. Successivamente
quest’ultimo – contattato più volte in carcere da agenti dei servizi – riferiva al G.I.
di Teramo, nel giugno 1986, di aver subito richieste dal Viccei e dall’Izzo di
fornire ai magistrati inquirenti elementi di supporto e riscontro alle versioni da
loro rese, anche dichiarando fatti da lui non conosciuti o di cui poteva
conoscere la falsità. La versione di Bongiovanni interveniva in un momento
decisivo per lo sviluppo istruttorio e processuale del contributo dei collaboratori;
a poco sarebbe in questo senso valsa la successiva ritrattazione con la quale il
Bongiovanni riaffermava la verità di quanto da lui inizialmente riferito e la falsità
delle accuse agli altri .
Nella stessa ordinanza dell’agosto del 1994 il G.I. di Bologna esprime forti
perplessità sui reali motivi della sortita di tale personaggio, non senza
evidenziare i suoi legami con la banda della Magliana e con Mino Pecorelli.
Ancor più rileventi – in una prospettiva di insieme che si raccordi ai rilievi sulle
iniziative assunte dal SID nelle indagini giudiziarie su piazza Fontana – appare
l’azione di copertura posta in atto da un ufficiale del servizio, Mannucci
Benincasa, direttore del centro Sid e poi Sismi di Firenze, in favore di Augusto
Cauchi, elemento centrale nell’ambiente eversivo toscano.
L’ufficiale aveva avuto un contatto personale con il Cauchi a Firenze già nel
1974, prima dell’attentato dell’Italicus. Ma tanto fu ammesso in sede giudiziaria
dal Mannucci Benincasa soltanto nel 1982 e solo dopo che gli era stato
contestato quanto in merito dichiarato dall’amm. Casardi.
Risulta altresì, in termini di sostanziale certezza, che nel 1975, quando già le
indagini si erano rivolte verso l’ambiente eversivo toscano, il Mannucci
Benincasa ricevette indicazioni che avrebbero consentito il reperimento e la
cattura del Cauchi.
Il Mannucci Benincasa non fece pervenire l’informazione alla polizia giudiziaria
ma, secondo quanto da lui stesso riferito, concordò un incontro con il dott.
Marsili, p.m. di Arezzo : incontro che tuttavia non si realizzò.
A ciò si aggiunga che, in una perizia disposta dal G.I. di Roma nei confronti di
Gelli sulla tenuta dei fascicoli del centro Sismi di Firenze,
– colloquio con l’Ortenzi, nell’estate del 1975, nel corso del quale quest’ultimo riferisce al Viccei che sia la
strage di Brescia che quella dell’Italicus erano opera del gruppo dei milanesi cui aveva fatto capo la
cellula di Ascoli;
– individuazione di alcuni dei referenti milanesi della cellula ascolana e, in particolare, indicazione del
Ballan e del Rognoni come persone collocate ai vertici del gruppo; contatti personali e telefonici tra i
predetti e l’Esposti;
– notizie apprese dal Marini in ordine alla latitanza di quest’ultimo e in particolare rapporti di quel periodo
tra il Marini, il Rognoni e il Concutelli;
– rapporti tra l’Esposti e ufficiali delle Forze Armate di stanza nel Veneto;
– trasporto a villa Nardi in epoca prossima alla Pasqua del ’74, di armi ed eplosivo; coinvolgimento in tale
attività del Marini, dell’Ortenzi, dell’Esposti e dello stesso Viccei;
– indicazione dei luoghi ove al tempo dei fatti l’Ortenzi e il Marini erano soliti occultare armi ed esplosivi;
– colloquio con il Marini risalente al 1980 durante il quale quest’ultimo conferma la versione dell’Esposti in merito
all’attentato di Silvi, addebita l’insuccesso all’irresponsabilità dell’Ortenzi ed esprime comunque soddisfazione per il
fatto che non vi siano state vittime.
forti perplessità sono evidenziate proprio in ordine ad un incartamento sul
Cauchi così come in merito ad un appunto relativo a quest’ultimo, mancante
dalle carte del Servizio e che fu rinvenuto, invece, nel corso di una
perquisizione presso l’abitazione del Mannucci Benincasa.
Per comprendere la complessità e insieme la rilevanza degli intrecci va
rammentato, da un lato, che Manucci Benincasa è una delle fonti “anonime”
che inizialmente indirizzarono verso Gelli le indagini dell’A.G. romana
sull’omicidio Pecorelli ed è stato imputato dal G.I. Zorzi, unitamente ad Umberto
Nobili, di altre gravi calunnie nei confronti di Gelli; da un altro, che il
collegamento tra il Mannucci Benincasa ed il Cauchi era passato, all’inizio,
attraverso il professor Luigi Oggioni, affiliato alla P2, intimo di Gelli, ortopedico
di fiducia del Sismi di Firenze; da un altro lato ancora, il ruolo avuto dal dott.
Mario Marsili, genero di Gelli e successivamente affiliato alla P2, sull’altalenante
contributo processuale reso da Alessandra De Bellis, moglie di Augusto Cauchi.
Appare quindi indubbio che il gruppo eversivo toscano, nel suo collegamento
con gli ambienti P2, abbia goduto di protezioni istituzionali non diversamente
dal gruppo padovano in ordine all’indagine su piazza Fontana.
Basterà in merito ricordare che il G.I. presso il tribunale di Firenze, dottor
Rosario Minna, che indagava su vari attentati a treni avvenuti in Toscana tra il
1974 ed il 1983, l’8 novembre 1984 chiese al direttore del SISMI di fornirgli le
notizie in suo possesso sul conto di persone, organizzazioni ed attentati
terroristici indicati in un elenco accluso. Dopo varie risposte interlocutorie, nel
gennaio 1985, il SISMI oppose il segreto di Stato ed il 28 marzo dello stesso
anno il Presidente del Consiglio lo confermò.
Solo successivamente fu possibile acquisire in sede giudiziaria un documento
relativo ad un rapporto del centro SISMI di Firenze del 20 dicembre 1977 dal
quale risulta che fin dalla primavera del 1974 Augusto Cauchi era diventato
collaboratore del locale centro D.
Tale copertura assume rilievo avuto riguardo a risultanze decisamente
significative per definire il livello di partecipazione dell’ambiente dell’eversione
nera toscana alla strategia attuata fino al 1974.
Le fonti di tali acquisizioni sono analiticamente riportate nell’ordinanza-sentenza
del G.I. Grassi e consistono principalmente negli apporti processuali di Andrea
Brogi, Marco Affatigato, della già ricordata Alesandra De Bellis, di Graziano
Gubbini e Vincenzo Vinciguerra, nonché nella documentazione sequestrata in
America a Delle Chiaie.
Peraltro le risultanze dell’istruttoria, pur prive di caratteri di definitività e
compiutezza probatoria per affermazioni in sede giudiziaria, segnalano una
direzione ricostruttiva del raccordo di strategie nelle quali si colloca l’attentato al
treno Italicus.
Appare quindi ampiamente giustificata l’esigenza di approfondire ulteriormente
tanto le dinamiche interne all’estrema destra dopo la delusione delle aspettative
golpiste del 1970, quanto i momenti di convergenza operativa tra i fautori della
guerra non convenzionale in funzione anticomunista e quanti, sempre a destra,
aspiravano ad una svolta di tipo autoritario.
L’ulteriore ricerca degli esecutori materiali dell’attentato e dei mandanti non può
prescindere dall’individuazione di coloro che hanno “gestito” l’attentato stesso,
prima e dopo il suo verificarsi, sia sotto i profili della informativa e della
sicurezza, sia nella dimensione giudiziaria.
In tale gestione già emerge la rilevanza dei rapporti Cauchi-Gelli, GelliMannucci Benincasa, Cauchi-Mannucci Benincasa, rapporti che attraversano e
continueranno ad attraversare l’attivismo dei vertici di Avanguardia Nazionale e
di Ordine Nuovo.
 8975_1_italicus-misteriditalia.it
8975_1_italicus-misteriditalia.it