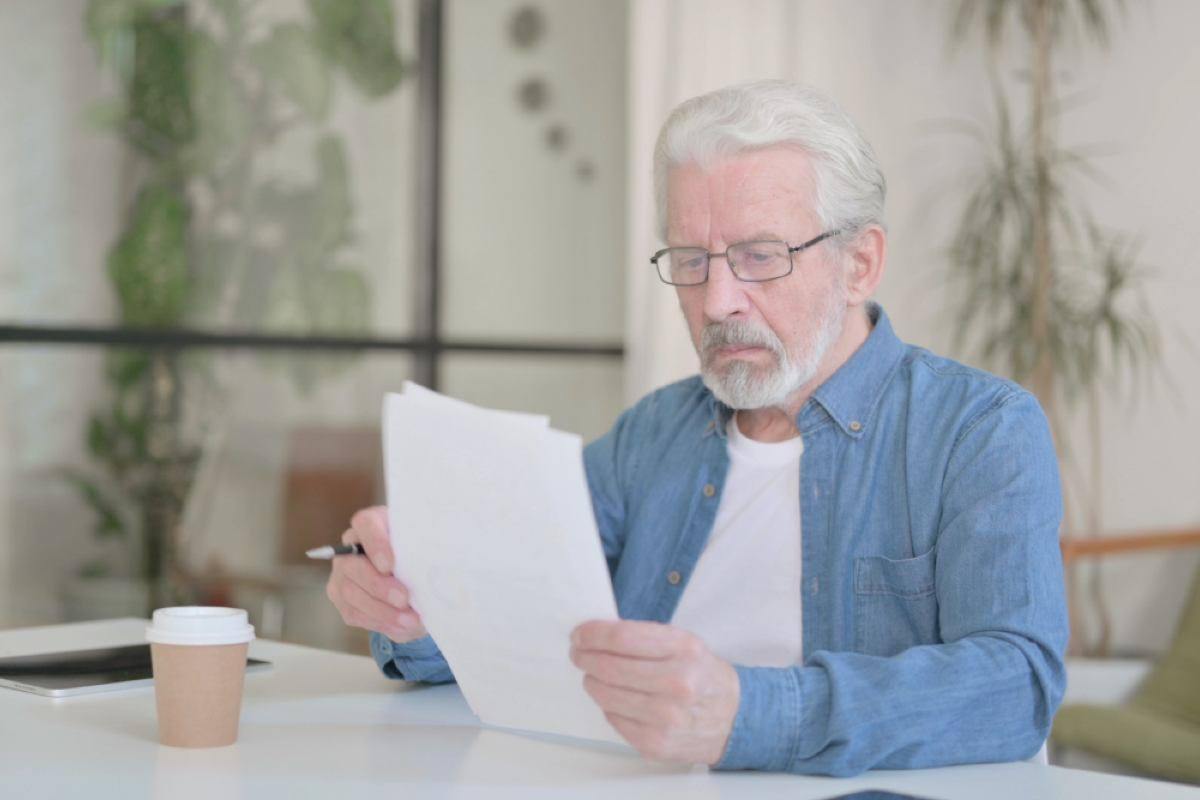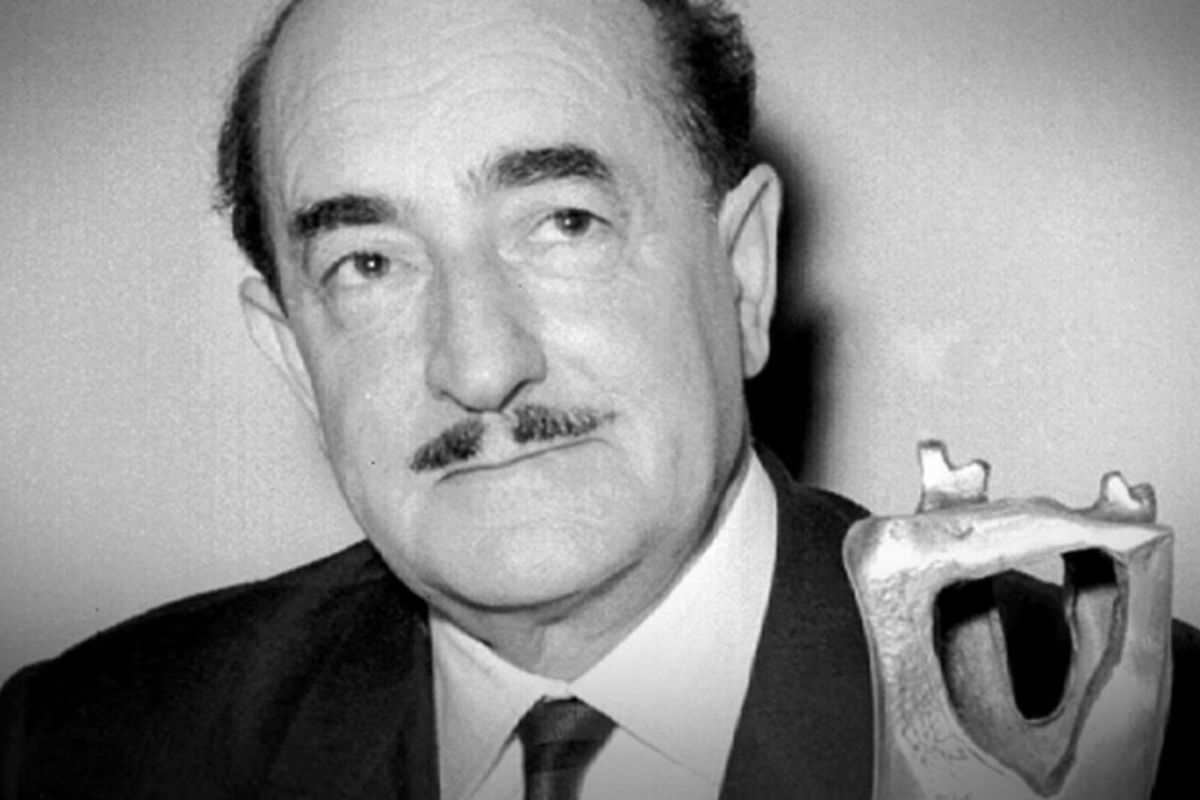Tra carte sigillate, archivi sotterrati e decreti ignorati, l’Italia custodisce ancora un patrimonio di verità non dette — verità che lo Stato ha deciso di coprire dietro il vincolo del “segreto di Stato”. Ma cosa proteggono davvero questi segreti? E quanto ce ne è negato?
Oltre la luce dei riflettori
In un sistema democratico moderno, ci si aspetterebbe che il potere sia trasparente, che la storia ufficiale riconosca le proprie zone d’ombra e che i cittadini possano almeno sapere quali pagine sono state cancellate. Eppure, in Italia, esiste una dimensione del “non-sapere consentito”, un’ombra nella quale si muovono atti, documenti, notizie che nessuno può depositare all’archivio della memoria pubblica.
La legge parla chiaro: la Legge 3 agosto 2007, n. 124 definisce il segreto di Stato come quel vincolo che può essere apposto sugli atti, documenti, notizie, attività o cose la cui divulgazione «sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto ad altri Stati e alle relazioni con essi».
Questo vuol dire: se un documento rischia di far tremare l’apparato istituzionale oppure espone alle relazioni internazionali una falla grave, può essere nascosto — non solo temporaneamente, ma potenzialmente per decenni.
Un vincolo che dura e pesa
Il segreto di Stato ha delle regole: non può coprire fatti di strage, terrorismo, reati mafiosi o eversivi dell’ordinamento costituzionale. Ma al di là di questo limite, la porta resta aperta a un numero indefinito di atti che «non possono essere soggetti a trasparenza», almeno non immediatamente.
Va dichiarato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Eppure, come ricorda una riflessione critica sulla materia, «non sappiamo neppure quanti siano i segreti di Stato» depositati negli archivi italiani.
E questa che sembra una assenza di numero diventa un silenzio organizzato: la memoria ufficiale che non conosce le proprie cancellazioni, lo Stato che protegge la propria immagine più che gli atti.
Le carte che nessuno apre
Ci sono vicende note, come il caso strage di Ustica o lo scandalo strage dell’Italicus, in cui parte della documentazione è stata desecretata dopo decenni. Ma accanto a questi esempi ce ne sono molti altri dove il vincolo permane, spesso perché la soglia di “danno all’integrità della Repubblica” è interpretata in modo elastico.
Come quando si è scoperto che un archivio interno del SISMI documentava l’intercettazione di magistrati e giornalisti: la risposta ufficiale fu che si trattava di «motivi istituzionali», e il segreto fu opposto.
In queste situazioni, il cittadino resta di fronte a un muro: una domanda che non può essere risposta, un fascicolo chiuso, uno Stato che decide quanto può sapere.
Perché i segreti restano segreti
Ci sono motivi concreti: la difesa, la sicurezza nazionale, accordi internazionali che impongono vincoli. Ma ci sono anche motivi meno dichiarati: la paura che certe verità possano minare la fiducia collettiva, rivelare intrecci scomodi tra istituzioni, imprese e potere occulto. Un documento ben conservato in archivio può significare che non si dovrà mai affrontare un passato gravato da responsabilità.

Segreti di Stato (Ansa)
Una ricerca accademica evidenzia che il segreto di Stato serve non solo a proteggere, ma anche a ordinare l’ignoto: chi sa, decide cosa resti nascosto e cosa emerga.
Così, dietro la facciata democratica, il potere costruisce una doppia realtà: quella visibile e quella che resta nell’ombra.
Quando la desecretazione diventa teatro
Nel 2014 la Matteo Renzi-governo fece una direttiva per declassificare atti relativi alle grandi stragi italiane. Più di recente, l’attuale esecutivo ha annunciato che il segreto di Stato sarà usato «solo nei casi in cui ciò si renda indispensabile».
Ma la domanda rimane: una dichiarazione d’intenti basta a cambiare decenni di burocrazia, archivi chiusi, pratiche che resistevano all’apertura? Perché il segreto non si rompe solo con un decreto, ma con un atteggiamento culturale — il riconoscere che lo Stato può avere torto, che alcune verità appartengono ai cittadini non come curiosità ma come diritto.
Il prezzo dell’ignoranza consentita
Quanto costa alla collettività non sapere? Primo, il trauma della verità negata: famiglie che aspettano da decenni, società che resta prigioniera delle proprie zone d’ombra.
Secondo, la distorsione del potere: quando non sai come si è deciso, da chi, perché, non puoi valutare la scelta pubblica e non puoi partecipare davvero.
E infine, la memoria interna che resta incompleta: senza conoscere ciò che è stato nascosto, il Paese non può imparare. Ogni deposito segreto è un capitolo non raccontato.
Non è un atto di accusa contro lo Stato: è la constatazione che la trasparenza è un dovere, e che un sistema democratico che si sottrae alla luce rischia di abdicare al suo stesso fondamento.
I segreti di Stato che non possono essere desecretati non sono soltanto pagine sigillate: sono storie che non possiamo ancora raccontare, domande che non possiamo ancora fare, ferite che non possiamo ancora chiudere.
E allora forse la domanda più sincera che ognuno di noi dovrebbe rivolgere non è “Cosa nasconde l’Italia?”, ma “Perché ho accettato che certe cose restino nascoste?”
 Segreti di Stato (Ansa)
Segreti di Stato (Ansa)