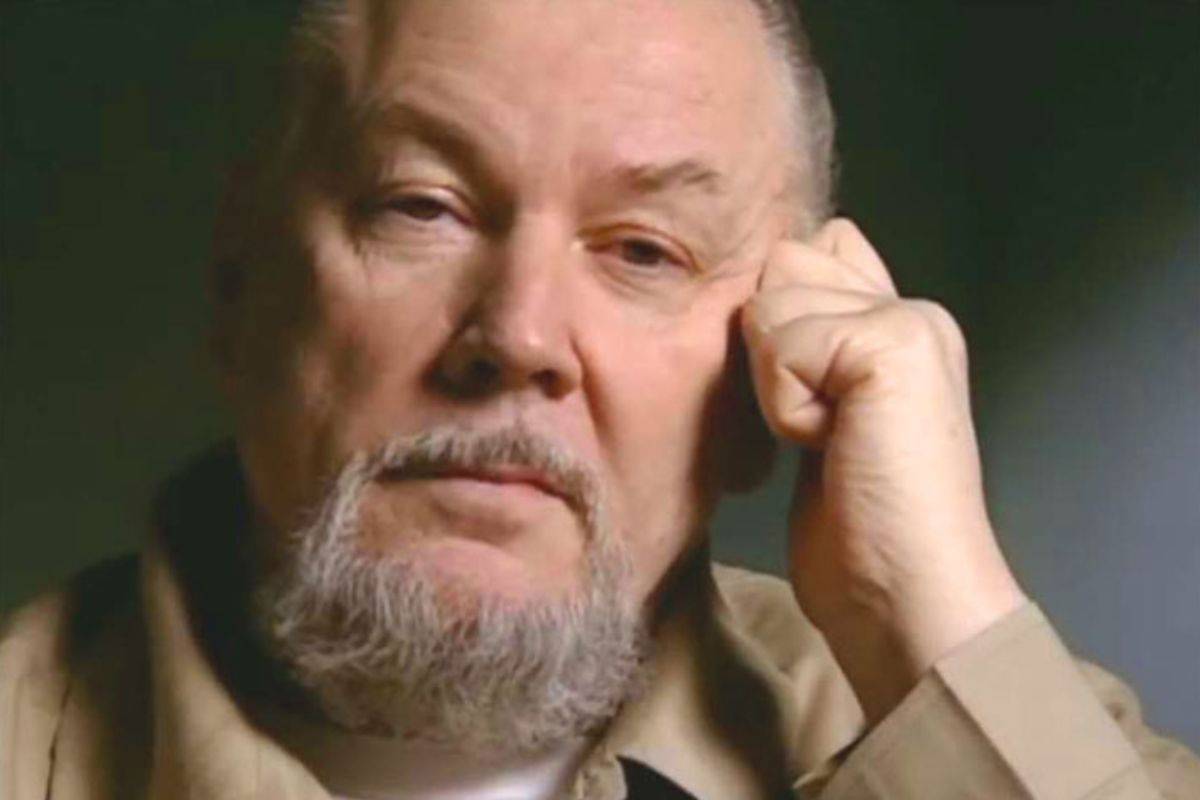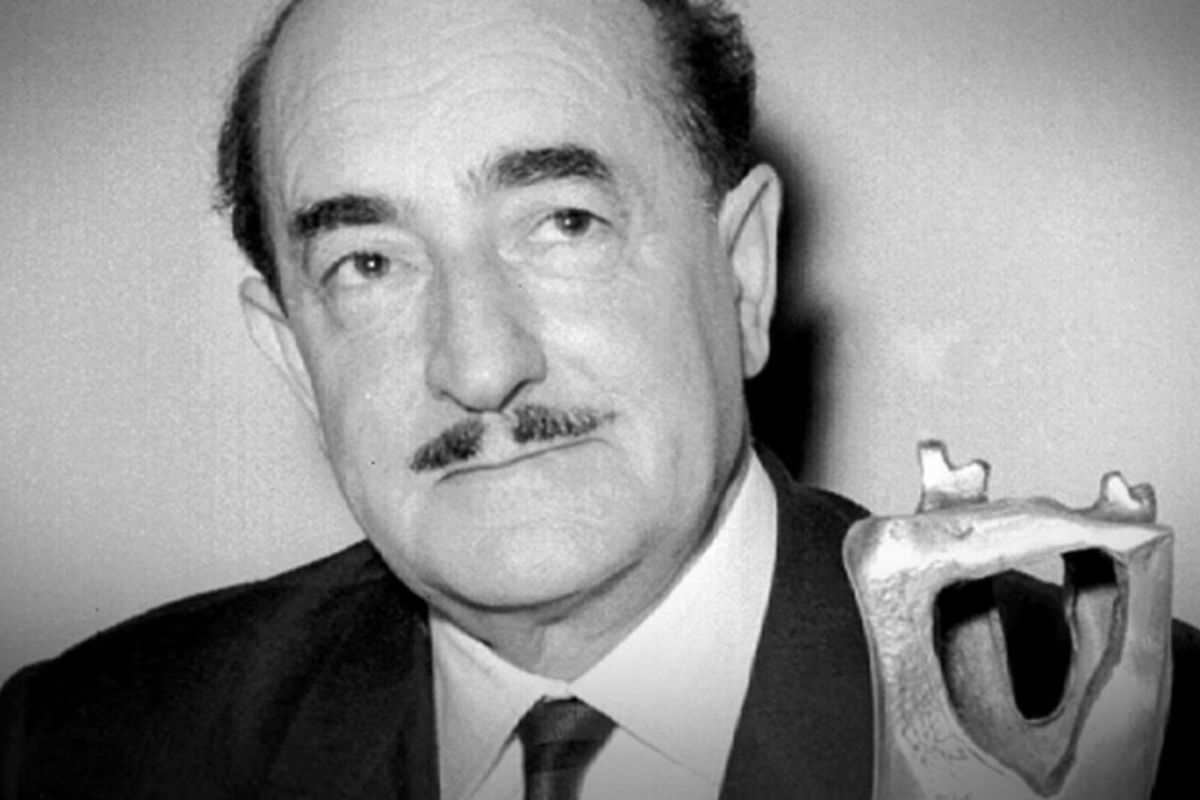Stragi, incidenti aerei, omicidi eccellenti e depistaggi: il secolo scorso in Italia è un archivio di tragedie che sembrano scollegate, ma che, a guardarle bene, condividono gli stessi protagonisti, le stesse dinamiche e gli stessi silenzi. Coincidenze? O i frammenti di una stessa, oscura verità?
Un secolo di misteri e di sangue
L’Italia del Novecento è un Paese che ha conosciuto la guerra, la ricostruzione, la speranza e la paura. Ma è anche una nazione che, più di ogni altra in Europa, ha visto le proprie tragedie trasformarsi in enigmi irrisolti.
Da Piazza Fontana a Ustica, da Bologna a Via Fani, da Mattei a Moro, ogni volta che la storia sembrava chiedere giustizia, arrivava un muro: documenti spariti, testimoni scomparsi, segreti di Stato.
Gli storici la chiamano “strategia della tensione”, i cittadini, più semplicemente, la chiamano coincidenza.
Ma quante coincidenze possono accumularsi prima di diventare un disegno?
Gli anni delle bombe: la nascita del dubbio
Tutto comincia il 12 dicembre 1969, quando una bomba esplode nella Banca Nazionale dell’Agricoltura di Milano, uccidendo 17 persone. È la strage di Piazza Fontana, il primo grande trauma della Repubblica. Da lì in poi, l’Italia entra in una spirale di violenza e ambiguità.
A pochi mesi di distanza, un altro nome comincia a ricorrere nei rapporti investigativi: Ordine Nuovo, gruppo neofascista legato a reti internazionali di estrema destra e, secondo alcune testimonianze, in contatto con settori dei servizi segreti. Gli stessi servizi che, nei decenni successivi, compariranno — direttamente o indirettamente — in quasi tutte le principali tragedie nazionali.
Dopo Milano, arrivano Brescia, Bologna, l’Italicus. Ogni volta cambiano le sigle, ma gli uomini e i metodi restano gli stessi. E ogni volta le piste si perdono tra depistaggi e segreti d’ufficio.
Mattei, Moro, Ustica: la geometria del sospetto
Ci sono nomi che ritornano come capitoli di un’unica storia. Il primo è Enrico Mattei, presidente dell’ENI, morto nel 1962 in un misterioso incidente aereo. Ufficialmente un guasto. In realtà, come dimostrano perizie successive, un’esplosione. Mattei dava fastidio a troppi: alle “Sette Sorelle”, ai poteri americani, alle relazioni troppo autonome dell’Italia con i Paesi arabi.
Sedici anni dopo, un altro incidente aereo scuote il Paese: Ustica, 27 giugno 1980, 81 vittime. Un DC-9 Itavia scompare dai radar e precipita in mare. Le indagini parlano di “missile”, di “collisione in volo”, di “combattimento militare”. E tra i documenti secretati emergono sigle NATO, comunicazioni francesi e americane, ordini di silenzio.
Un altro caso dove la verità è stata più protetta che cercata.
Nel 1978, nel cuore di Roma, Aldo Moro viene rapito e ucciso dalle Brigate Rosse. Ma attorno al suo sequestro si muovono, ancora una volta, servizi segreti divisi, informatori doppi, zone grigie. Le stesse sigle che compaiono nei dossier di Ustica, e perfino in quelli del caso Mattei.
Tre episodi lontani nel tempo e nello spazio, ma uniti da una costante: l’intreccio tra interessi internazionali e opacità istituzionale.
Le trame invisibili della politica
C’è un filo che lega molte di queste tragedie, ed è il rapporto ambiguo tra Stato e potere occulto.
Dopo la scoperta della loggia massonica P2, nel 1981, il Paese capisce che per anni una rete segreta di militari, politici e imprenditori ha influenzato scelte economiche, militari e giudiziarie.
Tra gli iscritti compaiono ufficiali dei servizi, direttori di giornali, ministri, persino uomini coinvolti nelle inchieste su Ustica e Bologna.
È la dimostrazione che l’Italia ha vissuto per decenni dentro una doppia verità: quella ufficiale, raccontata ai cittadini, e quella reale, custodita nelle stanze del potere.
Ogni volta che una tragedia minacciava di scoprire troppo, un nuovo scandalo esplodeva per distrarre, spostare, confondere.
Un meccanismo perfetto, una regia invisibile che ha saputo sopravvivere a governi, crisi e rivoluzioni.
Le coincidenze che fanno paura
A guardarle da vicino, le grandi tragedie italiane del Novecento sembrano muoversi secondo una logica misteriosa, quasi circolare. Ogni evento richiama il precedente, ne cita il linguaggio, ne ripete gli errori e le omissioni.
Quando nel 1992 Giovanni Falcone salta in aria sull’autostrada di Capaci, molti ricordano le parole di Moro: “Lo Stato uccide due volte, la seconda con il silenzio.”
Pochi mesi dopo, a via D’Amelio, muore Paolo Borsellino, e le carte della sua agenda rossa — che forse contenevano informazioni su Gladio, mafia e politica — spariscono nel nulla.

Una delle auto dell’attentato a Giovanni Falcone (Ansa)
Come erano scomparse le bobine dei radar di Ustica, come erano stati distrutti i documenti del caso Mattei, come erano stati secretati i rapporti sui legami tra P2 e servizi segreti.
Coincidenze, ancora una volta, ma troppe per essere ignorate.
Gli uomini che ricorrono
Ci sono anche nomi che ritornano. Funzionari dei servizi, investigatori, politici, magistrati. Uomini che compaiono in più di un’inchiesta, con ruoli diversi ma sempre nello stesso punto: quello in cui la verità si interrompe.
Alcuni di loro, negli anni, hanno ricevuto promozioni, incarichi internazionali, riconoscimenti. Altri sono morti in circostanze dubbie. Tutti, in un modo o nell’altro, sono diventati parte di quella memoria distorta che l’Italia non riesce a guarire.
Il ruolo dell’informazione
C’è poi un altro elemento costante: il controllo dell’informazione, ogni grande tragedia italiana è stata anche una guerra di narrazioni.
Nel caso Mattei, la stampa minimizzò per anni le ipotesi di sabotaggio. Durante il caso Moro, molti giornali contribuirono a dipingere il leader democristiano come un uomo ormai sconfitto. Dopo Ustica, i media seguirono la pista del “guasto tecnico” per quasi un decennio.
La verità, spesso, non è stata negata, ma diluita. Raccontata in modo da sembrare improbabile, spinta ai margini, etichettata come complottismo prima ancora che come domanda legittima.
E così, ogni volta, l’opinione pubblica si è rassegnata.
L’Italia dei segreti di Stato
Molte delle tragedie del Novecento italiano sono ancora oggi coperte dal segreto di Stato. Ufficialmente per “ragioni di sicurezza nazionale”, ma in realtà perché toccano punti troppo sensibili del nostro passato.
La legge prevede che, dopo cinquant’anni, i documenti possano essere declassificati. Ma anche quando ciò avviene, i fascicoli arrivano mutilati, le date alterate, i nomi oscurati.
È come se la verità fosse un rischio permanente per l’equilibrio del Paese. Come se ogni volta che si avvicina alla luce, qualcuno — in alto, ma non troppo visibile — preferisse spegnere l’interruttore.
Una memoria che non guarisce
Le grandi tragedie italiane del Novecento non sono solo fatti di cronaca: sono ferite ancora aperte nella coscienza collettiva. Perché un Paese che non conosce la propria verità è condannato a ripetere i propri errori, e l’Italia, da decenni, ripete lo stesso copione: indignazione, inchieste, silenzi, archiviazione.
Ogni generazione ha avuto il suo mistero irrisolto, e ogni mistero ha avuto lo stesso epilogo. La sensazione che qualcuno sappia, ma non voglia dire.
Ci sono Paesi che costruiscono la propria identità sulla verità, e altri che sopravvivono grazie all’oblio.
L’Italia, forse, appartiene a entrambe le categorie.
Un Paese che ricorda troppo, ma capisce troppo poco.
Che convive con le proprie ombre, le studia, le discute, le esorcizza, ma non le illumina mai fino in fondo.
Le coincidenze tra le grandi tragedie italiane del Novecento non sono solo cronologia e destino: sono il riflesso di un potere che non ha mai smesso di agire sotto traccia, che si rigenera ogni volta che la verità rischia di emergere.
E allora forse la vera domanda non è più se queste coincidenze siano reali o costruite,
ma perché, dopo un secolo, l’Italia continui ad averne così bisogno.
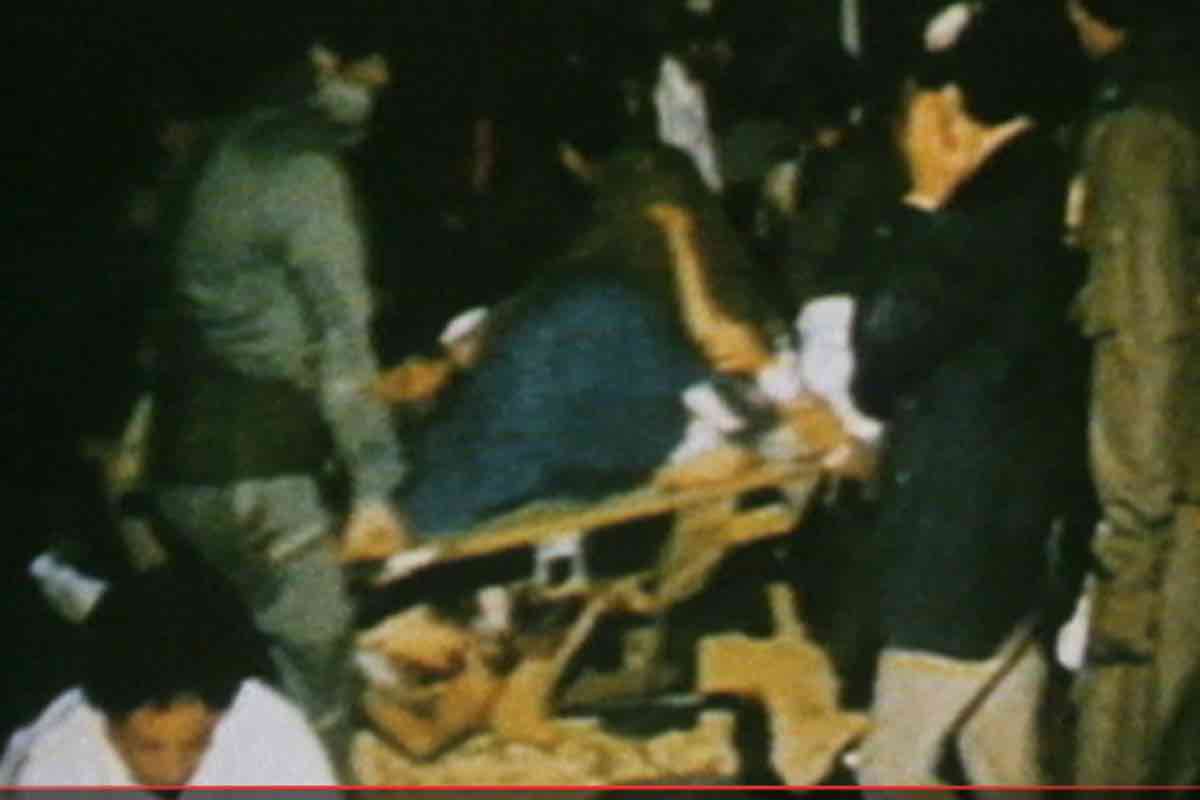 La strage di Bologna (Ansa)
La strage di Bologna (Ansa)