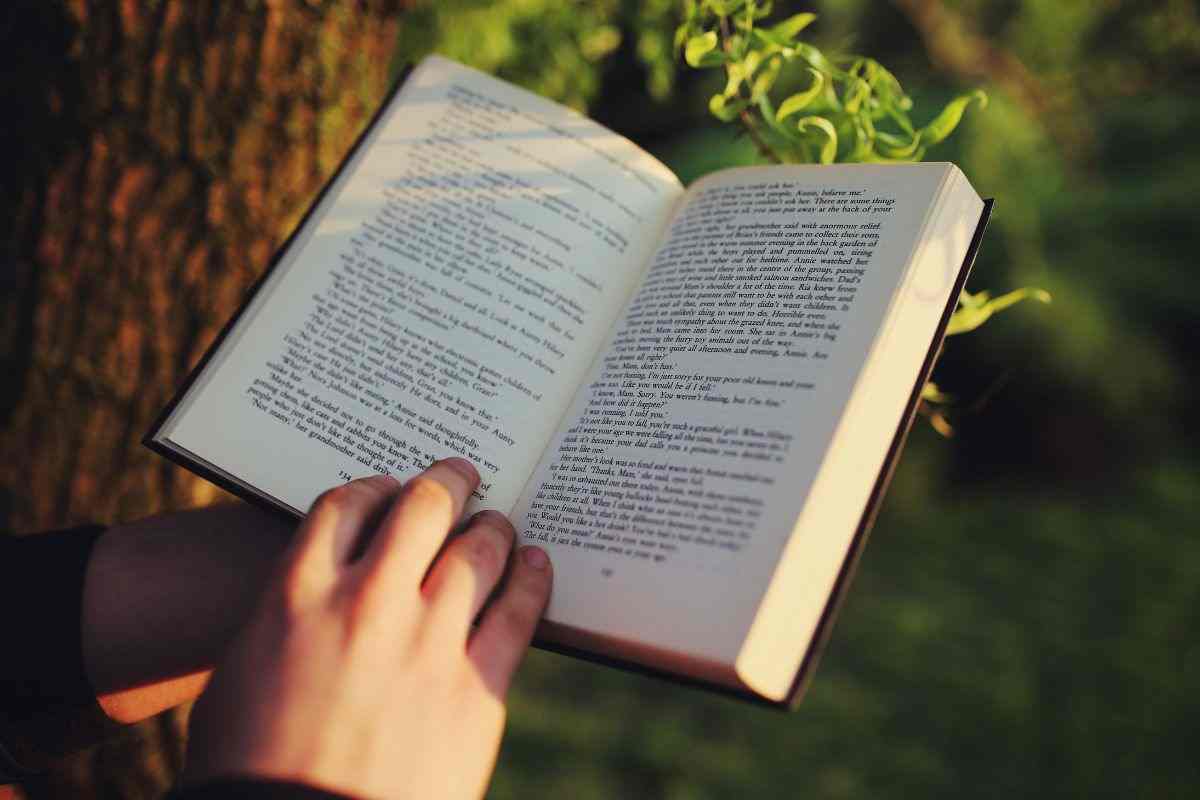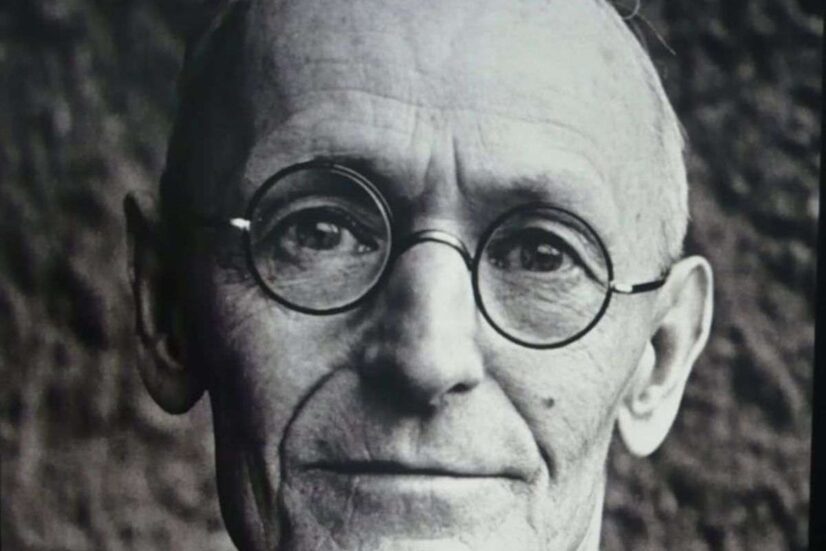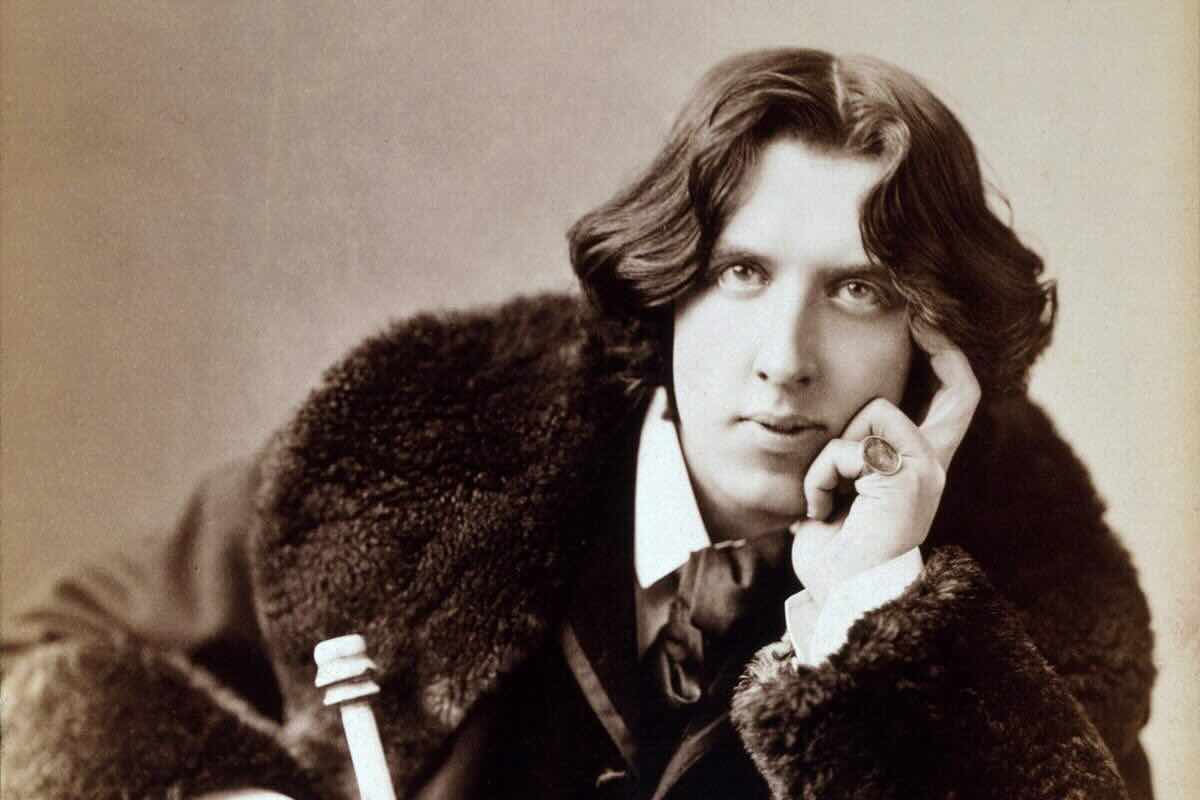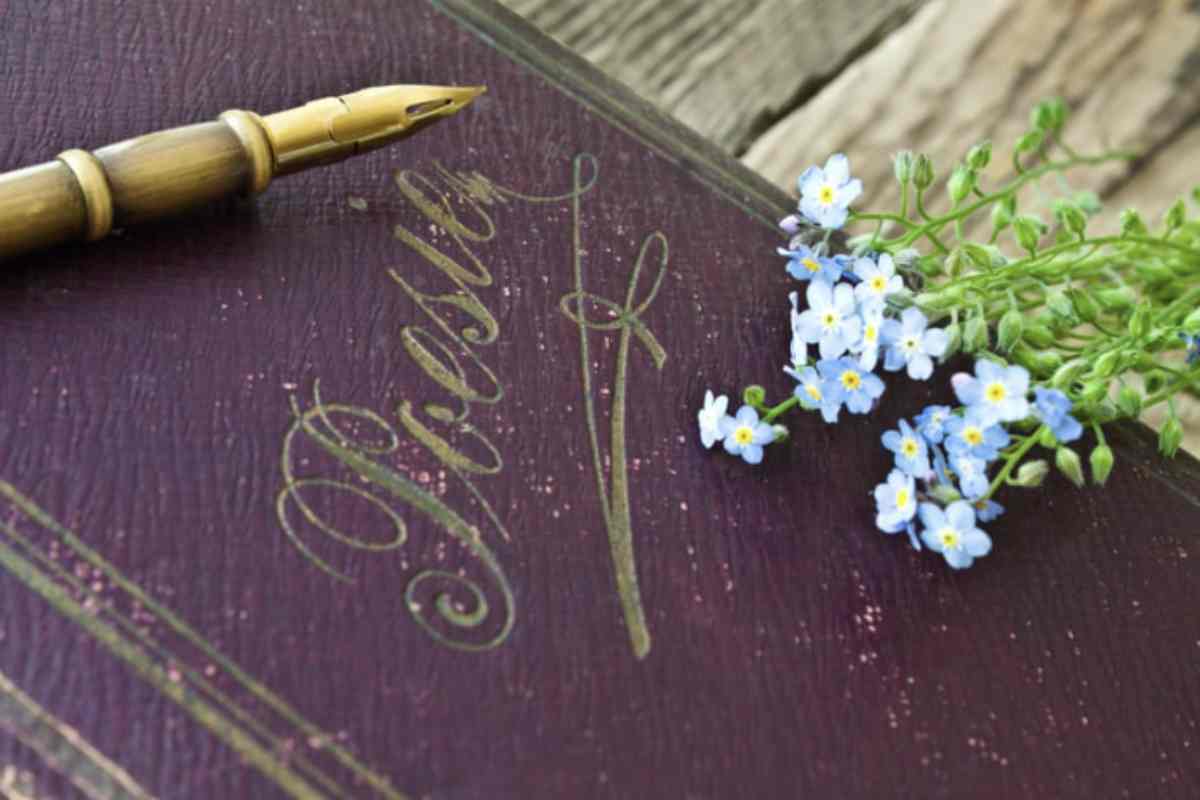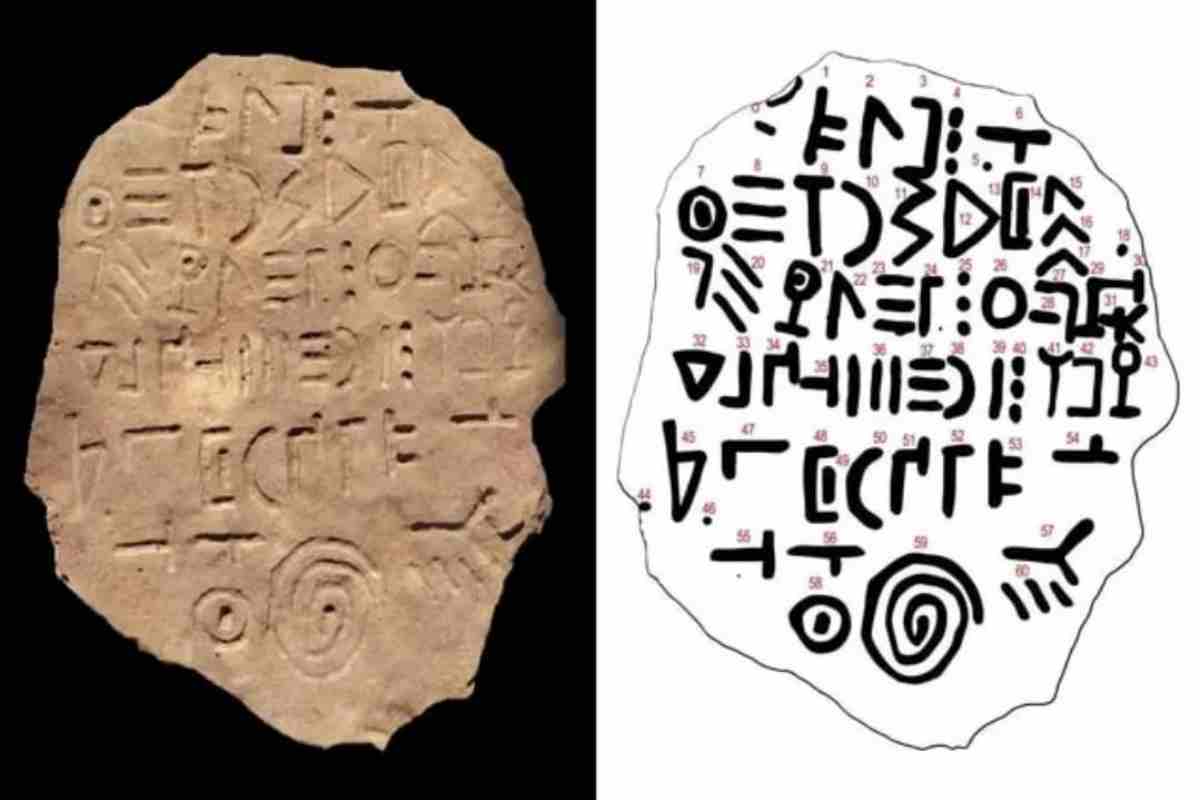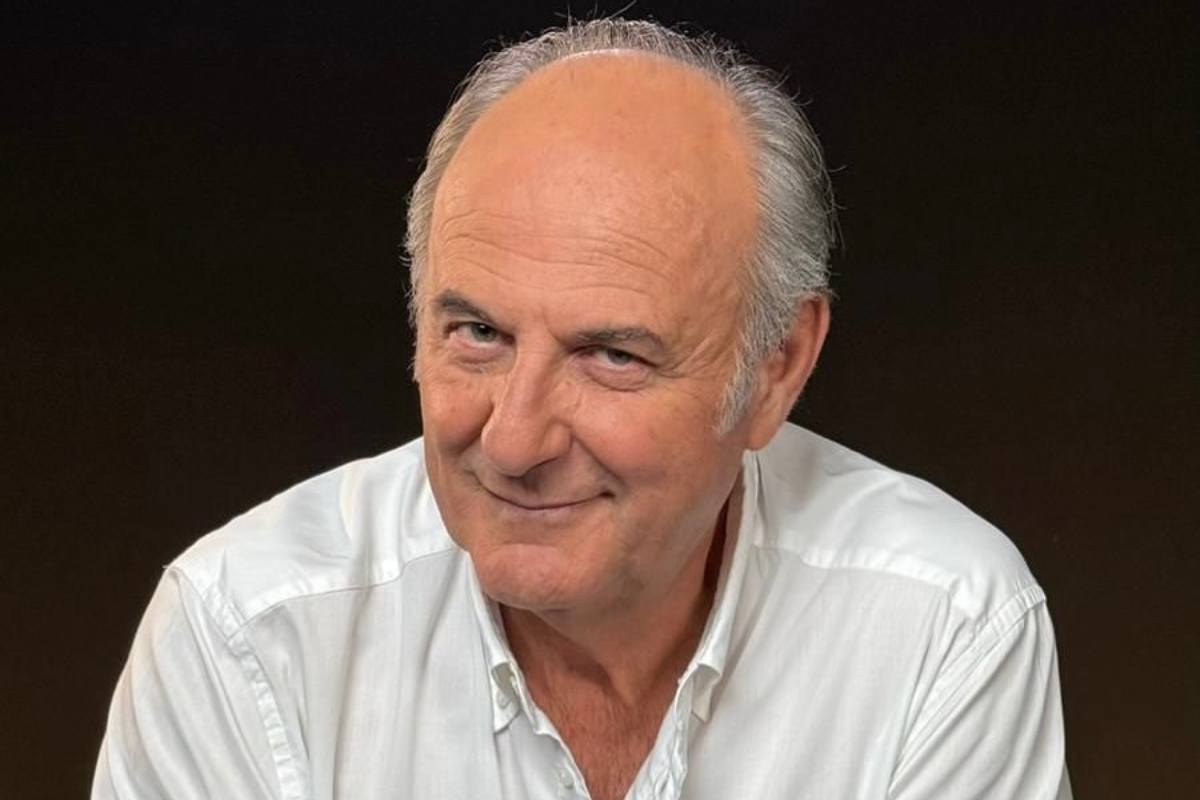Attraverso tale primo originario, quanto solido, nucleo di dichiarazioni accusatorie, intrinsecamente
attendibili e reciprocamente riscontrate, perché provenienti dagli stessi autori dell’orrenda strage, i
primi giudici, anche con il successivo ausilio delle propalazioni rese dagli altri collaboranti escussi
nel giudizio di prime cure, ritennero individuati sia degli esecutori materiali che dei mandanti della
strage, giungendo alle conclusioni che qui di seguito si rappresentano, riguardo alla posizione di
ciascuno.
BRUSCA GIOVANNI
Ad avviso dei primi giudici nessun dubbio residuava sulla diretta partecipazione di Brusca, reo
confesso, alle riunioni preliminari con Salvatore Riina – episodi su cui concordava Cancemi –
nonché alla fase esecutiva della strage, nel cui corso egli si era assunto l’orrendo compito di far
brillare la carica lanciando l’impulso radio con il telecomando.
L’imputato era stato presente in contrada Rebottone, anche nei momenti in cui si era proceduto
all’assemblaggio della ricevente e alle prove relative alla funzionalità dei detonatori. Invece, non
poteva ritenersi provata la sua presenza in occasione dell’arrivo dell’esplosivo portato da Giuseppe
Agrigento; la partecipazione al travaso dai sacchi ai bidoni del medesimo esplosivo; l’episodio
dell’arrivo dei telecomandi nascosti sul camioncino guidato da Rampulla, di cui si tratterà meglio
nella parte relativa alla posizione di Salvatore Sbeglia. Restavano altresì non sufficientemente
delineati l’incontro con Piediscalzi, le prove di velocità in contrada Rebottone e quelle svoltesi,
secondo l’assunto dell’imputato, attraverso l’interramento dei cinque chilogrammi di esplosivo
procurato da Salvatore Biondino.
Quanto alla fase del trasporto da Altofonte a Capaci, risultava pienamente confermata la presenza di
Brusca, anche se non era emerso da nessun altro collaboratore il dato relativo alla sosta
dell’esplosivo nella casa di tale Romeo.
Per le parti relative al travaso, alle prove di velocità, al caricamento del condotto, alla fase degli
appostamenti e al giorno della strage, ivi compreso l’appostamento sulla collinetta e la riunione del
brindisi nella villa di Girolamo Guddo, era indubbia la partecipazione dell’imputato, concordemente
a quanto dichiarato dai collaboratori che avevano riferito della fase esecutiva legata al territorio di
Capaci: La Barbera, Di Matteo e Ferrante.
Pertanto il giudicabile veniva dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti e condannato, con la
concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, alle pene
ritenute di giustizia.
CANCEMI SALVATORE
Il cospicuo contributo dell’imputato nel disvelare gli aspetti a lui noti della strage di Capaci aveva
incontrato, ad avviso dei primi giudici, il limite costituito da una progressione espositiva la cui
sottesa motivazione era da ricondursi al maldestro tentativo del Cancemi di ridurre il livello delle
sue responsabilità nel nefando delitto che, di certo, non erano state di poco momento, laddove si
ponga mente alla sua qualità di sostituto di Giuseppe Calò nel prestigioso mandamento di Porta
Nuova.
Tanto premesso, si osservava che l’imputato all’inizio si era limitato a narrare solo delle tre visite
alla villetta di Capaci, riferendo il dato saliente della presenza dei i bidoncini contenenti l’esplosivo,
intravisti in una di queste occasioni.
Tale racconto esauriva il contributo conoscitivo fornito, che sarebbe ripreso poi dal giorno della
strage – in relazione al quale il Cancemi aveva riferito di aver assistito al momento in cui, nel primo
pomeriggio, Raffaele Ganci aveva avvistato il movimento della Croma – per poi cessare per quel
giorno. Dopo un intervallo di tempo abbastanza ampio, il dichiarante aveva collocato l’incontro con
Giovanni Brusca, dal quale aveva appreso l’articolarsi degli eventi al momento dell’arrivo della
Croma blindata sul luogo dell’agguato, ricevendo conforto dall’analoga affermazione di
quest’ultimo.
L’evoluzione della narrazione aveva portato nel corso del tempo all’emergere della riunione
preliminare con Salvatore Riina ed alla precisazione del significato dell’incontro con Giovanni
Brusca, ricondotto nell’alveo della riunione che seguì la realizzazione della strage quel sabato
pomeriggio. Erano venuti altresì alla luce con la stessa progressione anche i pedinamenti dell’auto
di servizio in dotazione al magistrato per i suoi spostamenti a Palermo.
Sulla base di siffatta ricostruzione emergeva nitidamente che le rivelazioni dell’imputato erano state
caratterizzate da una narrazione basata su una parcellizzazione degli eventi narrati, sviluppatesi in
un contesto temporale non unitario. Si rilevava inoltre che malgrado il Cancemi avesse potuto
approfittare dell’occasione di poter ritornare sulle dichiarazioni per illustrarne parti prima rimaste
oscure, residuavano ancora aspetti da lui non pienamente rivelati. In particolare, quelli di maggiore
rilievo attenevano alla partecipazione alle operazioni di riempimento dei bidoncini, ai sopralluoghi
per individuare il luogo dove collocare la carica, e alle prove di velocità svoltesi in prossimità del
torrente Ciachea.
Al riguardo si riteneva altamente verosimile che nel corso delle visite alla villetta di Capaci, e
segnatamente la prima e la seconda, si fossero svolte rispettivamente le prove di velocità e i
sopralluoghi per visionare il cunicolo ai quali egli stesso, assieme a Raffale Ganci, aveva
partecipato.
E ciò sotto un duplice ordine di ragioni.
Da un lato gli altri collaboratori avevano parlato della sua presenza in occasione dei sopralluoghi
(Ferrante e La Barbera); dall’altro non era credibile l’imputato quando aveva sostenuto che in
occasione della seconda visita, si era limitato ad accompagnare Raffaele Ganci che si era
allontanato con Biondino, quasi come se fosse solo l’autista del predetto e non uno degli esponenti
di spicco di Cosa Nostra, quale sostituto di Giuseppe Calò nella reggenza dell’importante
mandamento di Porta Nuova. Nè parimenti convinceva che, per la prima visita, i due si fossero
accontentati di rilevare l’assenza dei complici e fossero tornati indietro, perchè era probabile che fu
proprio in quest’occasione che essi si accodarono agli altri che stavano sperimentando la fattibilità
dell’attentato nei pressi del primo cunicolo individuato.
Cancemi aveva anche taciuto di aver trascorso insieme a Raffaele Ganci il periodo dell’attesa della
notizia della strage, prima di recarsi insieme a lui nella villa di Guddo per incontrarsi con Salvatore
Riina e brindare alla riuscita dell’operazione.
Era quindi evidente il tentativo portato avanti dall’imputato di slegare la sua posizione a quella di
Raffaele Ganci, pienamente coinvolto nella strage, anche a livello esecutivo, nei cui confronti
pertanto, pur non negando la vicinanza, aveva tentato di autorappresentarsi come subalterno, come
mero accompagnatore, e ciò nel tentativo di supportare la tesi della sua mancata partecipazione a
condotte poste in essere dal primo che erano sintomo inequivocabile dell’importanza del ruolo da
questi rivestito, che poteva quindi trasporsi anche su di lui nel caso avesse ammesso di essersi
accompagnato al Ganci.
Emblematica a questo riguardo era ritenuta la partecipazione del Cancemi, riferita sia da Ferrante
che Brusca, ai sopralluoghi per l’identificazione del sito ove confinare l’esplosivo. Invero, la
presenza di Ganci, Biondino e Cancemi era segno evidente dell’importanza dell’attività di ricerca
del luogo idoneo ad ospitare la carica esplosiva per la migliore riuscita dell’attentato.
Altrettanto riduttiva era ritenuta la sua asserita partecipazione alle riunioni, sia quelle che
precedettero che quella che chiuse la fase organizzativa, perché anche in questi casi ammettere la
sua presenza sarebbe equivalso a riconoscersi, non solo nella realizzazione della strage, ma anche
più in generale, all’interno di Cosa Nostra, un ruolo di rilievo, in forza del quale era ammesso a
partecipare alle riunioni deliberative e a quella in cui si festeggiò la riuscita dell’operazione.
In quest’ottica si segnalava che Calogero Ganci aveva rilevato che il sabato in cui si era verificata la
strage vi era anche Cancemi insieme al padre al bar, e quindi entrambi avevano avvistato la Fiat
Croma blindata mentre lasciava il parcheggio, e non il solo Raffaele Ganci, come invece aveva
affermato Cancemi. Sebbene di tale circostanza unica fonte fosse Calogero Ganci, per cui non era
possibile ritenere come certo dal punto di vista probatorio l’accadimento, restava comunque per lo
stesso un ampio margine di veridicità, similmente a tutti gli episodi che avevano visto il suo
protagonismo insieme a Raffaele Ganci.
Di diversa natura era il silenzio del Cancemi sulla partecipazione al travaso e alle prove al torrente
Ciachea.
Nel primo caso la partecipazione a detta attività la si ritraeva dalla circostanza che lo stesso
collaborante aveva riferito l’episodio del montaggio della tenda sulla veranda realizzato da
Giovanni Battaglia, che costituì attività preliminare all’inizio delle operazioni di travaso effettuate
sulla veranda, mentre per il secondo caso la presenza del Cancemi la si ricavava dalle indicazioni di
Brusca e Ferrante.
A tali episodi si doveva aggiungere l’ammissione, parimenti non tempestiva, della partecipazione
dell’imputato alla riunione tenutasi al casolare la mattina successiva al caricamento del cunicolo.
Orbene, in tutte le segnalate ipotesi il silenzio serbato dal Cancemi si inquadrava non più nel
tentativo di evitare il coinvolgimento in episodi da cui era possibile trarre l’importanza del ruolo
assunto, ma nella generale tendenza a ridurre la portata del suo contributo al progetto stragista.
Restavano pertanto intatte, ad avviso dei primi giudici, le riserve sulle circostanze taciute e non
ammesse per sminuire il suo coinvolgimento nell’intera vicenda per cui è processo.
Pertanto il giudicabile veniva dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti e condannato, con la
concessione delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, alla pene
ritenute di giustizia.
*
LA BARBERA GIOACCHINO E DI MATTEO MARIO SANTO
La collaborazione di La Barbera, unitamente a quella di Di Matteo, aveva consentito agli
investigatori, prima, e all’A.G., poi, di far piena luce sulle vicende per cui è processo disvelandone i
profili più rilevanti, quali le operazioni di contrada Rebottone, la costruzione della ricevente, il
riempimento dei contenitori, le prove di velocità e il caricamento del condotto, per poi finire alla
fase degli appostamenti ed infine al giorno della strage.
In particolare, quanto narrato da La Barbera aveva esaurito l’intero percorso degli eventi che si
susseguirono dalla fase deliberativa fino al giorno della strage. La completezza della narrazione
rendeva quindi fondamentale ed imprescindibile il contributo reso, non inficiato dalle imprecisioni e
dalle incertezze che via via si erano registrate nel corso dell’esposizione. Difatti, su tutti i passaggi
nodali narrati si era constatata convergenza di dichiarazioni provenienti da più fonti propolatorie
che, per la fase Rebottone, provenivano da Di Matteo e Brusca, poi integrati, per i successivi
momenti da Ferrante, mentre per la fase finale dell’operazione, nonché per quella relativa
all’accompagnamento di Giovanni Brusca da Palermo a Piana degli Albanesi, avevano trovato
sommario riscontro in quelle del medesimo Brusca.
Le uniche incertezze registrate erano relative alla presenza del La Barbera alle prove svoltesi nei
pressi del torrente Ciachea, in merito alle quali la sua partecipazione era stata riferita sia da Ferrante
che da Brusca, mentre la seconda tornata di prove traspariva dalle sue dichiarazioni in proposito,
non essendo stata del tutto esclusa.
*
Il contributo reso da Di Matteo nel corso dei preparativi relativi alla fase esecutiva della strage si
ricavava dal suo coinvolgimento nelle attività svoltesi in contrada Rebottone, nel casolare nella sua
disponibilità, nel diretto coinvolgimento nelle operazioni di travaso dell’esplosivo consegnatogli da
Giuseppe Agrigento, nel trasporto dei bidoni a Capaci e nelle prove di velocità.
Le uniche discrasie fra le dichiarazioni dei predetti collaboratori erano quelle relative alla fase del
trasporto dell’esplosivo da Altofonte a Capaci, con riguardo alla composizione degli equipaggi e
alla persona che si era fatta trovare al bivio di Capaci per indicare loro la strada da seguire per
arrivare alla villetta, sulla cui marginalità, ad avviso dei primi giudici, non era il caso di soffermarsi
ulteriormente, coincidendo le predette propalazioni autoaccusatorie nei nuclei essenziali della
vicenda.
Pertanto, entrambi i giudicabili venivano dichiarati responsabili dei reati a loro rispettivamente
ascritti e condannati, con la concessione della diminunete di cui all’art. 8 D.L. n. 152/91 dichiarata
prevalente sulle contestate aggravanti, alla pene ritenute di giustizia.
*
GANCI CALOGERO, FERRANTE GIOVAMBATTISTA, GALLIANO ANTONINO
Il contributo probatorio offerto dal Ganci si era incentrato esclusivamente sulla fase dei
pedinamenti, in relazione ai quali aveva ricevuto piena conferma sia da Antonino Galliano, la cui
posizione processuale era stata separata, che da Salvatore Cancemi.
Gli unici spunti che, ad avviso dei primi giudici, potevano destare qualche perplessità nella
narrazione del Ganci derivavano dalla comparazione con Antonino Galliano, a cagione del rilevato
disaccordo sulla presenza di quest’ultimo il pomeriggio del 23 maggio 1992, giorno della strage.
Il Ganci non aveva incentrato le sue dichiarazioni solo sui pedinamenti, ma aveva riferito anche
degli incontri presso il Cash & Carry fra Biondino, Cancemi e suo padre, Raffaele Ganci, la cui
rivelazione aveva consentito di comprendere attraverso quali modalità si tenevano i contatti fra il
gruppo operante a Capaci e quello che stanziava a Palermo.
Meritava di essere sottolineata per la sua rilevanza la circostanza relativa al fatto che Domenico
Ganci, fratello dell’imputato, aveva la disponibilità dell’apparecchio cellulare intestato alla ditta
Ruisi di Utro Mariano.
*
Il contributo del Galliano alla ricostruzione dei fatti per cui è processo, oltre che per la predetta fase
preparatoria che lo aveva visto impegnato unitamente ai cugini Domenico e Calogero Ganci nella
fase dei pedinamenti della vettura di servizio del magistrato, era stato utile anche per la conoscenza
di vicende organizzative che riguardavano la Commissione provinciale di Palermo, atteso che
alcune di queste riunioni ebbero luogo presso l’abitazione della nonna, sicché egli aveva avuto la
possibilità di vedere alcuni dei partecipanti
*
Il Ferrante, con un apprezzabile sforzo di rielaborazione ed esposizione dell’esperienza vissuta nella
qualità di partecipe alla fase preparatoria dell’attentato, aveva narrato sotto angolo visuale diverso
rispetto a La Barbera alcuni fra i momenti più importanti in cui si estrinsecò l’attività esecutiva. Al
riguardo si citava il caricamento del condotto, visto nell’ottica non di chi mise in pratica
l’operazione, bensì in quella di chi si occupò di portare i bidoni al cunicolo; le prove di velocità,
descritte nella qualità di conducente l’autovettura e non di operatore presente sulla scarpata; e, in
relazione al giorno della strage, lo stazionamento nei pressi dell’aeroporto, descritto per altra via
sempre da La Barbera e da Brusca.
La convergenza che si riscontrava fra gli imputati chiamanti in correità che avevano preso parte
all’operazione, in ordine alla partecipazione del Ferrante all’attività di riempimento dei bidoncini,
oltre che alla riunione tenutasi al casolare il mattino successivo al caricamento del condotto,
riguardava episodi ammessi senza esitazione dall’imputato.
Infine, aveva trovato conforto nelle rivelazioni di Giovanni Brusca, quella parte della narrazione
relativa alla descrizione delle prove di velocità svoltesi al torrente Ciachea, oltre a quella relativa ai
sopralluoghi eseguiti e al reperimento del luogo ove andava collocata la carica esplosiva. Altrettanto
significativa era la rivelazione dell’incontro, prima alla macelleria e poi all’aeroporto, con
Domenico Ganci.
Pertanto, entrambi i giudicabili venivano dichiarati responsabili dei reati a loro rispettivamente
ascritti e condannati, con la concessione della diminuente di cui all’art. 8 D.L. n. 152/91 dichiarata
prevalente sulle contestate aggravanti, alla pene ritenute di giustizia.
*
BAGARELLA LEOLUCA
Plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie avevano attinto l’imputato, il cui ruolo all’interno
della famiglia mafiosa di Corleone, anche a cagione degli stretti rapporti parentali con Salvatore
Riina che ne aveva sposato la sorella, era stato delineato con dovizia di particolari, così come la di
lui fattiva partecipazione alla fase preparatoria ed esecutiva della strage.
In tal senso si era espresso Giovanni Brusca che aveva ne aveva registrato la presenza in contrada
Rebottone nel corso dell’effettuazione delle prove con l’esplosivo realizzatesi in quella sede; Di
Matteo lo aveva indicato fra coloro che erano abitualmente presenti nel luogo predetto, di cui
conosceva il nascondiglio della chiave di ingresso, nonché come colui che era presente sia quando
Rampulla aveva portato i telecomandi, sia alla costruzione della ricevente nel periodo di
permanenza nel casolare di Capaci.
Sempre Brusca lo aveva coinvolto nel trasporto dei bidoni da Altofonte alla villetta di Capaci, ed
altrettanto avevano fatto Di Matteo, che aveva precisato che nell’occasione il Bagarella aveva il
Kalashnikov, e La Barbera.
Durante le operazioni di travaso dell’esplosivo, il Bagarella era presente, a dire di Brusca e Di
Matteo, che aveva riferito che l’imputato aveva mostrato una certa familiarità con i due che erano
del luogo, cioè Battaglia e Troia. Ed anche La Barbera e Cancemi, che ne aveva notato la presenza
durante una delle sue visite in tale località, si erano espressi in tal senso.
In relazione alle prove di velocità, Di Matteo lo aveva indicato come facente parte del gruppo
appostato sulla collinetta, insieme a Brusca e Gioè, mentre durante il caricamento del condotto,
secondo Brusca, il Bagarella aveva compito di sorvegliare che nessuno disturbasse i lavori, ed
aveva a tale scopo a disposizione un Kalashnikov; circostanza sulla quale aveva concordato
Ferrante, che aveva riferito anche del ruolo di sorvegliante delle operazioni, come La Barbera, che
in particolare aveva attribuito all’imputato il merito di aver avvisato il gruppo dell’arrivo dei
Carabinieri, e la decisione di non coinvolgere nel caricamento Di Matteo.
Aveva appreso della sua presenza sui luoghi, in quel determinato frangente, anche Salvatore
Cancemi, perché riferitogli da Raffaele Ganci, che gli aveva anche detto che Bagarella si sarebbe
anche interessato a procurare l’esplosivo. Cosa analoga era avvenuta per Di Matteo, che aveva
appreso da Gioé che l’imputato era presente nel momento del caricamento del condotto.
Non risultava, invece, secondo La Barbera, la presenza del Bagarella alla riunione operativa svoltasi
all’indomani del caricamento del cunicolo.
Cancemi invece lo aveva indicato fra i presenti alla riunione successiva alla strage, a casa di
Girolamo Guddo, da dove si era poi allontanato, insieme a Riina, prima di tutti gli altri.
Mentre nei momenti immediatamente precedenti la strage, Di Matteo, sempre per averlo appreso da
Gioé, aveva rivelato che il Bagarella era assente.
Il quadro di elementi probatori così sinteticamente ricostruito rendeva evidente che la convergenza
delle plurime indicazioni provenienti dagli imputati chiamanti in correità a carico di Bagarella, una
volta superato il vaglio dell’attendibilità intrinseca per ogni dichiarante, rendeva certa la
partecipazione dell’imputato all’evento stragistico essendo del tutto irrilevanti e marginali le
discrasie in cui i propalanti erano incorsi. Pertanto, i primi giudici infliggevano al Bagarella la pena
dell’ergastolo.
*
BIONDINO SALVATORE
Plurime e convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia avevano attinto l’imputato
delineandone il ruolo di spicco del mandamento di San Lorenzo, quale sostituto di Giuseppe
Gambino, capomandamento detenuto, e di soggetto vicinissimo a Salvatore Riina, per conto del
quale si occupava di fissare appuntamenti, e che era solito accompagnare in giro in occasione delle
riunioni, tant’è che entrambi vennero tratti in arresto il 15 gennaio 1993 dai Carabinieri del ROS.
Con riferimento alla strage di Capaci, a dire di Anzelmo, Ganci Calogero e Di Matteo, il Biondino
era stato il diretto emissario di Riina nel corso della fase dei preparativi, ed aveva partecipato,
secondo quanto riferito da Ferrante, Brusca, Ganci Calogero e Di Matteo, alle fasi di ricerca del
posto dove collocare la carica esplosiva insieme a Raffaele Ganci, avendo, in precedenza,
incaricato il Ferrante ed il Troia, appartenenti al medesimo mandamento, di tale compito.
Anche La Barbera aveva attribuito, come gli altri dichiaranti, il medesimo ruolo all’imputato,
rettificando in sede dibattimentale le sue originarie dichiarazioni sul punto.
Avuto riguardo alle successive fasi prodromiche alla strage, si osservava come la presenza del
Biondino era un dato costante su cui avevano concordato tutti gli imputati chiamanti in correità
coinvolti nell’esecuzione del delitto.
La presenza dell’imputato a Capaci era stata confermata persino da Calogero Ganci, cioè da persona
che, pur avendo rivelato di sapere poco sul gruppo operante in periferia, aveva indicato come sicuro
appartenente allo stesso proprio il Biondino, unitamente al Brusca e al Bagarella, evidentemente per
averlo appreso dal padre, che era stato interessato in prima persona all’individuazione del luogo ove
collocare l’esplosivo.
Più in particolare, secondo le dichiarazioni di La Barbera, Brusca, Cancemi e Di Matteo, si era
registrata la sua presenza al momento del travaso, alle prove di velocità, al caricamento del
condotto, oltre che nella fase degli appostamenti, durante la quale aveva fatto da tramite con il
gruppo dei pedinatori operanti a Palermo.
Brusca aveva attribuito al Biondino anche il ruolo di colui che aveva procurato non solo la parte di
esplosivo che gli attentatori avevano trovato nella villetta, ma anche il recupero dei bidoncini serviti
materialmente per effettuare il travaso. Sebbene fosse insorto un contrasto con quanto affermato dal
Ferrante, che aveva ricondotto a Giuseppe Graviano l’origine di quella partita di esplosivo, quel che
però emergeva con certezza, grazie alla convergenza sul punto delle dichiarazioni dei due imputati,
era che Salvatore Biondino si era curato anche di procurare i contenitori che dovevano servire per il
travaso.
Era altresì emerso dalle concordi dichiarazioni degli imputati lo stretto rapporto esistente fra
l’imputato e il duo Troia-Battaglia.
A parte l’appartenenza allo stesso mandamento, e quindi il rapporto di superiorità gerarchica del
primo nei confronti degli ultimi due, confermata da Cancemi, Ferrante, Di Matteo e La Barbera, era
evidente, in concreto, che Troia e Battaglia eseguivano materialmente gli ordini del loro capo, come
risultava dall’episodio della custodia dei contenitori e del congegno, dal controllo del cunicolo dopo
il caricamento, dalla distruzione di tutto quanto usato dagli attentatori, sia in esito al travaso, che al
caricamento, che subito dopo la strage, dal taglio dei rami e dal recupero della sega, per come
riferito da La Barbera e Brusca.
Era altresì evidente che l’affidamento di tutti questi ruoli ai predetti imputati era stato determinato
dalla consapevolezza in capo al Biondino che i due, essendo del posto, avevano maggiore
dimestichezza ad intervenire per procurare quello che necessitava e, soprattutto, potevano muoversi
sul territorio senza destare sospetti e procurare quanto necessario.
Oltre alla acclarata presenza di Salvatore Biondino a tutte le fasi della preparazione dell’attentato, il
predetto, alla stregua delle concordi dichiarazioni di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi, aveva
partecipato alle riunioni tenutesi al Cash & Carry. Pertanto, Biondino messo a conoscenza degli
avvenimenti che si verificavano a Palermo, che evidentemente apprendeva da Ganci e Cancemi, poi
li riferiva agli altri membri dell’organizzazione operanti a Capaci, per come era avvenuto nel caso
del cd. “falso allarme”, allorquando la repentina partenza della macchina del dr Falcone dal luogo
ove era parcheggiata fece pensare all’imminente arrivo del magistrato a Palermo, secondo quanto
concordemente affermato da Brusca, Ferrante e La Barbera, che avevano appreso detto episodio
perché era stato raccontato loro proprio dal Biondino.
Indubbia, inoltre, era la partecipazione del Biondino alle riunioni che avevano preceduto la fase dei
preparativi ed a quella che si era tenuta subito dopo la strage.
Per quanto riguardava i momenti precedenti l’inizio della fase dei preparativi, Brusca lo aveva
indicato come presente in casa di Guddo alla riunione in cui Salvatore Riina gli aveva conferito
l’incarico di organizzare l’attentato e in quella successiva, in cui Brusca aveva presentato Pietro
Rampulla al Riina.
Salvatore Cancemi, pur se solo nel corso del riesame del P.M., aveva ammesso la circostanza e la
sua partecipazione e quindi aveva riferito anche della presenza dell’imputato ad uno di tali incontri.
Infine, analoga convergenza si era registrata per la riunione verificatasi subito dopo la strage.
Le indicazioni provenienti dai collaboratori consentivano quindi di inquadrare il ruolo svolto
dall’imputato relativamente alla preparazione dell’attentato; ruolo che non si era limitato solo ad
un’opera di controllo, partecipazione e raccordo fra i due gruppi, ma si era esteso anche alla fase
deliberativa dell’attentato, posto che egli aveva partecipato insieme ad altri capimandamento, oltre a
Salvatore Riina, agli incontri che avevano preceduto l’inizio dei preparativi e, insieme agli stessi
capimandamento e al Riina, a quello celebrativo del trionfo.
La presenza in entrambi i momenti era indice inequivoco del fatto che il Biondino rivestiva un ruolo
di rilievo all’interno di Cosa Nostra, partecipando alle scelte strategiche che attenevano agli aspetti
più delicati relativi alla sopravvivenza del sodalizio.
Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità del giudicabile e lo condannavano alla
pena dell’ergastolo, ritenendo del tutto irrilevanti le discolpe offerte dalla difesa del giudicabile che
a dire del Ferrante, che aveva appreso tale circostanza dallo stesso Biondino, si era procurato per il
tramite dei familiari un alibi fasullo, costruito a tavolino.
*
TROIA ANTONINO E BATTAGLIA GIOVANNI
Il ruolo di Troia Antonino all’interno di Cosa Nostra era stato concordemente delineato dai
collaboranti che lo avevano indicato come sottocapo della famiglia di Capaci, rientrante nel
mandamento di San Lorenzo. In tal senso si erano espressi Giovan Battista Ferrante, che di quel
mandamento faceva anch’egli parte, nonché Gaspare Mutolo e Anzelmo. Quest’ultimo, pur avendo
riferito di aver conosciuto l’imputato durante un comune periodo di detenzione e che nell’occasione
non gli era stato presentato come uomo d’onore, aveva appreso del ruolo rivestito dal Troia
all’interno dell’organizzazione da Ferrante, Biondino o Biondo, che, ad avviso dei primi giudici,
erano fonti altamente qualificate, perché tutte appartenenti al medesimo mandamento del citato
Troia, ed avevano pieno titolo per fare la confidenza all’Anzelmo che pertanto sul punto era ritenuto
credibile.
La posizione rivestita dall’imputato all’interno del sodalizio mafioso era comunque ricavabile per
via indiretta anche dalle dichiarazioni di Cancemi, La Barbera e Di Matteo, dalle quali era possibile
trarre un dato comune costituito dallo stretto rapporto di dipendenza fra l’imputato, Giovanni
Battaglia e Salvatore Biondino.
I dichiaranti, infatti, pur avendo conosciuto gli imputati per la prima volta in occasione dei
preparativi dell’attentato, avevano rilevato subito il legame esistente fra i tre, che si sostanziava in
un rapporto di dipendenza gerarchica rispetto al Biondino, che si era avvalso dei due uomini per
l’espletamento degli incarichi esecutivi durante le varie fasi in cui si erano articolati i preparativi.
Il Troia ed il Battaglia, essendo originari dei luoghi teatro della strage, meglio di chiunque altro
potevano provvedere a risolvere i problemi pratici che si presentavano nella complessa ed articolata
fase di preparazione della strage.
Avuto riguardo al contributo personale fornito alla realizzazione della strage, Ferrante, La Barbera e
Brusca avevano assegnato a Troia il merito specifico di aver trovato il cunicolo che poi era stato
caricato con le frazioni di esplosivo.
Gli stessi imputati avevano registrato la presenza del Troia nel corso delle attività di travaso
dell’esplosivo nei bidoncini, svoltasi in un’abitazione nella sua disponibilità, sia pur in comune con
il fratello Enzo, stando a quanto riferito da Ferrante.
Della presenza dell’imputato aveva dato conferma anche Di Matteo, che pur non avendo preso parte
all’operazione, lo aveva notato proprio in occasione dell’arrivo dell’esplosivo che avevano portato
alla villetta.
Ad analoghe conclusioni pervenivano i primi giudici nei riguardi di Battaglia, che fra l’altro era
stato presente nella fase del travaso, perché tutti gli imputati chiamanti in correità che avevano
preso parte all’attività esecutiva, lo avevano indicato come colui che aveva provveduto a bruciare
tutti gli oggetti che erano serviti nel corso del caricamento dei contenitori, e che, durante tale fase,
aveva prudenzialmente montato la tenda per evitare che passanti o vicini potessero notare quel che
stava succedendo sulla veranda; circostanza questa ammessa dallo stesso Cancemi, che induceva a
ritenere che malgrado non lo avesse confessato, aveva partecipato anch’egli alla fase del travaso.
Sia Troia che Battaglia si erano occupati infine della custodia del congegno di trasmissione e dei
contenitori, ed in particolare del confinamento degli stessi, o di parte di essi, nella buca sottoterra,
previo l’avvolgimento in buste di plastica nera, nonchè del successivo dissotterramento poco prima
del caricamento del cunicolo, per come riferito direttamente da Ferrante e confermato
indirettamente da Brusca e La Barbera, che al momento del caricamento, avevano notato che i
bidoni erano avvolti da buste scure simili ai sacchetti per la spazzatura.
Il Battaglia e il Troia risultavano poi, secondo Brusca, Ferrante e La Barbera, presenti al
caricamento, sia pure con ruoli diversi, perché Troia era stato impegnato con Ferrante nel trasporto
dei bidoncini dalla villetta al condotto, e ancor prima, sempre secondo Ferrante, nell’attività di
ricerca dell’altra entrata del cunicolo, quella lato mare; attività svoltasi però prima del caricamento,
grazie alla disponibilità in capo al Troia delle chiavi dell’azienda avicola di Romeo.
Per Battaglia invece, stando al tenore di quanto riferito da Brusca e La Barbera, doveva ritenersi che
era rimasto fisso al cunicolo, con mansioni di controllo generale della situazione.
Analoga convergenza si riscontrava per le prove di velocità, atteso che Brusca e La Barbera
avevano riferito la presenza di entrambi che doveva ritenersi certa anche con riferimento agli
appostamenti e al giorno della strage.
Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità di Troia e Battaglia in ordine a reati
loro ascritti e li condannavano alla pena dell’ergastolo.
*
BIONDO SALVATORE
Alla stregua delle plurime e convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboranti è
stato individuato il ruolo svolto dal Biondo all’interno di Cosa Nostra quale “soldato” della
famiglia di San Lorenzo. In tal senso si erano espressi Anzelmo, Ganci Calogero e Cancemi,
precisando che l’imputato era molto vicino a Biondino e Ferrante. Quest’ultimo, affiliato alla
medesima famiglia e legato anche da stretto legame di parentela con il Biondo, aveva confermato
pienamente le propalazioni degli altri imputati, sulle quali pertanto, ad avviso dei primi giudici, non
era utile soffermarsi ulteriormente per inferirne la conducenza probatoria.
Altrettanto certi e verificati erano i rapporti tra l’imputato e Biondino, per come evidenziato a
proposito della posizione di quest’ultimo.
I collaboranti Di Matteo e La Barbera avevano riferito di aver conosciuto l’imputato per la prima
volta in occasione dei preparativi dell’attentato, confermandone comunque la vicinanza a Biondino
e Ferrante, e quindi indirettamente l’appartenenza alla famiglia di San Lorenzo.
Sulla base delle concordi rilevazioni dei coimputati che lo avevano chiamato in correità, si riteneva
certa la presenza del Biondo già ad Altofonte, dove Di Matteo lo aveva collocato in compagnia di
Biondino, e poi ancora nel momento del travaso, delle prove di velocità (accanto a Ferrante, alla
guida della Mercedes, a dire di Ferrante e La Barbera), del caricamento del condotto (con funzioni
di sentinella), negli appostamenti e nel giorno della strage, trascorsi sempre accanto a Ferrante, in
macchina nei pressi dell’aeroporto.
Il Ferrante aveva anche riferito della presenza del Biondo all’incontro avuto in Palermo con
Domenico Ganci, confermando quindi il fatto che i due usavano spesso muoversi insieme.
Peraltro, in esito ad un’attività di pedinamento effettuata da personale della DIA, erano stati
acclarati gli incontri fra l’imputato e Ferrante alla Città Giardino.
La valenza probatoria degli elementi indicati, desumibile dalla convergenza delle chiamate di
correità relativamente alla partecipazione dell’imputato a tutte le fasi che avevano contrassegnato
l’evolversi dei preparativi dell’attentato, considerata unitariamente ai dati emersi dall’attività di
indagine, rendevano certa la di lui concorrente responsabilità nella strage. Difatti, non era ritenuta
d’ostacolo a tale conclusione la pretesa incompatibilità delle attività svolte ai fini della realizzazione
dell’attentato con il contemporaneo svolgimento di attività lavorative, sul rilievo che era ben
possibile per il Biondo, a cagione della peculiarità del lavoro, riuscire a ritagliarsi ampi margini di
autonomia, insuscettibili di qualsiasi forma di controllo. Pertanto, si riteneva, senza alcun timore di
smentita, che era stato possibile per l’imputato conciliare l’impegno lavorativo con quelli che lo
legavano ai preparativi della strage; delitto per il quale Salvatore Biondo veniva condannato alla
pena dell’ergastolo
*
GANCI RAFFAELE
Raffaele Ganci, alla stregua delle convergenti chiamate di tutti i collaboranti escussi nel corso
dell’istruttoria dibattimentale, era indicato come uno dei capimandamento più importanti all’interno
della Commissione provinciale, molto vicino a Salvatore Riina, il quale lo aveva preferito a
Salvatore Scaglione nella guida del mandamento che era stato creato proprio per il Ganci subito
dopo la fine della guerra di mafia, alla fine del 1982 e gli inizi del 1983.
Il preponderante ruolo del Ganci nella realizzazione della strage si desumeva dal fatto che egli si era
esposto in prima persona nella preparazione dell’attentato, che non era stata delegata a semplici
gregari, ma costantemente seguita dall’imputato sin dall’inizio, e non solo per l’aspetto relativo alla
direzione e al coordinamento del gruppo che operava in Palermo, ma anche attraverso il controllo
del commando che aveva il compito di eseguire l’attentato.
La certezza sulla centralità del ruolo rivestito dall’imputato nella realizzazione della strage, anche
per quanto atteneva alla parte esecutiva, era derivabile dalla la sua costante partecipazione diretta o
mediata per il tramite di Salvatore Biondino ad ogni fase in cui si era articolata detta attività.
Alla stregua delle convergenti indicazioni di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi era emerso che,
durante la fase dei preparativi, Raffaele Ganci, Biondino e Cancemi si incontravano al Cash &
Carry ove si scambiavano le informazioni relative all’attività dei due gruppi che operavano a
Palermo e a Capaci. Tale scambio di informazioni garantiva all’imputato, attraverso Biondino, la
conoscenza di quel che accadeva in sua assenza.
Il protagonismo di Ganci nel corso del progetto stragista si era manifestato sin dalla prima riunione,
nel cui corso Salvatore Riina aveva conferito a Brusca l’incarico di trovare una persona esperta di
esplosivi, per come concordemente riferito da Salvatore Cancemi e dal medesimo Brusca. Al
riguardo la presenza del Ganci, non poteva ritenersi messa in discussione dai tentennamenti di
Cancemi sulla rivelazione dell’episodio, che restava fermo quanto al coinvolgimento del Ganci,
perché Cancemi, ad avviso dei primi giudici, era stato poco lineare nella sua esposizione solo per
evitare di restarne coinvolto.
Anche nella fase di ricerca del luogo ove andava posizionato l’esplosivo, si rilevava la presenza di
Ganci Raffaele, secondo quanto riferito da Ferrante, Di Matteo, La Barbera, Brusca e dallo stesso
figlio del giudicabile, Ganci Calogero.
L’imputato aveva svolto un ruolo attivo anche nella fase dei pedinamenti, in relazione ai quali, alle
rivelazioni di Ganci Calogero e Antonino Galliano, si erano aggiunte le indicazioni fornite nel
settembre del 1996 anche dal Cancemi.
Il Ganci era stato altresì presente alla riunione al casolare, la mattina successiva al caricamento del
cunicolo, e a quella propedeutica alla fase degli appostamenti.
Il giorno della strage, a dire di Ganci Calogero e Salvatore Cancemi, era stato proprio Raffaele
Ganci ad accorgersi che la Fiat Croma blindata del dr Falcone si stava muovendo, per cui aveva
allertato i figli affinché si ponessero all’inseguimento della vettura, dirigendosi poi insieme al
Cancemi alla villa di Guddo per aspettare gli altri e la notizia dell’esecuzione dell’attentato dai
notiziari televisivi.
La partecipazione dell’imputato alla fase del travaso dell’esplosivo si ricava esplicitamente dalle
dichiarazioni di Ferrante, La Barbera e Brusca, mentre era stata solo adombrata dal Cancemi che
non ne aveva parlato, limitandosi a fare solo un incauto cenno all’episodio del montaggio della
tenda da parte di Giovanni Battaglia, la cui conoscenza era indice del fatto che egli era stato
presente al riempimento dei contenitori.
Restava infine non delineato con assoluta certezza quanto accaduto in occasione della seconda
visita nel cui corso, secondo Cancemi, Raffaele Ganci si era allontanato con Biondino dalla casa per
farvi ritorno dopo circa mezzora. Tale episodio poteva essere collocato prima del travaso ed era
ricollegabile alle prove svolte nei pressi del Torrente Ciachea, in relazione alle quali Ferrante aveva
riferito della presenza di Raffaele Ganci, seduto accanto al conducente, che era stata confermata,
pur se in termini dubitativi, da Giovanni Brusca.
Il ruolo di Ganci Raffaele emergente dalle dichiarazioni dei propalanti, aveva trovato conforto
nell’attività di indagine esperita dal ROS con l’osservazione dei movimenti dei soggetti gravitanti
intorno al cantiere di Piazza Principe di Camporeale, ove, a dire del Cancemi, solitamente si
incontravano gli affiliati alla famiglia della Noce. Peraltro, il Cancemi si era riconosciuto nel
filmato che lo ritraeva mentre unitamente a Raffaele Ganci si stata allontanando in fretta dal
cantiere, avendo appena appreso dell’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare per l’omicidio
Lima.
Ed ancora, i Carabinieri del ROS erano riusciti ad accertare, tramite pedinamenti e riprese filmate,
che il Ganci frequentava la villa di Via Margi Faraci, dove si erano tenute le riunioni con Salvatore
Riina; che Domenico Ganci, figlio dell’imputato, era a conoscenza dell’ultima dimora di Riina da
cui era uscito insieme al Biondino la mattina del 15 gennaio 1993; che i soggetti presenti all’interno
del cantiere di Piazza Principe di Camporeale, fra i quali Raffaele Ganci, avevano condiviso
appieno la gioia di detenuti visti in televisione mentre brindavano alla morte violenta di magistrati;
che era nella disponibilità dell’imputato, in quanto intestata alla moglie Gambino Nicolina, la
vettura Clio (targata Pa A 86390) usata anche per i pedinamenti e alla guida della quale l’imputato
si era allontanato dal cantiere di Piazza Principe di Camporeale, assieme a Salvatore Cancemi, il
giorno in cui furono emesse, o stavano per essere emesse, le ordinanze di custodia cautelare per
l’omicidio Lima.
Era stato altresì rilevato, sempre sulla base della suddetta attività di indagine, che Raffaele Ganci
soleva frequentare la macelleria di Cancemi Giuseppa, sita in via Cortegiani 24, cugina di quel
Salvatore Cancemi da cui l’imputato aveva continuamente cercato di prendere le distanze negando
qualsiasi tipo di contatto.
Ulteriore e significativo elemento a carico di Ganci Raffaele si ricavava dalla telefonata che
Calogero Ganci aveva fatto alla macelleria per avvisare che la macchina di servizio del magistrato
si trovava già all’aeroporto. Sebbene a quella telefonata avesse risposto Domenico Ganci e non
l’imputato – secondo le dichiarazioni del figlio Calogero Ganci –, tuttavia quella macelleria era il
punto di riferimento dei pedinatori, ed esattamente il luogo da dove osservavano gli spostamenti
della Fiat Croma del magistrato.
Pertanto i primi giudici affermavano la penale responsabilità del giudicabile in ordine alla strage ed
ai connessi delitti, condannandolo alla pena dell’ergastolo.
*
GANCI DOMENICO
La posizione processuale di Domenico Ganci, ad avviso dei primi giudici, era intimamente
connessa a quella del padre Raffaele e del fratello Calogero Ganci che aveva esteso la sua chiamata
in correità nei confronti dei predetti congiunti, ma anche nei confronti del cugino Antonino
Galliano, anch’egli divenuto collaboratore di giustizia.
Il ruolo di soldato svolto dall’imputato all’interno della famiglia mafiosa, e più in particolare
nell’ambito dell’omonimo mandamento della Noce, di cui capo storico riconosciuto era il padre, era
stato riferito concordemente da Francesco Paolo Anzelmo e da Giuseppe Marchese.
L’Anzelmo era stato il sottocapo della predetta famiglia della Noce; era stato “combinato” nella
stessa cerimonia insieme a Domenico Ganci; aveva retto il mandamento assieme all’imputato
durante lo stato di detenzione di Ganci Raffaele, per come riferito anche da Galliano, determinando
il malumore dell’altro fratello, Calogero, per come ammesso da quest’ultimo nel corso del suo
esame.
A dire del Galliano, la reggenza temporanea del mandamento aveva consentito al cugino di
partecipare alle riunioni della Commissione provinciale accanto a Salvatore Riina.
Marchese era ben addentro alla vicende della famiglia della Noce, pur se formalmente appartenente
ad altro mandamento, per via dello stretto contatto con il gruppo dei corleonesi, vicinissimi ai
Ganci, grazie alla parentela con Bagarella, e, nello specifico, per aver constatato, durante la sua
detenzione, il ruolo di mediatori che rivestivano i fratelli Ganci fra il carcere e l’esterno. Pertanto, il
collaborante era stato in grado di riferire quanto a sua conoscenza su Domenico Ganci.
Anche Mutolo, affiliato a Cosa Nostra in diverso mandamento e soprattutto in epoca più datata
rispetto al giovane Ganci, lo aveva collocato nel medesimo ruolo di soldato della famiglia della
Noce, fornendo così prezioso, quanto autonomo, riscontro alle indicazioni dei primi due
collaboranti.
Il ruolo svolto da Domenico Ganci nella vicenda per cui è processo si era incentrato principalmente
nella fase dei pedinamenti, che, secondo Calogero Ganci e Antonino Galliano, erano stati iniziati da
Galliano e dall’imputato, molto prima rispetto al momento in cui era intervenuto Calogero Ganci.
Giovan Battista Ferrante riferiva dell’incontro, prima a Palermo città, poi all’aeroporto, con
l’imputato. In particolare, nel corso dell’incontro a Palermo, Domenico Ganci, in presenza di
Biondo e Biondino, aveva mostrato a quest’ultimo la macchina di servizio, parcheggiata dietro
l’abitazione del giudice. Successivamente, all’aeroporto, l’imputato aveva indicato al Ferrante il
posto dove doveva posizionarsi per vedere uscire le macchine del corteo e rilevare se il dr Falcone
fosse effettivamente arrivato. In quell’occasione il Ganci era alla guida di un’autovettura Mercedes
250 diesel bianca, per come acclarato dai militari del ROS.
L’imputato era stato presente anche alla riunione successiva al caricamento del condotto, per come
riferito da La Barbera e Brusca, essendo tale incontro destinato a definire stabilmente i ruoli che
ognuno dei componenti dei gruppi operativi doveva ricoprire.
Il giorno della strage Domenico Ganci non solo aveva ricevuto la telefonata del fratello Calogero
delle ore 17,15, con la quale quest’ultimo, a suo dire, lo aveva avvisato dell’arrivo della Fiat Croma
all’aeroporto, ma aveva fatto, 15 minuti prima, con il suo cellulare, due telefonate prima a Ferrante
e poi a La Barbera, per informarli che la macchina del magistrato era partita, essendo evidentemente
riuscito ad individuare la direzione della Fiat Croma prima del congiunto.
L’indicazione di Calogero Ganci aveva trovato riscontro nell’attività di indagine svolta dalla DIA
che aveva accertato, molto prima della collaborazione dell’imputato, che le telefonate in uscita da
quel cellulare avevano prevalentemente come destinatari appartenenti alla famiglia Ganci, per cui si
ritenne fondatamente che l’apparecchio fosse in uso ad uno dei componenti di detta famiglia.
Alla stregua di tali considerazioni i primi giudici affermarono la penale responsabilità del
giudicabile in ordine al delitto di strage ed a quelli connessi e gli irrogarono la pena dell’ergastolo e
quelle ritenute di giustizia.
*
SBEGLIA SALVATORE
Sbeglia Salvatore, ancorché fosse vicino alla famiglia della Noce per cointeressenze di carattere
economico, non era affiliato a Cosa Nostra, per come riferito da Francesco Paolo Anzelmo e da
Calogero Ganci, che aveva escluso che l’imputato potesse rivestire il ruolo di affiliato a detta
organizzazione anche in forma riservata.
Anche Galliano aveva riferito di aver conosciuto l’imputato, confermando i rapporti di natura
economica che lo legavano allo zio Raffaele Ganci, precisando, quanto alla strage, di aver utilizzato
per i pedinamenti della vettura di servizio del dr Falcone il cellulare intestato alla ditta dello Sbeglia
consegnatogli sempre dal predetto Ganci.
Salvatore Cancemi, pur escludendo la qualità di uomo d’onore dell’imputato, lo aveva coinvolto
nell’attentato in quanto, a suo dire, aveva appreso da Raffaele Ganci, a cui lo Sbeglia era legato da
stretti rapporti, dell’incarico affidatogli di acquistare un telecomando; incarico che era stato
adempiuto perché, prima della strage, aveva visto il predetto oggetto nella macchina del Ganci e
questi gli aveva confidato che quello era il telecomando che aveva procurato lo Sbeglia.
Cancemi aveva datato l’acquisto dello strumento elettronico a circa una settimana prima della
strage, per poi, una volta tornato sull’argomento, spostarlo più indietro nel tempo. Con riferimento
alla consapevolezza che Sbeglia potesse avere dell’uso che ne sarebbe stato fatto, il collaborante
aveva affermato che, in virtù dei rapporti intimissimi che vi erano fra i due, l’imputato doveva
essere per forza di cose a conoscenza della circostanza.
Tuttavia, in sede di controesame del difensore dell’imputato, era stata contestato al Cancemi che
egli aveva dichiarato che Raffaele Ganci aveva dato a Biondino l’incarico di procurarsi il
telecomando (cfr. interrogatorio del 2 novembre 1993).
In esito ad ulteriore contestazione (tratta dal verbale del 18 febbraio 1994), si apprendeva che
l’imputato aveva riferito di aver visto il telecomando nella macchina di Raffaele Ganci dopo il
verificarsi della strage; ed ancora, tale circostanza era stata ribadita nel verbale del 26 luglio 1994.
Infine, in occasione dell’esame reso del presidente, Cancemi aveva ribadito che Raffaele Ganci
aveva dato l’incarico sia a Sbeglia che a Biondino, che in macchina aveva visto il telecomando che,
secondo le confidenze fattegli da Ganci Raffaele, aveva procurato Sbeglia, affermando di non
sapere se in effetti quello visto in quel frangente era il telecomando usato per la Commissione della
strage.
I primi giudici, rilevavano che, tenuto conto del quadro probatorio esposto a carico del giudicabile,
era impossibile affermare che egli potesse rispondere del delitto di strage, atteso che il problema
della fornitura del telecomando al commando operativo costituiva fattore destinato, allo stato, a
rimanere insoluto.
In primo luogo perché lo stesso Cancemi, oltre ad introdurre un altro elemento di instabilità nelle
sue dichiarazioni nella parte in cui aveva attribuito ruolo analogo a quello di Sbeglia anche a
Salvatore Biondino, non era stato in grado di dire se i telecomandi da lui visti nella macchina di
Raffaele Ganci fossero quelli effettivamente impiegati per la realizzazione di questa strage.
In secondo luogo le predette dichiarazioni erano prive di qualsiasi riscontro, atteso che gli altri
imputati chiamanti in correità avevano negato il coinvolgimento dello Sbeglia nell’attentato.
In particolare, Calogero Ganci aveva escluso che Sbeglia fosse coinvolto nella strage, parlando a tal
proposito, come Ferrante e Anselmo, di “Strage degli Innocenti” operata dal Cancemi.
Si osservava, però, che Raffaele Ganci, sia pur per un’altra occasione, sempre di natura delittuosa, a
dire del figlio, aveva espresso l’intenzione di rivolgersi a Salvatore Sbeglia per il reperimento di
telecomandi. Pertanto, le asserzioni fatte da Cancemi, in ordine al coinvolgimento dell’imputato
nella strage non erano del tutto destituite di un fondamento, sia pur minimo. Tuttavia,
l’indeterminatezza della propalazione, sia per quanto riguardava il profilo dell’individuazione del
progetto criminoso che per l’effettivo concretizzarsi dell’intenzione, espressa a livello meramente
ideativo, non toglieva rilievo al fatto che la disponibilità di Salvatore Sbeglia, per simili
adempimenti, costituiva dato acquisito per il capomandamento della Noce che aveva dunque ben
chiaro che l’imputato era in grado di soddisfare le riferite esigenze.
Tale rilievo, però, per la sua intrinseca indeterminatezza, non valeva a calare l’episodio riferito da
Calogero Ganci nel concreto del fatto di strage per cui è processo, a ciò ostando anche
l’inquadramento temporale della vicenda, per cui immutato continuava ad essere il quadro degli
indizi posti a carico dell’imputato del quale si imponeva, in assenza di riscontri alla chiamata in
correità proveniente da Cancemi, l’assoluzione da tutti i reati ascritti per non aver commesso il
fatto.
*
SCIARRABBA GIUSTO
Alla stregua delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti che avevano attinto l’imputato era
emerso che Giusto Sciarrabba era affiliato alla famiglia della Noce, rivestendone il ruolo di
consigliere.
In tal senso si erano espressi Francesco Paolo Anzelmo, Antonino Galliano, Gaspare Mutolo,
Calogero Ganci e Salvatore Cancemi. La riferita circostanza della permanenza, per un certo periodo
di tempo, dell’imputato a Roma, ove svolgeva un’attività commerciale era stata confermata da
Cancemi, in quanto sia Raffaele Ganci che Giuseppe Calò gli avevano riferito che l’imputato
gestiva a Roma un negozio di biancheria.
Sempre Cancemi aveva narrato di frequentissimi viaggi a Palermo da parte dell’imputato e ne aveva
rivelato al contempo il ruolo svolto nella capitale, come emissario dell’organizzazione per
l’esecuzione di delitti che la riguardavano.
In ordine al coinvolgimento dell’imputato nella strage di Capaci, Anzelmo aveva appreso da
Raffaele Ganci, durante una passeggiata nell’ora d’aria avvenuta nel corso di un periodo di comune
detenzione, che lo Sciarrabba, che viveva al Nord Italia e che aveva abitato per lungo tempo a
Roma, era stato incaricato di segnalargli la partenza dalla capitale del dr Falcone.
Salvatore Cancemi aveva confermato la circostanza relativa al fatto che Raffaele Ganci avrebbe
dato espresso incarico a Sciarrabba di seguire gli spostamenti del giudice, per averlo appreso dal
Ganci, mentre si trovavano insieme in macchina e stavano andando al macello di Palermo. Riferiva
al riguardo il collaborante di aver assistito, una ventina di giorni prima della strage, ad una
telefonata intercorsa tra i due alla macelleria di Via Lancia di Brolo, relativa a questioni legate alla
strage; che a tale episodio aveva assistito il figlio del Ganci, Calogero; che aveva appreso, sempre
da Raffaele Ganci, che l’imputato avrebbe ad un certo punto espresso al capomandamento difficoltà
ad eseguire l’incarico, determinate dal fatto che il giudice era scortato e quindi non riusciva ad
assistere bene all’imbarco.
Avuto riguardo alla citata telefonata, Cancemi prima aveva affermato di aver intuito solo che
l’interlocutore fosse Sciarrabba, non ricevendo sul punto alcuna espressa conferma dal Ganci,
mentre poi aveva precisato che questi gli aveva espressamente detto di aver parlato con Sciarrabba,
specificando in ultimo, che, poiché la macelleria era grande, non aveva sentito fare alcun nome al
Ganci, ma aveva appreso poi, da questo, che l’interlocutore era il citato imputato. Tuttavia, secondo
Cancemi, Raffaele Ganci non avrebbe avuto nessuna conferma da Roma, quel 23 maggio, del fatto
che il giudice stava per partire da Roma.
Sulla vicenda Calogero Ganci aveva escluso che in sua presenza si fossero verificate telefonate fra
il padre e l’imputato, anzi aveva asserito che la lontananza di Sciarrabba era un bene per la famiglia
che così poteva mantenere il più stretto riserbo sugli affari più delicati.
Infine, Ferrante aveva rivelato le confidenze fattegli durante la codetenzione all’Asinara da
Domenico Ganci che non si spiegava le motivazioni che avevano spinto Cancemi a coinvolgere
nell’attentato Sbeglia e Sciarrabba, a suo giudizio estranei a tutta la vicenda.
Uguale sensazione di stupore la si ritrova nelle dichiarazioni di Calogero Ganci, che, riferendo sullo
stesso episodio citato da Ferrante, aveva fatto riferimento alla “Strage degli Innocenti”, dimostrando
ancora più stupore per via del fatto che Cancemi, oltre a coinvolgere ingiustamente Sbeglia e
Sciarrabba, avesse invece taciuto la partecipazione di Antonino Galliano ai pedinamenti.
In tale cornice si inserivano le dichiarazioni di Salvatore Cancemi, che aveva riferito sul ruolo
rivestito dall’imputato, indicato come colui che doveva seguire lo spostamento del dr Falcone
all’aeroporto, per riferirlo al gruppo che a Palermo doveva attivare i preparativi al ricevimento della
notizia della partenza.
Quel che non poteva farsi a meno di sottolineare era che la chiamata di correità del Cancemi era
intervenuta in un momento processuale in cui non erano ancora venuti a galla i pedinamenti della
Fiat Croma, realizzati dal gruppo dei Ganci e dallo stesso Cancemi, che ne aveva parlato solo dopo
che era divenuta di dominio pubblico la collaborazione di Calogero Ganci: prima di tale scelta
Cancemi era il solo imputato che, in quanto partecipe del gruppo operante in città, era unico
depositario di quanto era accaduto su tale versante.
La scelta di tacere sull’espediente dei pedinamenti della Fiat Croma comportava dunque che la
notizia che il dr Falcone stava per arrivare – secondo lo schema logico che il narratore doveva
seguire per essere credibile – doveva venire per forza di cose da Roma.
Orbene, la circostanza che il Cancemi avesse partecipato attivamente all’operazione, faceva sorgere
il dubbio che egli avesse coinvolto Sciarrabba per tacere di una parte dei preparativi che lo
vedevano protagonista in prima persona, nell’ottica di ridurre al minimo l’ammissione delle sue
responsabilità, senza perdere l’occasione di fornire al contempo una ricostruzione degli eventi
basata su un costrutto logico, in cui ogni passaggio aveva una sua razionalità.
Per contro, si rilevava che Francesco Paolo Anzelmo aveva riferito di aver appreso del
coinvolgimento di Sciarrabba, con il medesimo ruolo descritto dal Cancemi. Tale coincidenza allora
allontanava dal Cancemi lo spettro di una condotta, che se veritiera, andava ben oltre la
spregiudicatezza, ed, escluso ogni tipo di accordo preventivo sul punto fra Cancemi ed Anzelmo,
non derivabile da alcuna circostanza emersa processualmente, rimetteva in campo la possibilità di
una fondatezza dell’accusa mossa a Sciarrabba.
Tuttavia, le perplessità in ordine alle motivazioni che potrebbero aver indotto il Cancemi ad
accusare lo Sciarrabba, e soprattutto la genericità delle indicazioni fornite dallo stesso Cancemi e
dall’Anzelmo sull’attività svolta dall’imputato non consentivano di far ritenere accertato l’effettivo
contributo causale offerto dallo Sciarrabba nella realizzazione della strage.
Ed, invero, la condotta descritta dal Cancemi e dall’Anzelmo con riferimento allo Sciarrabba, non
era specifica, essendosi limitati essi a descrivere in modo generico un ruolo che agli effetti pratici
risultava un contenitore vuoto, sconoscendosi come si svolgevano i supposti pedinamenti e con
quali modalità l’imputato, che non abitava più a Roma, doveva segnalare al gruppo di Capaci la
partenza del giudice.
In definitiva, quello svolto da Sciarrabba era ritenuto un ruolo del tutto svincolato dai movimenti di
tutti gli altri soggetti che erano intervenuti nei preparativi e nel giorno della strage, non inseribile
quindi programmaticamente nel quadro degli interventi da realizzare e coordinare al fine della
realizzazione dell’evento stragistico. A causa dell’indeterminatezza della condotta dell’imputato che
emergeva dalle dichiarazioni dei collaboratori, si ritenevano non integrati i presupposti per la
realizzazione del reato di concorso in strage, che restava pertanto per Giusto Sciarrabba non definito
nei suoi connotati essenziali.
Conseguentemente il giudicabile veniva mandato assolto con la formula ritenuta di giustizia.
*
AGRIGENTO GIUSEPPE
L’organico inserimento dell’imputato nell’organizzazione mafiosa ritenuta responsabile della strage
di Capaci aveva trovato conforto nelle convergenti e plurime indicazioni dei collaboranti Francesco
Paolo Anzelmo (che aveva inserito l’Agrigento nella famiglia di San Cipirello con il rango di
soldato), Francesco Di Carlo, Gaspare Mutolo, Mario Santo Di Matteo, Gioacchino La Barbera e
Giovanni Brusca. Quest’ultimo, poi, lo aveva coinvolto nel sequestro del figlioletto del Di Matteo,
e, per quanto riguardava in particolare la strage, aveva dichiarato che era stato proprio Agrigento a
portare l’esplosivo in contrada Rebottone, preavvisando Di Matteo della visita al casolare che
sarebbe avvenuta intorno alla fine di aprile o ai primi di maggio del 1992.
Di Matteo aveva confermato la circostanza, pur non essendo chiarissimo sulla collocazione
temporale della visita; aveva altresì precisato che Agrigento era spesso in compagnia di Giovanni
Brusca, in ciò confortato da La Barbera, che lo aveva notato ad Altofonte mentre faceva visita a
Brusca che lì trascorreva la sua latitanza; che in virtù di tale legame, l’imputato doveva essere a
conoscenza dell’uso che si doveva fare dell’esplosivo che gli aveva consegnato; che proprio
l’Agrigento gli aveva reso noto che la sostanza che stavano travasando non era fertilizzante, per
come prima facie poteva apparire essendo contenuta in quattro sacchi di juta normalmente destinati
a tale scopo.
Ritenuta pertanto la penale responsabilità dell’Agrigento in ordine ai delitti detenzione di sostanze
esplosive, a diversa soluzione pervenivano i primi giudici in ordine al delitto di strage, non
ravvisandosi elementi dai quali desumere che l’imputato avesse consapevolezza della destinazione
dell’esplosivo da lui portato in contrada Rebottone e lì stesso travasato. Infatti, contrariamente a
tutti gli altri appartenenti del commando esecutivo, Agrigento non aveva preso parte a nessun’altra
attività, oltre a quella segnalata, tranne che per un episodio particolare, citato da Giovanni Brusca
relativo alla visita di un suo parente a nome Piediscalzi, richiesto di una consulenza sull’esplosivo.
Il colloquio però avvenne alla presenza del solo Rampulla e del Brusca, mentre l’Agrigento ne
rimase estraneo, sicché dal tenore delle dichiarazioni di Brusca, tale episodio non poteva essere
invocato per desumere elementi di prova a carico del giudicabile, a prescindere dal fatto che
nessuno degli altri collaboratori aveva narrato dell’episodio, né della visita di Agrigento, né tanto
meno di quella di Piediscalzi.
L’assenza dell’imputato da tutte le altre fasi di organizzazione dei preparativi dell’attentato, salvo
che per l’approvvigionamento ed il trasporto di parte dell’esplosivo, non consentiva di sostenere che
l’Agrigento era consapevole della sua destinazione, che non poteva desumersi né dalla stretta
vicinanza a Giovanni Brusca, e quindi dalla presunzione che egli dovesse necessariamente sapere
che il materiale serviva per riempire il cunicolo da far saltare al passaggio del dr Falcone, né dalla
cospicua quantità di esplosivo trasportato che ne avrebbe rivelato in modo inequivoco la
destinazione all’esecuzione di una strage.
Tuttavia, osservavano i primi giudici che, trattandosi di mere presunzioni sulla cui rilevanza non era
necessario soffermarsi oltre, l’accettazione di tale sillogismo avrebbe comportato l’aperta
violazione dei principi generali sulla responsabilità penale. Né potevano trarsi elementi di giudizio
sfavorevoli al giudicabile dall’ulteriore sillogismo, perché anche l’operazione di travaso dai sacchi
ai bidoni, cioè quella che maggiormente poteva essere indicativa della consapevolezza che questi
servissero per la strage, non aveva un significato univoco su cui poter fondare l’affermazione di
colpevolezza dell’Agrigento che non era lecito ricavare da mere presunzioni argomentative.
Pertanto, l’Agrigento veniva mandato assolto dal reato di strage e da quelli connessi con la formula
di giustizia, fermo restando, come si è già detto in precedenza, l’attribuibilità oggettiva e
psicologica dei reati relativi alla detenzione e al porto di esplosivi.
*
RAMPULLA PIETRO
L’organico inserimento in Cosa Nostra dell’imputato emergeva univocamente dalla dichiarazioni
dei collaboranti provenienti dall’area catanese, quali Malvagna, Pulvirenti, Calderone, che lo
avevano posto a capo della famiglia mafiosa di Caltagirone e lo avevano indicato quale soggetto
legato a Benedetto Santapaola. Inoltre, sull’appartenenza del Rampulla alle famiglie catanesi
avevano concordato Di Matteo, La Barbera e Cancemi e gli altri propalanti.
In particolare Ganci Calogero, riferendosi al Rampulla ne aveva parlato come soggetto
originariamente legato al mandamento di Mistretta, del quale Farinella era capomandamento, poi
trasferitosi nel catanese ove si era legato a Santapaola e a Giuseppe Madonia.
Sulla scia tracciata dalle indicazioni di Ganci si era inserito anche Brusca, che aveva riferito di aver
contattato proprio le famiglie catanesi per invitare Rampulla a Palermo per presentarlo a Salvatore
Riina nella riunione svoltasi in Via Margi Faraci, nell’appartamento di Girolamo Guddo.
La dimestichezza mostrata sin da giovane dall’imputato con le sostanze esplosive era frutto degli
anni di militanza nei movimenti della destra extraparlamentare, per come risultava dalle condanne
subite negli anni caldi della contestazione studentesca.
Il fatto dunque che l’imputato fosse persona pratica di esplosivi, e che tale circostanza costituisse
elemento di conoscenza diffuso fra gli appartenenti all’organizzazione criminosa, rendeva agevole
spiegare il motivo per cui Giovanni Brusca, che era in contatto con i gruppi catanesi per sua stessa
ammissione, ne avesse richiesto l’intervento, una volta appreso, nel corso del primo incontro con
Salvatore Riina, che era necessario trovare qualcuno che fosse pratico di esplosivi.
Conseguentemente, il riconoscimento di tale qualità, da parte di tutti gli altri imputati di reato
connesso che avevano partecipato alla fase dei preparativi dell’attentato era dato univoco.
Andava ascritta al Rampulla la realizzazione pratica di molte operazioni che richiedevano doti di
specializzazione, di cui tutti gli altri complici evidentemente non godevano. Pertanto erano state
svolte da lui personalmente o sotto la sua supervisione l’assemblaggio della ricevente e il
collegamento con la trasmittente; la sperimentazione della metodica empirica per saggiare
l’efficacia della trasmissione e di ricezione del segnale attraverso il collegamento dell’apparecchio
ricevente con le lampadine flash; la direzione dei lavori durante l’attività di travaso dell’esplosivo;
la scelta di confinare delle frazioni della carica sotto terra ricoperte dal letame; il collegamento del
detonatore alla ricevente perfezionato nel corso del caricamento del condotto; l’aiuto prestato a
Ferrante per il trasporto dei bidoni al condotto; e infine la partecipazione alle prove di velocità e la
presenza durante gli appostamenti.
Con riferimento alla partecipazione dell’imputato alla fase del caricamento ne andava sottolineata la
presenza non solo al materiale inserimento delle cariche nel condotto, ma anche per il tragitto dalla
villetta, ove si era svolto il travaso, al condotto insieme a Biondino, Troia e a Ferrante.
Tutti gli operatori presenti nel corso dei preparativi nel territorio di Capaci avevano concordato poi
sulla sua assenza il giorno del verificarsi della strage, sul pernottamento durante l’appostamento in
una casa e preliminarmente sull’episodio del tamponamento della sua auto.
Infine il coinvolgimento dell’imputato nella preparazione dell’attentato si ritraeva dall’esame del
traffico telefonico, da cui emergeva che Pietro Rampulla il 5 maggio del 1992 aveva contattato con
il suo cellulare (0337/463777) quello di La Barbera alle ore 17.36.
Pur non essendo possibile attribuire con precisione a tale contatto alcuna causale certa, quel che
certamente rilevava era la registrazione di un contatto telefonico fra due soggetti che,
apparentemente nessun tipo di rapporto potevano avere, appartenendo essi a realtà, dal punto di
vista territoriale, diametralmente opposte. Inoltre, avuto riguardo ai contatti telefonici, gli
accertamenti di p.g. effettuati evidenziavano la frequenza dei contatti del Rampulla con i familiari
che costituiva indice altamente verosimile del fatto che l’imputato si trovasse, nel periodo indicato,
fuori casa, ed era pertanto normale che avvertisse l’esigenza di dare sue notizie alla moglie.
Alla stregua di tali univoci elementi probatori, i primi giudici, ritenevano di poter affermare la
penale responsabilità del Rampulla in ordine al delitto di strage ed agli strumentali e connessi reati,
che risultavano integrati sia dal punto di vista materiale che psicologico e lo condannavano alla
pena dell’ergastolo. Invero, ciascuna delle diverse condotte poste in essere dal Rampulla, non solo
era di per sé autonomamente idonea a determinare il concorso nel reato di strage, ma lo era anche
per rendere manifesta la piena volontarietà in capo all’imputato del fatto criminoso a cui,
progressivamente, andava contribuendo con la sua condotta.
*
GRAVIANO GIUSEPPE
Ad avviso dei primi giudici era rimasta totalmente priva di riscontro l’accusa mossa da Giovan
Battista Ferrante nei confronti di Giuseppe Graviano, il quale avrebbe materialmente recapitato
nella villetta di Capaci l’altra parte di esplosivo contenuta nei sacchi di tela plastificata. Malgrado il
Ferrante avesse descritto l’evento in maniera particolarmente circostanziata, rivelando in via
preliminare da chi era venuto l’impulso ad attrezzarsi per ricevere il materiale (Salvatore Biondino),
chi in quel frangente lo avesse aiutato a caricare i sacchi (Biondo), quale la macchina era stata usata
da Giuseppe Graviano per portare l’esplosivo a Capaci, non era stato possibile identificare nessun
tipo di elemento in base al quale riconoscere a Graviano tale compito.
L’assunto proposto da Ferrante era destinato pertanto a rimanere allo stato indimostrato con ovvie
conseguenze sul piano probatorio.
GLI ESECUTORI MATERIALI DELLA STRAGE DI CAPACI
 capaci
capaci